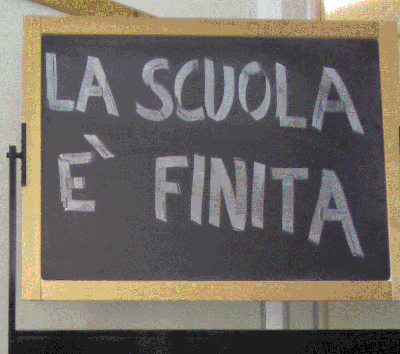 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Ci sono voluti due anni ma alla fine l’ormai famigerata riforma Gelmini è arrivata a toccare anche gli atenei. Un percorso lento, incidentato dalla rumorosa protesta degli studenti e dei precari dell’istruzione, ma che grazie alla pazienza della sua firmataria ed alla fortissima pressione di Confindustria, ha finalmente raggiunto l’approdo della promulgazione. Lo scorso giovedì, infatti, un Senato in balia della querelle interna al Pdl ha approvato il testo scritto a quattro mani con il ministro Brunetta con 152 voti favorevoli, 94 contrari e un astenuto. Fondamentali all’approvazione sono stati i si portati in dote dall’API (Alleanza Per l’Italia), la nuova formazione centrista capitanata da quello stesso Francesco Rutelli che negli anni ‘70 battagliava per la libertà dei saperi e per l’emancipazione della cultura dal dio denaro: ça va sans dire.
Se da una parte quindi si plaude alla tenacia e alla lungimiranza della ministra, dall’altra si lista a lutto l’autonomia che, nel bene e nel male, ha sempre caratterizzato l’istruzione superiore italiana: in nome del risparmio, infatti, le risorse verranno pesantemente tagliate e i consigli di amministrazione degli atenei verranno implementati dalla presenza di rappresentanti del “capitale”. Questi ultimi promettono di investire nella ricerca, sollevando così lo Stato dal peso dei contributi; ma sono in molti a leggere queste nuove dinamiche nell’ottica di un impoverimento dei saperi e delle competenze che verranno fisiologicamente inficiate dalle esigenze economiche delle aziende.
Per la ministra è tutto oro che cola: “L'università sarà più meritocratica, trasparente, competitiva e internazionale. Il ddl segna la fine delle vecchie logiche corporative: sarà premiato solo chi se lo merita. L'approvazione di questo provvedimento costituisce la base per il rilancio del sistema universitario italiano, finalmente si potrà competere con le grandi realta' internazionali”.
Ma andiamo a vedere quali saranno questi cambiamenti “epocali”. In primis, dicevamo, l’autonomia: con la riforma, l’assunto tutelato dall’articolo 33 della Costituzione - “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”- verrà appunto accantonato. La nuova legge di Stato prevede, infatti, un’intromissione ben poco felpata nell’organizzazione e nell’ordinamento dei singoli atenei: si ridefiniscono integralmente ruoli e funzioni degli organi universitari (rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, ecc.); si fissa il limite del numero di mandati del rettore (due) e la durata massima dell’incarico (otto anni complessivi); sono previste ipotesi di incompatibilità e si ridefinisce integralmente l’articolazione interna delle università, sopprimendo le facoltà e creando macro-dipartimenti che dovranno svolgere sia le attività inerenti alla ricerca che quelle relative alla didattica.
Una rivoluzione in tutti i sensi, che lega a doppio filo le decisioni degli organi accademici ai diktat di un bilancio disastrato e di un altrettanto disastrato tesoriere (non importa chi, i conti italiani saranno sempre e comunque in rosso). E’ infatti la sola logica del risparmio a muovere le scelte dei legislatori: non c’è nulla di razionale nel voler disarticolare le facoltà - già di per sé più che oberate dalla mole di lavoro e dall’ordinaria amministrazione - per agglomerarle in grandi dipartimenti, in onere di provvedere praticamente a tutto.
 Se infatti si pensa che la divisione delle strutture è una conditio sine qua non per l’efficienza e l’efficacia delle attività didattiche, ben si comprenderà come dietro alla suddetta volontà di ottimizzazione stia in realtà solo l’imperativo del taglio, della riduzione del personale.
Se infatti si pensa che la divisione delle strutture è una conditio sine qua non per l’efficienza e l’efficacia delle attività didattiche, ben si comprenderà come dietro alla suddetta volontà di ottimizzazione stia in realtà solo l’imperativo del taglio, della riduzione del personale.
E qui si arriva al secondo punto fondamentale di questa “epocale riforma”, ovvero la celebrazione del precariato più spinto. Scompare la figura del ricercatore a tempo indeterminato: l’articolo 12 del testo prevede infatti la infatti, che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università potranno stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Le nuove leve saranno selezionate mediante procedure pubbliche riservate ai soli possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.
Questi contratti, che altro non sono se non una farsa, avranno durata triennale e potranno essere rinnovati soltanto per una volta. Se alla scadenza del termine complessivo di sei anni i ricercatori non avranno conseguito l’idoneità di professore associato e non verranno chiamati da alcuna università, dovranno tornarsene mesti a casa, facendo mea culpa per la loro “improduttività”.
In tutto ciò una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto l’Onda? La stessa Onda che nell’autunno caldo del 2008 minacciò le barricate se la legge 133 avesse trovato riscontro nella pratica legislativa? Non pervenuta. Le ferie di agosto sono ferie anche per i rivoluzionari e i ribelli e, ad ora, le poche reazioni suscitate dalla notizia dell’approvazione della riforma Gelmini sono calendarizzate per settembre.