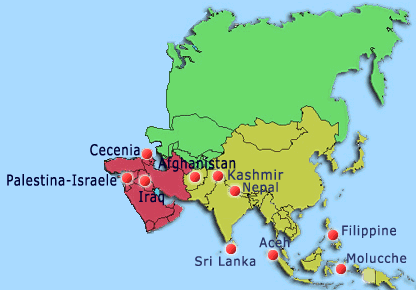 Freddi, caldi, congelati, esplosivi, annunciati, insoluti. Sono le definizioni che vengono fuori quando si parla di conflitti (attuali o secolari) sui quali si giocano, spesso, le sorti del mondo. E l’Asia, in questo contesto, è il continente a rischi maggiori. Le notizie che arrivano sono sempre più allarmanti perchè gli scontri in atto - in un crocevia di traffici di tutti i tipi - potrebbero trasformarsi in aperta guerre di secessione evidenziando le divisioni geopolitiche delle sfere di influenza. Sul tavolo dei maggiori conflitti asiatici sono più che mai aperti quelli che si verificano in Israele (un paese che continua la sua lotta armata contro la Palestina senza rispettare le leggi dell’Onu e le proteste della comunità internazionale) e in Iraq dove l’occupazione americana provoca ogni giorno di più danni epocali. E sullo sfondo - dove risalta anche il conflitto interno al Pakistan segnato dall’arroganza del generale Musharraf - si evidenzia sempre più il conflitto con la Turchia che vede i curdi sviluppare la loro lotta per ottenere un proprio territorio nazionale.
Ecco l’Afghanistan, dove è guerra senza fine con i Taliban che prendono sempre più potere e con gli americani che insistono con il loro massiccio intervento appoggiati anche da forze internazionali (Italia compresa). Il Paese intanto si trova in una condizione di grave instabilità politica e crisi umanitaria. La problematica creazione di istituzioni democratiche e l’ancor più difficile consolidamento del ruolo di queste al di fuori della capitale e dei principali centri urbani, sono direttamente collegati al persistere di forme di potere politico basato sulla forza armata, sull proliferare di attivit? illegali, tra le quali spicca il narcotraffico di oppiacei, ed sull’incremento delle azioni di guerriglia del riorganizzatosi movimento Taliban contro il governo, le truppe della Nato e le organizzazioni internazionali. A ciò si somma la miriade di emergenze croniche che affliggono una società per noi ignota e lontana, sconvolta da un quarto di secolo di guerra.
Freddi, caldi, congelati, esplosivi, annunciati, insoluti. Sono le definizioni che vengono fuori quando si parla di conflitti (attuali o secolari) sui quali si giocano, spesso, le sorti del mondo. E l’Asia, in questo contesto, è il continente a rischi maggiori. Le notizie che arrivano sono sempre più allarmanti perchè gli scontri in atto - in un crocevia di traffici di tutti i tipi - potrebbero trasformarsi in aperta guerre di secessione evidenziando le divisioni geopolitiche delle sfere di influenza. Sul tavolo dei maggiori conflitti asiatici sono più che mai aperti quelli che si verificano in Israele (un paese che continua la sua lotta armata contro la Palestina senza rispettare le leggi dell’Onu e le proteste della comunità internazionale) e in Iraq dove l’occupazione americana provoca ogni giorno di più danni epocali. E sullo sfondo - dove risalta anche il conflitto interno al Pakistan segnato dall’arroganza del generale Musharraf - si evidenzia sempre più il conflitto con la Turchia che vede i curdi sviluppare la loro lotta per ottenere un proprio territorio nazionale.
Ecco l’Afghanistan, dove è guerra senza fine con i Taliban che prendono sempre più potere e con gli americani che insistono con il loro massiccio intervento appoggiati anche da forze internazionali (Italia compresa). Il Paese intanto si trova in una condizione di grave instabilità politica e crisi umanitaria. La problematica creazione di istituzioni democratiche e l’ancor più difficile consolidamento del ruolo di queste al di fuori della capitale e dei principali centri urbani, sono direttamente collegati al persistere di forme di potere politico basato sulla forza armata, sull proliferare di attivit? illegali, tra le quali spicca il narcotraffico di oppiacei, ed sull’incremento delle azioni di guerriglia del riorganizzatosi movimento Taliban contro il governo, le truppe della Nato e le organizzazioni internazionali. A ciò si somma la miriade di emergenze croniche che affliggono una società per noi ignota e lontana, sconvolta da un quarto di secolo di guerra.
Altra area di conflitti congelati è oggi più che mai quella dell’Arabia Saudit. Qui i problemi di sicurezza interni risalgono al 1995 quando si registrarono i primi accenni dello scontro fra gruppi jihadisti ed autorità che minacciavano la legittimità della famiglia reale a governare e la sicurezza nella penisola. L’attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001 ha mostrato, inoltre, che le tensioni interne all’Arabia Saudita possono avere delle importanti conseguenze internazionali tanto che nel mondo si è messo subito in evidenza che 15 dei 19 attentatori suicidi erano di nazionalit? saudita...
Anche il Bangla Desh - pur se segnato da una lenta e profonda trasformazione - è sempre un punto caldo a partire da quel 1947 quando India e Pakistan ottennero l'indipendenza ed iniziò la separazione di musulmani e induisti in due stati: i primi migrarono verso il Pakistan, i secondi alla volta dell'India. Il territorio dell’attuale Bangladesh, a maggioranza musulmana, venne così assegnato al Pakistan come provincia orientale separata ed assunse il nome di Pakistan Orientale. Ma nel 1970 una politica estera aggressiva e autoritaria ece sorgere in Bangladesh rivendicazioni indipendentistiche che, dopo una repressione sanguinosa da parte del governo pakistano, sfociarono in una vera e propria guerra civile. Nel dicembre 1971, quando venne proclamata ufficialmente l'indipendenza dal Pakistan, il nome del nuovo paese divenne Bangladesh. E quando nel 1982 salì al potere il generale Hossain Mohammed Hershad, gli scontri tra musulmani ed indu e tra nazionalisti e progressisti portarono il paese sull'orlo di una nuova guerra civile. Venne introdotto nelle scuole l’insegnamento obbligatorio del Corano e della lingua araba. E nel 1988 l’Islam venne dichiarata religione di Stato. Attualmente il Bangladesh indipendente sembra avere ereditato tutte le debolezze strutturali accumulate nel corso del Novecento aggravate da un processo di decolonizzazione particolarmente problematico. Si aggiunge il Myanmar (Birmania) sconvolto dalla cosiddetta “Rivoluzione zafferano” alimentata dai monaci buddisti e sostenuta da forze occidentali interessate alla destabilizzazione dell’area.
Ma il paese più a rischio quanto a conflitti freddi è, in questo momento, la Cina che, comunque, cerca di fare del tutto per contenere spinte e proteste interessata come è al successo delle prossime Olimpiadi. Pechino, intanto, allontana sempre più quel lungo e complesso periodo che ha segnato il suo rapporto di amore-odio con Mosca. Ma il ricordo dei contrasti ideologici nel periodo di Mao - pur se archiviati - restano fermi nella memoria insieme all’ombra di quell’isola di Damanskij dove, nel marzo 1969, si svolsero scontri armati tra i soldati cinesi e russi. Come ha detto recentemente il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, “per la prima volta le relazioni bilaterali fra la Cina e la Russia non sono influenzate negativamente da un contenzioso sulla frontiera”.
Comunque sia la risoluzione del contenzioso è passata attraverso una cessione territoriale poco significativa per estensione geografica, ma che viene vista dai russi come una perdita di prestigio nei confronti della sempre più imponente potenza cinese. C’è, in tal senso, un accordo fra i due Paesi che è stato ratificato dalla Duma di Mosca e che riguarda appena il 2 per cento della frontiera terrestre di 4.300 chilometri che separa i due Paesi – la più lunga del mondo – che è stata solo ora demarcata in modo definitivo. Questo ha comportato la cessione dell’interezza dell’isola Tarabarov, alla confluenza dei fiumi Amur e Ussuri, e parte delle limitrofe isole Bolshoi Ussuriisky, a qualche minuto di ferry dalla citt? di Khabarovsk, nonchè metà dell’isola Bolshoi, sul fiume Argun, che separa la regione cinese della Mongolia interna dalla zona russa di Chita, nella Siberia orientale. Per tranquillizzare i russi l’esponente della diplomazia del Cremlino ha poi sottolineato che si tratta di un “trasferimento” e non di una “cessione” di terreni, e che nessun interesse economico russo passerà in mani cinesi.
Nondimeno, ora Tarabarov sarà ufficialmente chiamata Yinlong, e metà della Bolshoi Ussuriisky sarà Heixiazi, come preferiscono i cinesi, cosa che mette fine a una disputa che si protraeva dall’epoca in cui l’impero zarista e quello mancese dei Qing (l’ultima dinastia imperiale ad aver governato la Cina, decaduta nel 1911) avevano esteso i rispettivi confini fino a toccarsi. Alla fine degli anni Sessanta, ai tempi della glaciale rottura sinosovietica, i due Paesi erano stati sull’orlo di una guerra di frontiera, tanto per attriti di natura ideologica, che per la propriet? di queste isolette. L’equilibrio gopolitico e geoeconomico porta ora Pechino a rinunciare alla rivendicazione di tutte le isole intorno a Khabarovsk e ad accettare il compromesso russo di ricevere solo metà dell’isola Bolshoi, ritrovandosi pur sempre con in mano 337 chilometri quadrati di territorio in più.
Un serio problema interno per il governo di Pechino, riemerso all’attenzione internazionale con le proteste dei monaci e la repressione cinese della scorsa settimana, è quello del rapporto con il Tibet (centro del buddhismo-lamaismo), che rappresenta, nella realtà cinese, una enclave geografico-culturale. Ultimo esempio sopravvissuto di teocrazia, il Tibet - nel tentativo di blindare il suo potere - tiene viva la propria tradizione anche dopo l’integrazione da parte della Cina (1951) e una serie di riforme radicali, il cui rapido ritmo ha sempre provocato una diffusa opposizione, sfociando anche nel tentativo di rivolta del 1959, in seguito al fallimento del quale il Dalai-Lama si rifugiò in India. La posizione costituzionale del Tibet nell'ambito della repubblica cinese venne poi sistemata - in una fase gravida di incertezze - con la creazione della regione autonoma tibetana (1965) e, da allora, il governo di Pechino respinge fermamente ogni fermento indipendentistico.
Continuano intanto proteste e scontri nella contesta regione dove migliaia di tibetani manifestano contro la Cina nell’ultimo anniversario della rivolta di Lhasa. Da Dharamsala, la piccola città sull’Himalaya indiano dove il Dalai Lama vive in esilio da quando fuggì in India, cento esuli sono ora partiti dando vita a quella che chiamano la «marcia del ritorno», che dovrebbe concludersi col loro rientro in Tibet l’8 agosto prossimo, il giorno nel quale si apriranno i Giochi di Pechino. Il potere mostra di essere preoccupato per la situazione nella regione del Xinjiang che include buona parte del settore nordoccidentale (1,66 milioni di chilometri quadrati) dove si registrano i movimenti indipendentisti degli uiguri (17 milioni di fede musulmana). In queste zone è forte l’influenza verso un processo di separazione da Pechino soprattutto dopo la disgregazione dell’Urss che ha avuto ampi riflessi nel Kasachstan e nella Kirghisia, paesi turcofoni e musulmani. La migrazione, incentivata dal centro, di cinesi da altre regioni ha accresciuto il malcontento degli uiguri preoccupati di essere presto sopraffatti dal punto di vista demografico. D’altra parte non sono solo ideali politici a mantenere lo Xinjiang sotto stretta sorveglianza. In gioco vi sono anche concreti interessi economici (in particolare sugli ingenti giacimenti di gas e altre materie prime il cui sfruttamento è solo all’inizio) e le nuove vie di comunicazione aperte lungo le rotte transfrontaliere con il Kasachstan e l’Asia centrale, che dovranno avere, nelle intenzioni di Pechino, un ruolo strategico.
Ma la vita politica della Cina è anche segnata dagli “attriti” con il vicino Vietnam, sfociati in guerra aperta nel 1979 e successivamente in vari incidenti di frontiera.
Per quanto riguarda poi le contestazioni internazionali nei riguardi delle risorse energetiche la Cina ha chiarito - una volta per tutte - che il perimetro delle sue rivendicazioni marittime va dalle Senkaku (Diaoyu) a Natuna (esclusa). Chiunque si azzardasse a pescare idrocarburi in quest’area - avvertono i cinesi - ne pagherebbe le conseguenze.
Rapporti difficili e sempre tesi sono poi quelli tra Pechino e Taiwan aggravati dal fatto che il governo locale ha appoggiato - con una dichiarazione del ministero degli Esteri del febbraio 2008 - la secessione del Kosovo affermando, che “l’autodeterminazione è un diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite ed è il popolo da essere il padrone del futuro della propria nazione”. Taiwan – considerata un’isola “ribelle” dalla Cina popolare - ha provato decine di volte a farsi riconoscere dall’Onu, ma ha sempre trovato ostacoli in Pechino e i suoi alleati. “In nessun modo – è detto nella dichiarazione taiwanese – l’indipendenza di una nazione dovrebbe essere negata da un’altra”.
Ai confini della Cina si evidenzia poi l’annosa questione delle due Coree. Qui c’è quel tristemente noto 38mo parallelo che segna la divisione tra le due realtà. Si tratta di un “muro” che ostacola contatti reali e processi distensivi. Gli ultimi anni parlano di un riavvicinamento della Corea del Nord sia con il Giappone che con la parte sud della penisola nonostante gli incidenti del 2002, quando diverse navi della Corea del nord entrarono nelle acque della Corea del sud aprendo il fuoco. Ecco le Filippine agitate dalle rivendicazioni del Milf (Moro Islamic Liberation Front), che recentemente ha dichiarato che la mossa del Kosovo “rompe un tabù” nelle regole non scritte delle Nazioni Unite, che salvaguardano l’integrità degli Stati riconosciuti. Il Milf, dopo anni di lotta per l’indipendenza di Mindanao, ha accettato di aprire il dialogo con il governo, mettendo da parte mire indipendentiste e chiedendo solo autonomia amministrativa per la regione sud.
Altra storia di conflitti arriva dal Giappone. Con Tokio che mantiene sempre un contenzioso caratterizzato da intese sul filo della realpolitik. E’ aperta, infatti, con la Russia quella pagina relativa a quattro isole che compongono l'arcipelago meridionale delle Kurili, un tempo comprese nel Giappone e poi occupate dall’Urss nel corso della seconda guerra mondiale. Aree tutte della regione di Sachalin e sempre definite, nel linguaggio geopolitico di Tokio, come “Territori del nord”. C’è stata in proposito una recente presa di posizione del ministro degli Esteri giapponese Taro Asso che - nel corso di una seduta della commissione parlamentare per gli affari esteri giapponese svoltasi a Tokio - ha sostenuto che Russia e Giappone devono spartirsi in metà eguali le quattro isole che compongono l'arcipelago meridionale delle Kurili.
Da parte sua la Russia propone di risolvere la questione sulla base della dichiarazione nippo-sovietica del 1956, secondo la quale l'Unione Sovietica, a seguito della firma del trattato di pace, si impegnava a trasmettere al Giappone deliberatamente due delle isole contestate: esattamente quelle chiamate rispettivamente Sikotan e Habomai. Ma nello stesso tempo il Cremlino sa bene che tale soluzione non verrebbe accettata dalla maggior parte dei cittadini russi, il 73% dei quali, secondo un recente sondaggio, ritiene che le Kurili facciano parte integrante della giurisdizione territoriale della Federazione Russa. Il problema ora è quello della collocazione geopolitica di questo arcipelago del Pacifico conteso tra due paesi. Con il Cremlino che per porre un rimedio ai tanti problemi dell’area cerca di creare una zona franca come polo di sviluppo per l’Estremo Oriente.
E’ chiaro - per i politologi di Mosca - che una concezione realista dei rapporti tra economia e politica nell’intera regione presuppone anche una griglia teorica in grado di dar conto di quelli che sono i caratteri distintivi della fase più recente dell'ordine economico internazionale. In particolare vanno considerati l'emergere di un nuovo centro - già in rapida evoluzione - costituito dall'area del Pacifico (Giappone e paesi asiatici di nuova industrializzazione) e la crescente interdipendenza dell'economia americana e di quella giapponese. Ma è anche vero che malgrado il contenzioso sulle Kurili, Mosca pare disposta a privilegiare il rapporto energetico col Giappone per costruire insieme un contrappeso alla spinta della Cina nel Nord-Est asiatico.
Ora, se per il Giappone il problema è quello di possibili riconquiste territoriali, per l’India i problemi sono di ben altra portata. C’è sullo sfondo la crisi tra Cina e Pakistan che soffiano sul fuoco del rapporto con Nagaland, Manipur e Tripura. Attualmente sono attivi in queste aree più di 40 gruppi di vario peso e dimensioni, ma non tutti possono essere definiti come organizzazioni eversive o ribelli. Alcuni sono in realtà semplici associazioni criminali, altri gruppi svolgono invece funzioni di «polizia morale». In molti casi, la loro lotta per l’”indipendenza” si risolve in un accordo per una ”autonomia” o in benefici finanziari per i loro capi. Resta viva però l’eventualità di una possibile scintilla capace di provocare un conflitto aperto.
Venti di rivolta per processi di indipendenza arrivano intanto dall’Indonesia dove i gruppi islamici festeggiano la proclamata indipendenza dei kosovari musulmani. Ed è in questo contesto di azioni indipendentiste che a Papua si sta conducendo una campagna per staccare questa remota provincia orientale dall'Indonesia. Qui, nella provincia di Aceh, gli scontri hanno fatto 15.000 morti. Infine in questo nostro riassunto di conflitti c’è anche quello in atto nello Sri Lanka. Un paese dove, a partire dal 1983, i guerriglieri separatisti tamil delle Tigri per la Liberazione della Patria (Ltte) lottano contro il governo controllato dalla maggioranza cingalese e inizialmente sostenuto dall'esercito indiano. Le stime più attendibili parlano di un conflitto per l’egemonia che ha già fatto 68 mila morti. E come conseguenza il cessate il fuoco del 2002 è sepolto sotto le bombe.
Ed ecco, quindi, che anche dall’Asia arriva un preciso segnale d’allarme. Perchè la cosiddetta “sepoltura della guerra fredda” - una tesi, questa, tanto propagandata dai media che si riconoscono nella politica dell’imperialismo mondiale - non ha posto fine a nessun equilibrio. C’è nel continente una crisi delle comunità nazionali e politiche, sfidate e messe in difficoltà dall’emergere degli interessi delle grandi potenze, dall’etnicismo e da ciò che spesso è percepito come la rivincita delle microcomunità tribali, familiari o di clan. Il “grande gioco”, quindi, è sempre in atto con i suoi aspetti regionalistici e le numerose contrapposizioni venate di rivalità che conducono a conflitti mortali all’interno di ciascuno stato.