- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Le elezioni speciali andate in scena domenica scorsa in Myanmar per l’assegnazione di alcune decine di seggi parlamentari, secondo i dati non ufficiali hanno premiato largamente la Lega Nazionale per la Democrazia (LND) di Aung San Suu Kyi. La stessa icona della lotta democratica nella ex Birmania avrà la possibilità di entrare nella Camera bassa dell’Assemblea legislativa a fianco dei rappresentanti di una giunta militare contro cui, fino a pochi mesi fa, ha combattuto strenuamente e che l’ha privata della libertà per la maggior parte degli ultimi due decenni.
Anche se per i risultati definitivi sarà necessario attendere ancora qualche giorno, già poco dopo la chiusura delle urne la stessa LND aveva annunciato il successo in almeno 43 dei 44 seggi per i quali aveva presentato propri candidati. Lunedì, poi, anche i media del regime hanno confermato sostanzialmente questi dati, assegnando 40 seggi all’LND, mentre negli altri cinque i risultati sarebbero ancora incerti.
Nelle elezioni suppletive di domenica erano in palio 45 seggi, vale a dire circa il 7% dei 664 totali che compongono i due rami del parlamento birmano. I candidati della Lega Nazionale per la Democrazia avrebbero prevalso anche in quattro distretti della capitale, Naypyidaw, dove vivono soprattutto militari e impiegati ministeriali. Aung San Suu Kyi ha trionfato invece nel distretto rurale di Kawhmu a sud della città principale, Yangon, e per lei ora si parla addirittura di un possibile incarico ministeriale.
Per la prima volta dal 1990, quando l’LND vinse a valanga le elezioni ma i militari impedirono a San Suu Kyi di formare un governo, in questi giorni migliaia di persone sono scese nelle strade per festeggiare l’esito di un voto, mostrando a tutto il mondo il fortissimo desiderio di cambiamento diffuso nel paese dopo cinque decenni di dittatura.
Il voto è stato seguito dai commenti positivi dei governi occidentali. Una nota ufficiale della Casa Bianca, ad esempio, ha definito la tornata elettorale “un passo importante nella trasformazione democratica della Birmania”. La numero uno della diplomazia europea, Catherine Ashton si è a sua volta congratulata con il governo e il popolo del Myanmar per le modalità con cui si sono svolte le elezioni.
Alla vigilia del voto, San Suu Kyi e i portavoce del suo partito avevano denunciato intimidazioni ai danni dei loro sostenitori, mentre domenica sono stati segnalate alcune decine di brogli. Queste pratiche, tuttavia, risultano insignificanti per gli standard del Myanmar e non sono state coordinate con i vertici del regime, poiché è stato proprio quest’ultimo a volere l’ingresso del premio Nobel per la Pace birmano e dell’LND nella vita politica del paese in risposta alle richieste dell’Occidente per aprire un percorso di riconciliazione. Per la prima volta, così, il voto è stato monitorato da varie delegazioni di osservatori stranieri, tra cui quelle inviate dall’ASEAN (Associazione delle Nazioni dell’Asia Sud-Orientale), dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea.
 Secondo la tesi sostenuta dai principali media occidentali, il voto di tre giorni fa in Myanmar e la partecipazione dell’LND sono solo le più recenti di una serie di riforme intraprese dal regime per allentare il controllo totalitario sulla vita politica e l’economia del paese. Il processo di transizione era iniziato con le elezioni farsa del 2010 - boicottate dall’LND che fu perciò costretta a sciogliersi - in seguito alle quali la giunta militare ha ceduto il potere ad un governo nominalmente civile.
Secondo la tesi sostenuta dai principali media occidentali, il voto di tre giorni fa in Myanmar e la partecipazione dell’LND sono solo le più recenti di una serie di riforme intraprese dal regime per allentare il controllo totalitario sulla vita politica e l’economia del paese. Il processo di transizione era iniziato con le elezioni farsa del 2010 - boicottate dall’LND che fu perciò costretta a sciogliersi - in seguito alle quali la giunta militare ha ceduto il potere ad un governo nominalmente civile.
Sotto la guida del nuovo presidente, nonché ex primo ministro, generale Thein Sein, sono stati poi liberati centinaia di prigionieri politici, eliminate alcune restrizioni alla libertà di stampa e, soprattutto, adottate misure per aprire il paese del sud-est asiatico alla penetrazione del capitale estero. Come ha ricordato il Wall Street Journal, solo pochi giorni fa il governo birmano si era mosso per liberalizzare il cambio della valuta nazionale (kyat), in precedenza tenuta ad un livello artificialmente alto. Il provvedimento contribuirà ad attrarre maggiori investimenti esteri da compagnie impazienti di fare affari in un paese autoritario dove sarà disponibile una vasta manodopera a basso costo.
Le cosiddette riforme democratiche in corso in Myanmar, a ben vedere, rispondono piuttosto ad un disegno del regime per svincolarsi dalla dipendenza pressoché esclusiva dalla Cina, soprattutto in ambito economico, riequilibrando la propria politica estera grazie ad un certo riavvicinamento all’Occidente.
La Cina, oltre ad avere preso frequentemente le parti della giunta militare in ambito internazionale, ha investito massicciamente in progetti di sviluppo nella ex Birmania, così da assicurarsi un rapporto privilegiato con un paese che dispone di importanti risorse naturali e che, soprattutto, è situato in una posizione strategica per gli interessi di Pechino. Affacciato sull’Oceano Indiano, il Myanmar costituisce infatti un punto di transito fondamentale per le importazioni energetiche cinesi dal Medio Oriente, consentendo di evitare la rotta obbligata che passa attraverso lo Stretto di Malacca, potenzialmente a rischio di blocco da parte dei militari statunitensi di stanza nell’area in caso di crisi.
La possibilità di limitare l’espansione dell’influenza cinese nella regione, assieme alla prospettiva di aprire un nuovo mercato per il proprio business, ha convinto l’Occidente a raccogliere i segnali di disponibilità provenienti dal Myanmar. Prima di aprire un qualche dialogo era però necessario ottenere qualcosa in cambio per convincere l’opinione pubblica internazionale della serietà del processo di trasformazione democratica intrapreso dal regime.
In quest’ottica è stata fondamentale la riabilitazione di Aung San Suu Kyi la quale, rappresentando quei settori filo-occidentali della borghesia birmana emarginati dal regime militare e desiderosi di beneficiare dell’apertura del paese agli investimenti esteri, si è dimostrata pronta a raccogliere l’invito del nuovo governo e a partecipare alla competizione elettorale di domenica scorsa.
Dopo le prime “riforme” di questi mesi, il dibattito in Occidente sul Myanmar si sposterà con ogni probabilità nelle prossime settimana sull’opportunità di eliminare le sanzioni economiche e commerciali che vari paesi (USA, UE, Australia e Canada) hanno applicato negli anni scorsi a causa delle regolari violazioni dei diritti umani da parte della giunta militare.
L’Unione Europea, secondo fonti citate lunedì dal Wall Street Journal, dovrebbe discutere delle sanzioni in un meeting in programma il 23 aprile. All’ordine del giorno potrebbe esserci la soppressione di alcune limitazioni minori agli scambi commerciali con il Myanmar, mentre ancora lontana rimane la cancellazione di tutte le sanzioni, così come dell’embargo sulla vendita di armi.
 Il risultato del voto di domenica, secondo alcuni commentatori, avrebbe generato un certo panico tra i vertici del regime in vista del voto per il rinnovo dell’intero Parlamento nel 2015. In realtà, il regime è ben consapevole del malcontento che pervade la popolazione e si aspettava un voto molto positivo per il partito di Aung San Suu Kyi. Le divisioni all’interno dell’élite di potere circa la direzione intrapresa dal governo, in ogni caso, è probabile che esistano, anche se sembrano riguardare più che altro l’opportunità di sganciarsi da una Cina che continuerà comunque ad avere un ruolo di spicco nella vita del paese per scommettere sul riavvicinamento agli Stati Uniti e ai loro alleati.
Il risultato del voto di domenica, secondo alcuni commentatori, avrebbe generato un certo panico tra i vertici del regime in vista del voto per il rinnovo dell’intero Parlamento nel 2015. In realtà, il regime è ben consapevole del malcontento che pervade la popolazione e si aspettava un voto molto positivo per il partito di Aung San Suu Kyi. Le divisioni all’interno dell’élite di potere circa la direzione intrapresa dal governo, in ogni caso, è probabile che esistano, anche se sembrano riguardare più che altro l’opportunità di sganciarsi da una Cina che continuerà comunque ad avere un ruolo di spicco nella vita del paese per scommettere sul riavvicinamento agli Stati Uniti e ai loro alleati.
Un dilemma simile travaglia d’altra parte le classi dirigenti di quasi tutti i paesi del sud-est asiatico, i quali si trovano a fare i conti con una dipendenza economica sempre più marcata con Pechino e le pressioni o i legami politici e militari tradizionalmente coltivati con Washington in un frangente storico che vede il ritorno prepotente degli USA in Estremo Oriente in funzione anti-cinese.
Per quanto riguarda il Myanmar, infine, nonostante sia innegabile una certa apertura del paese, i cambiamenti di questi mesi sono in gran parte di facciata. Il partito politico espressione della ex giunta militare (Partito Unione Solidarietà e Sviluppo, USDP), infatti, detiene tuttora il monopolio del potere, così che il ruolo dell’LND di San Suu Kyi sarà tutt’al più quello di mediare tra il regime e l’Occidente. Repressione e violazioni dei diritti umani continuano inoltre ad essere documentate quotidianamente, soprattutto nelle regioni settentrionali popolate da inquiete minoranze etniche che da decenni si battono contro il governo centrale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il secondo summit dei cosiddetti “Amici della Siria” è andato in scena domenica scorsa a Istanbul, dove, sotto la guida degli Stati Uniti, si sono riuniti i rappresentanti di oltre 70 paesi per intensificare l’opera di destabilizzazione ai danni del regime di Bashar al-Assad. Il vertice, dopo quello organizzato a febbraio in Tunisia, è giunto a pochi giorni dall’accettazione anche da parte di Damasco del piano di pace dell’ex segretario generale dell’ONU, Kofi Annan, apparso proprio ieri di fronte al Consiglio di Sicurezza per fare il punto della situazione nel paese mediorientale.
Il piano di Annan era stato approvato da Russia e Cina dopo lo stralcio della richiesta esplicita delle dimissioni di Assad e l’inclusione di un appello rivolto anche ai “ribelli” armati a fermare le ostilità. Per Mosca e Pechino, l’appoggio alla missione sponsorizzata dall’ONU e dalla Lega Araba appare come il tentativo di risolvere la crisi in Siria con mezzi diplomatici, così da tenere in vita un alleato fondamentale per i loro interessi nella regione.
Come ha chiarito la stessa conferenza di Istanbul, tuttavia, gli Stati Uniti, i governi europei, la Turchia e le monarchie assolute del Golfo Persico intendono utilizzare il piano Annan come hanno già fatto con le precedenti iniziative diplomatiche, a cominciare dalla missione degli osservatori della Lega Araba fatta naufragare da Arabia Saudita e Qatar, cioè unicamente come arma per esercitare ulteriori pressioni sul regime fino alla sua caduta.
In quest’ottica, qualsiasi gesto o apertura da parte del presidente siriano non sarà comunque sufficiente, poiché l’obiettivo unico degli USA e dei loro alleati rimane il cambio di regime a Damasco, senza nessuno scrupolo per le possibili conseguenze di un intervento militare esterno, per l’appoggio dato ad un’opposizione dalla dubbia popolarità nel paese o per l’esplosione delle violenze settarie che si stanno pericolosamente alimentando nel paese.
A conferma di ciò, le dichiarazioni uscite dal vertice di Istanbul sono state puntualmente all’insegna delle minacce. Il premier turco, Recep Tayyp Erdogan, ha ad esempio affermato che “se il regime siriano non collaborerà con Annan, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dovrà adempiere alle proprie responsabilità per mettere fine al massacro”. Per il padrone di casa della conferenza, inoltre, “se il Consiglio di Sicurezza dovesse nuovamente sfuggire a questa responsabilità storica, la comunità internazionale non avrà altra scelta che appoggiare il diritto all’auto-difesa del popolo siriano”.
Mentre tutte le delegazioni presenti domenica in Turchia non hanno esitato a puntare ancora una volta il dito contro Assad per non aver implementato il piano Annan, nessuno ha ritenuto opportuno ricordare come la stessa proposta di pace preveda lo stop alle violenze anche per l’opposizione armata. Per Damasco, la cessazione unilaterale delle operazioni militari nel paese senza una simile iniziativa dei “ribelli” rappresenterebbe infatti un vero e proprio suicidio.
 Per il Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, “dopo quasi una settimana, dobbiamo concludere che il regime ha fatto una nuova aggiunta alla sua lunga lista di promesse non mantenute”. Per questo, secondo la ex first lady, “il mondo deve giudicare Assad per le sue azioni e non per le sue parole”.
Per il Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, “dopo quasi una settimana, dobbiamo concludere che il regime ha fatto una nuova aggiunta alla sua lunga lista di promesse non mantenute”. Per questo, secondo la ex first lady, “il mondo deve giudicare Assad per le sue azioni e non per le sue parole”.
Quest’ultima frase di Hillary esprime alla perfezione tutta l’ipocrisia che avvolge la politica estera statunitense, dal momento che parole simili potrebbero essere applicate precisamente ai crimini commessi dall’imperialismo americano nel mondo e nascosti dietro la retorica della democrazia e dell’intervento “umanitario”.
Proprio per aprire la strada ad un intervento esterno era stato creato il gruppo degli “Amici della Siria”, in modo da scavalcare il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dove nei mesi scorsi risoluzioni anti-Assad erano state bloccate dal veto di Russia e Cina per evitare il ripetersi della vicenda libica.
I governi di Mosca e Pechino, vale a dire i principali alleati di Damasco, erano entrambi assenti dal vertice di Istanbul. Nella metropoli turca erano invece presenti i rappresentanti del Consiglio Nazionale Siriano (CNS), il cui numero uno, Burhan Ghalioun, prima dell’apertura dei lavori ha invitato i governi presenti ad aumentare il loro impegno per armare il Libero Esercito della Siria e aprire al più presto corridoi “umanitari” nel paese, sostanzialmente una copertura per un intervento militare esterno.
Gli “Amici della Siria” si sono ancora una volta dimostrati poco interessati alle profonde divisioni interne al Consiglio Nazionale Siriano o alle recenti accuse di crimini guerra rivolte da Amnesty International ai gruppi armati che da esso dovrebbero dipendere. Il CNS è infatti stato riconosciuto domenica come “legittimo rappresentante di tutti i siriani”, anche se per il momento non l’unico.
La promozione del CNS e del Libero Esercito della Siria è proseguita con la conferma da parte di Hillary Clinton dell’impegno americano a fornire equipaggiamenti “non letali” all’opposizione, come aveva anticipato settimana scorsa a Seoul il presidente Obama in un faccia a faccia con Erdogan a margine di un summit sul nucleare tenuto nella capitale sudcoreana.
 Il materiale promesso consisterebbe soprattutto in sofisticati sistemi di comunicazione per permettere un più efficace coordinamento non solo nella progettazione di attacchi contro le forze e le installazioni del regime, ma anche in vista di un eventuale intervento militare esterno.
Il materiale promesso consisterebbe soprattutto in sofisticati sistemi di comunicazione per permettere un più efficace coordinamento non solo nella progettazione di attacchi contro le forze e le installazioni del regime, ma anche in vista di un eventuale intervento militare esterno.
A Istanbul si è discussa poi la creazione di un fondo a favore del CNS, anche se non è stato raggiunto un accordo sull’impiego del denaro da raccogliere. Paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar, sebbene lo facciano già da tempo in maniera non ufficiale, spingono per fornire armi ai “ribelli”, mentre Washington, Ankara e l’Europa sembrano nutrire ancora qualche riserva.
Secondo le cifre fornite dai rappresentanti del CNS, starebbero per essere stanziati 176 milioni di dollari per assistenza “umanitaria” e 100 milioni per pagare direttamente i salari dei membri dell’opposizione armata. Questi ultimi diventeranno così a tutti gli effetti veri e propri mercenari al servizio delle potenze imperialiste occidentali per rovesciare un regime sgradito.
Nella dichiarazione finale degli “Amici” è stata inclusa la richiesta a Kofi Annan di stabilire una scadenza oltre la quale dovranno essere decisi i prossimi passi da fare per risolvere la crisi siriana. Lunedì al Consiglio di Sicurezza ONU, l’ex segretario generale ha così annunciato il prossimo 10 aprile come data concordata con Damasco per l’inizio dell’implementazione del piano. L’ambasciatore siriano al Palazzo di Vetro, Bashar Jafari, ha confermato l’impegno, vincolato però al rispetto del cessate il fuoco anche da parte dell’opposizione.
Sempre a Istanbul, i delegati dei governi hanno inoltre deciso di istituire un gruppo di lavoro per monitorare quei paesi che continuano a fornire armi o altro supporto al governo Assad. Questi movimenti, peraltro, sono ratificati da contratti legali stipulati con un governo legittimo, a differenza dei traffici illegali che dal Golfo vanno ad alimentare le violenze in Siria.
Infine, è stato raggiunto un accordo per facilitare la raccolta di prove che documentino la repressione del regime in vista di futuri processi per crimini di guerra contro Assad e la sua cerchia di potere. Questo sforzo, com’è ovvio, non comprende le prove di torture, rapimenti e uccisioni arbitrarie, anche a danno di civili, di cui si stanno macchiando i “ribelli”.
Il summit di Istanbul è stato duramente condannato dalla Russia che lo ha definito una distrazione dalla missione diplomatica di Annan e un nuovo tentativo di destabilizzare la Siria per aprire la strada ad un intervento militare. Il livello di impegno per la risoluzione pacifica della crisi da parte degli “Amici della Siria” è risultato d’altra parte evidente dall’esclusione dalla conferenza di quei gruppi dell’opposizione che hanno mostrato una certa disponibilità ad aprire un dialogo con il regime.
È il caso, questo, del Comitato di Coordinamento Nazionale Siriano, che, come ha scritto sabato Bloomberg News, dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri russo Lavrov a Mosca tra un paio di settimane per discutere proprio quel piano Annan che, a differenza del CNS, i suoi vertici hanno approvato e che potrebbe però essere ben presto superato dai fatti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Qualche giorno fa, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha dato il via libera definitivo e con accordo bipartisan a quello che è stato propagandato come un provvedimento in grado di stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro. La nuova legge, appoggiata dall’amministrazione Obama, ha in realtà a che fare con l’occupazione solo per l’acronimo che è stato scelto come nome (JOBS Act o Jumpstart Our Business Startup Act), dal momento che si risolve in una serie di misure volte a ridurre le regolamentazioni per il business americano che, con ogni probabilità, finiranno per facilitare le frodi finanziarie.
Anche se teoricamente rivolta alle piccole imprese, il punto centrale della legislazione appena licenziata dal Congresso è l’allentamento dei controlli da parte della Commissione per i Titoli e gli Scambi (Securities and Exchange Commission, SEC) - l’ente federale statunitense che vigila sulla Borsa - sulle nuove aziende (“Startup”) con un fatturato annuo fino a un miliardo di dollari
I contenuti del JOBS Act sono in buona parte ispirati alle proposte presentate nel recente passato dal presidente Obama, tra cui alcune snocciolate durante l’ultimo discorso sullo stato dell’Unione. Oltre alla scomparsa dell’obbligo di sottostare alla supervisione della SEC, la legge semplificherà la raccolta del capitale per le aziende nascenti, in particolare tra un vasto numero di investitori attraverso il web (“crowdfunding”).
Inoltre, il numero minimo di investitori al di sopra del quale queste “startup companies” saranno obbligate a sottoporre i bilanci alla SEC passerà da 500 a 1.000, mentre le aziende potranno fare pubblicità virtualmente senza controlli per sollecitare gli investimenti, con la conseguenza di facilitare le frodi.
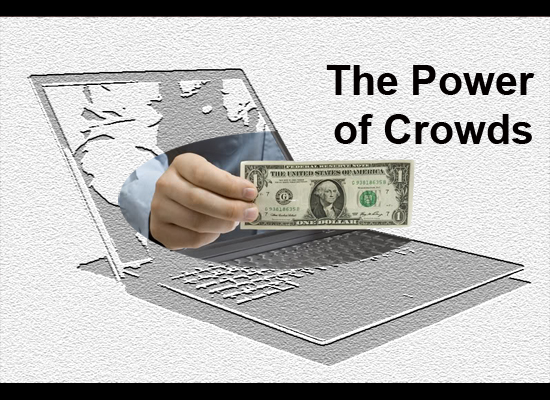 Queste iniziative hanno suscitato le critiche delle associazioni a difesa dei consumatori e degli investitori, preoccupate per l’ulteriore apertura di un settore già debolmente regolamentato e che ha già registrato nel recente passato numerose truffe. L’agenzia a protezione degli investitori NASAA (North American Securities Administrators Association) ha ad esempio messo in guardia dagli effetti negativi della legge, soprattutto sui pensionati.
Queste iniziative hanno suscitato le critiche delle associazioni a difesa dei consumatori e degli investitori, preoccupate per l’ulteriore apertura di un settore già debolmente regolamentato e che ha già registrato nel recente passato numerose truffe. L’agenzia a protezione degli investitori NASAA (North American Securities Administrators Association) ha ad esempio messo in guardia dagli effetti negativi della legge, soprattutto sui pensionati.
Il suo presidente, Jack Herstein, ha ricordato come “nel 2004 l’amministrazione Bush ostacolò numerose leggi statali a protezione degli investitori per facilitare la cosiddetta innovazione finanziaria, specialmente nel settore dei mutui. La maggior parte di noi ricorda molto bene come é andato a finire l’esperimento, ma il Congresso sembra non avere imparato la lezione”. Per Herstein, il JOBS Act creerà “nuovi posti di lavoro solo per i promotori di truffe finanziarie su Internet”.
Giovedì scorso, anche l’ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti, nonché attivista per i diritti dei consumatori, Ralph Nader, ha fatto sentire la propria voce, chiedendo a Obama di porre il veto sulla nuova legge. Nader sostiene che “il JOBS Act permetterà di avviare imprese rischiose senza i dovuti controlli delle agenzie preposte” ed “eliminerà molti obblighi che vengono solitamente imposti alle nuove compagnie per proteggere gli investitori”.
I media mainstream d’oltreoceano e la stessa Casa Bianca, al contrario, hanno elogiato il Congresso per l’accordo bipartisan a favore della crescita economica. Le profonde divisioni tra i due schieramenti sono infatti messe da parte senza difficoltà quando si presenta l’occasione di avanzare proposte che beneficiano i grandi interessi economici e finanziari a spese di lavoratori e classe media.
Alla Camera, il JOBS Act è stato così approvato con 380 voti a favore e appena 41 contrari. Qualche giorno prima, il Senato lo aveva ugualmente licenziato con un margine di 73 a 26. La Camera si era in realtà già espressa a favore in precedenza, ma una modifica introdotta dal Senato ha richiesto un ulteriore voto.
 Su richiesta di alcuni senatori democratici era stato inserito l’obbligo di un qualche controllo per le aziende che utilizzeranno il sistema del “crowdfunding”, anche se da più parti alla Camera è già stato espresso l’auspicio che nel prossimo futuro questa modesta regolamentazione venga smantellata.
Su richiesta di alcuni senatori democratici era stato inserito l’obbligo di un qualche controllo per le aziende che utilizzeranno il sistema del “crowdfunding”, anche se da più parti alla Camera è già stato espresso l’auspicio che nel prossimo futuro questa modesta regolamentazione venga smantellata.
La nuova legge è stata ovviamente accolta con entusiasmo dai vari gruppi imprenditoriali e dalle corporations d’oltreoceano. Per stessa ammissione dei suoi sostenitori, comunque, il JOBS Act avrà al massimo un impatto irrisorio sul mercato del lavoro, con la creazione di un massimo stimato di 100 mila nuovi posti nei prossimi otto anni. Secondo i dati ufficiali dell’Ufficio per le Statistiche del Dipartimento del Lavoro, nel mese di febbraio gli americani disoccupati erano 12,8 milioni.
Di fronte ad una crisi che sembra aver mollato la presa solo per i membri dell’aristocrazia economico-finanziaria, gli unici provvedimenti che la politica statunitense è in grado di adottare consistono dunque esclusivamente in nuovi sostanziosi regali alle corporations e nella ulteriore deregolamentazione del business. Per i milioni di americani senza lavoro quello che resta sono invece le briciole di sussidi di disoccupazione sempre più ridotti o, tutt’al più, la misera prospettiva di impieghi precari e sottopagati.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Luca Mazzucato
di Luca Mazzucato
NEW YORK. Per alcuni, Goldman Sachs, la madre di tutte le banche, è il male assoluto, mentre per chi lavora in finanza è il sogno nel cassetto. Se fino ad ora le critiche sono state tutte concentrate sulle pratiche finanziarie ai limiti della legalità, adesso il gioco si fa pesante: l'accusa è di prostituzione minorile e traffico di esseri umani. Negli Stati Uniti questa è probabilmente la singola accusa più infamante, capace di trascinare un'azienda a picco. Lo scoop del New York Times apre una voragine nell'immagine pubblica di Goldman ed è difficile immaginare cosa succederà. Certo è che la storia è una bomba.
Fino al 2008, la banca d'investimento era considerata la più prestigiosa azienda del pianeta, dai profitti stellari e un vero magnete per le menti più brillanti del panoramana mondiale e soprattutto dell'Ivy League. I suoi ex-dipendenti stanno governando il nostro continente: dal capo della BCE Mario Draghi, al nostro premier Monti e al premier greco Papademos.
La reputazione della banca è da anni in costante declino, anche se i suoi profitti e i bonus dei suoi dirigenti sono tornati ai livelli pre-crisi. La storia recente ha portato alla luce il modus operandi della banca: cercare di speculare il più possibile sui propri clienti, a costo di rifilare a ignari fondi pensione investimenti spazzatura, scommettendo sul loro fallimento e mietendo profitti stellari. Le recenti dimissioni di un pezzo grosso di Goldman Sachs a mezzo di editoriale infamante sul NYT hanno ricordato a tutti chi sono e cosa fanno questi cosiddetti “Masters of the universe.” Ma ora viene quasi da pensare: fossero questi i problemi!
Nicolas Kristof, sul New York Times, racconta i retroscena di una storia che farà rizzare i capelli in testa anche al più cinico tra i repubblicani. Il mondo dei siti online che offrono servizi di sesso a pagamento è uno dei più redditizi negli Stati Uniti. Spesso però, come nel caso del sito Backpage.com, gli annunci su questi siti non sono postati da escort indipendenti, ma da veri e propri schiavisti. Una recente indagine ha scoperto un osceno traffico di ragazzine minorenni che venivano rapite, drogate, pestate, ridotte in schiavitù e poi offerte al pubblico pedofilo, proprio su questo sito. I magistrati hanno incastrato i colpevoli, ma purtroppo non sono riusciti a fare in modo che la società proprietaria del sito venisse considerata legalmente responsabile per gli annunci messi online. Questo nonostante l'intervento di ben diciannove senatori americani.
 Kristof ha deciso di vederci chiaro e ha iniziato a indagare sugli assetti proprietari del sito, uno dei più popolari con milioni di visitatori. Scopre che l'azienda appartiene per il cinquantuno percento a "Village Voice Media", la stessa società che gestisce lo storico giornale gratuito The Village Voice, distribuito ovunque a New York, che peraltro si finanzia con decine di pagine di pubblicità di escort e vari servizi sessuali a pagamento. Ma chi possiede il resto della proprietà?
Kristof ha deciso di vederci chiaro e ha iniziato a indagare sugli assetti proprietari del sito, uno dei più popolari con milioni di visitatori. Scopre che l'azienda appartiene per il cinquantuno percento a "Village Voice Media", la stessa società che gestisce lo storico giornale gratuito The Village Voice, distribuito ovunque a New York, che peraltro si finanzia con decine di pagine di pubblicità di escort e vari servizi sessuali a pagamento. Ma chi possiede il resto della proprietà?
Avete indovinato. La quota di minoranza di "Village Voice Media" appartiene a varie banche d'investimento, e il secondo azionista - con il sedici percento - è proprio Goldman Sachs, che ha acquistato la sua quota nel 2000, subito prima che la società mettesse le mani sul sito di sesso a pagamento. Uno dei consiglieri di amministrazione della società, fino al 2010, è stato il senior manager di Goldman Sachs Scott Lebovitz. Elizabeth McDougall, consulente capo di "Village Voice Media", intervistata dal New York Times ha dichiarato che nessuno dei proprietari ha mai mostrato alcun dissenso rispetto alla condotta della società.
Insomma, ci sono dentro fino al collo. Negli ultimi giorni la banca e le altre società finanziarie coinvolte, invece di usare il loro peso azionario per aiutare i magistrati a bloccare le pratiche illegali del sito Backpage.com, hanno cercato di sbarazzarsi delle azioni in fretta e furia, senza peraltro riuscirci. Come bambini colti con le mani nel sacco: anche se in questo caso il sacco è un osceno intreccio di schiavitù, sfruttamento e prostituzione minorile.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Vincenzo Maddaloni
di Vincenzo Maddaloni
Il bersagliere ucciso nell’attacco talebano di pochi giorni fa rende ancor più pesante il fallimento della missione italiana in Afghanistan. Da una parte cresce a cinquanta il numero dei nostri caduti, dall’altra parte il fatto che le grandi potenze occidentali riunite nella Nato non possono che proclamare la sconfitta, dopo oltre dieci anni di conflitto.
Tuttavia, nonostante il nostro contingente in Afghanistan sia il quarto per numero, non ha impedito che in Italia più che altrove la politica estera resti un’appendice della politica interna anche con il governo Monti (si tenga a mente come si ta gestendo la vicenda dei due marò imprigionati in India).
Infatti, per cause storiche e culturali, abbiamo una classe dirigente restia non solo a pensare la politica estera in termini globali, ma persino a coltivare curiosità per quelle zone dove sono presenti i soldati italiani e lo Stato spende.
Che tutto questo sia reale lo conferma la gran parte di quanto è stato detto e scritto in Italia negli ultimi dieci anni e passa a proposito dei grandi temi della politica estera, incluso l’Afghanistan con i suoi talebani. Eppure, per rimediare basterebbe un semplice ripasso ricordando, per esempio, che ben tre guerre furono perse con l'Afghanistan, nell'Ottocento e nel Novecento. L’Inghilterra le perdette perché insediò a Kabul dei governi fantocci, perché non tenne in alcuna considerazione le sue antiche decentrate strutture tribali, perché credeva che era il miglior modo per fare dell’Afghanistan uno Stato cuscinetto tra Russia, Persia, India.
Sono errori che continuano a ripetersi, e fa impressione che nessuno se ne sia rammentato. Mi tornano sempre in mente le parole di Boris Gromov, il generale comandante dell’Armata Rossa che seppe uscire con dignità dalla trappola afghana:« Abbiamo perso la guerra perché non abbiamo rispettato le promesse con la popolazione, come non era mai accaduto prima. Infatti - mi spiegava (anno 1989) - prima la nostra tattica prevedeva la distruzione dei centri di potere dei tiranni e poi intervenire in soccorso della popolazione con ingenti aiuti economici. Così facendo abbiamo sempre vinto. Siamo stati sconfitti in Afghanistan perché è venuta a mancare questa seconda fase. Gli ottusi dirigenti che avevano preceduto Gorbaciov non avevano rispettato le promesse, e i pastori afghani delusi ci si sono rivoltati contro. Non vi si poteva rimediare se non ritirandosi».
 Beninteso, anche la guerra afghana in versione Nato ha messo in evidenza tanto gli errori politici quanto quelli militari. Fin dall’inizio (anno 2001) si sono declamati un’infinità di obiettivi: abbattere il regime talebano, distruggere l’infrastruttura di Al Qaeda, catturare bin Laden, diffondere pratiche e istituzioni più democratiche, lottare contro la corruzione, sostenere il governo di Karzai, limitare l’influenza delle potenze regionali vicine. Morale, si è realizzato poco o nulla di questo ambizioso, articolato e mutevole programma.
Beninteso, anche la guerra afghana in versione Nato ha messo in evidenza tanto gli errori politici quanto quelli militari. Fin dall’inizio (anno 2001) si sono declamati un’infinità di obiettivi: abbattere il regime talebano, distruggere l’infrastruttura di Al Qaeda, catturare bin Laden, diffondere pratiche e istituzioni più democratiche, lottare contro la corruzione, sostenere il governo di Karzai, limitare l’influenza delle potenze regionali vicine. Morale, si è realizzato poco o nulla di questo ambizioso, articolato e mutevole programma.
bin Laden è morto? Probabilmente non è mai esistito. Al Qaeda ha subito colpi durissimi e molti leaders sono stati fisicamente eliminati? È vero,ma molti altri ne hanno preso il posto e, cosa ben più grave, persino quella parte di popolazione che aveva salutato con speranza l’intervento occidentale ha girato le spalle ai “liberatori”, come aveva profetizzato vent'anni fa il generale Gromov.
Che cosa pensare? In un mondo mediatico in cui si continua a incoraggiare un giornalismo speculativo e spettacolare, a scapito di un giornalismo d’informazione e che dequalifica la figura stessa del giornalista fino ad annullarla, c’è poco da pensare. In Italia ha "perso di valore" il professionista esperto e aggiornato che possa intervenire con sicura competenza sui nodi sempre più ardui del mondo contemporaneo e spiegarli.
La funzione critica del giornalismo in Italia rischia l'estinzione. L’ultima parola - è diventata ormai una prassi - la si dà al conduttore televisivo, al maggiordomo del salotto mediatico. Così facendo, accade che siano i non giornalisti ad essere catapultati ai vertici della professione. Poi ci sono i politici che sempre di più intervengono nel mestiere del giornalista, e infine gli editori che sono imprenditori, attivi in molti campi, ai quali interessa solo e soltanto il business.
 Sicché in un simile panorama si sono letti i commenti più disparati su tutta una serie di episodi come quelli sui soldati americani che «impazziscono» e massacrano civili inermi per difendere i quali sono stati inviati in Afghanistan. Oppure sulle immagini di soldati Usa che offendevano nel modo più volgare cadaveri di talebani. Oppure sui militari afghani che sparano e uccidono i soldati che li stavano addestrando. Oppure i commenti sulle copie del Corano bruciate che hanno provocato violente manifestazioni e assalti ai compounds alleati durante i quali sono morti decine di afghani. Sui Droni che ammazzano persone a casaccio col preteso di eliminare questo o quel capobanda. Infine sull'inaudito massacro di 16 civili afghani ad opera del sergente Robert Bales.
Sicché in un simile panorama si sono letti i commenti più disparati su tutta una serie di episodi come quelli sui soldati americani che «impazziscono» e massacrano civili inermi per difendere i quali sono stati inviati in Afghanistan. Oppure sulle immagini di soldati Usa che offendevano nel modo più volgare cadaveri di talebani. Oppure sui militari afghani che sparano e uccidono i soldati che li stavano addestrando. Oppure i commenti sulle copie del Corano bruciate che hanno provocato violente manifestazioni e assalti ai compounds alleati durante i quali sono morti decine di afghani. Sui Droni che ammazzano persone a casaccio col preteso di eliminare questo o quel capobanda. Infine sull'inaudito massacro di 16 civili afghani ad opera del sergente Robert Bales.
Così la sequenza di «incidenti» ha fatto esplodere il clima di sfiducia già da tempo latente negli Usa scatenando un dibattito che, dietro le quinte dell'ufficialità, è ancora lontano da conclusioni condivise. Inoltre ha moltiplicato i dubbi dei nostri alleati europei al punto che in molti si chiedono se sia realistico pensare di ritirare il grosso delle truppe straniere dal Paese entro il 2014, come la Nato ha annunciato di voler fare da oltre un anno. L'Italia che fa? Stando così le cose che senso ha per un paese nelle condizioni economiche dell’Italia tirare fino al 2014? Se ci fosse una risposta chiara avremmo tutti da guadagnarne, a cominciare dal risparmio sulle spese militari. Ma Monti, come si vede, glissa. Per non dispiacere Obama.
