- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Lo scorso 1° Luglio, l’Assemblea Legislativa della Costa Rica, ha approvato con trentuno voti a favore e otto contrari, l’ingresso nel paese di 13.000 marines statunitensi, che saranno accompagnati da 46 navi d’appoggio, una portaerei e 200 elicotteri. Motivo ufficiale? La lotta al narcotraffico, of course. Motivo reale? Minacciare da vicino il Nicaragua di Daniel Ortega e il Venezuela di Hugo Chavez, che Washington proprio non riesce a normalizzare. La piccola repubblica centroamericana cambia così il suo destino o, perlomeno, la sua mission, trasformandosi da paradiso per turisti a base militare per gli Stati Uniti.
D’altra parte, la richiesta di questa sostanziale variazione di status era di quelle che non si potevano rifiutare, essendo pervenuta dalla locale ambasciata Usa il 21 giugno. Il Parlamento di San Josè ha offerto così una dimostrazione di tempismo ed efficienza, prima che di inclinazione alla servitù. Sembra quindi che il destino della Costa Rica vada evolvendo.
Un tempo noto come unico stato delle Americhe ad essere privo di forze armate, limitando alla sola Polizia Nazionale le funzioni difensive del paese - veniva chiamata la Svizzera del Centroamerica - San José ha deciso d’imprimere una svolta formale al suo status. A dire il vero, la singolarità dello Stato privo di apparato militare non era l’unica: anche sul piano finanziario, la Costa Rica ha sempre avuto un ruolo particolare nel continente, soprattutto nel proporsi come paradiso fiscale e nell’essere quindi utilizzato come lavatrice tropicale dei dollari sporchi.
Storicamente, San Josè è anche stata ripetutamente indicata come luogo adatto alla mediazione politico-diplomatica nella ribollente area Centroamericana. A fare da retroterra propagandistico a questa veste, veniva dichiarata una presunta neutralità politica della Costa Rica nei confronti dei conflitti politici e militari dei suoi vicini. Ma questa presunta neutralità non ha mai trovato cogenti conferme nelle opere di mediazione cui è stata chiamata nei decenni, anzi.
Durante gli anni ’80, la Costa Rica si caratterizzava per una politica verso il Nicaragua fortemente ambigua: da un lato offriva mediazione diplomatica e piani per il cessate il fuoco, dall’altro garantiva rifugio e logistica alla Contra, che installò una delle sue componenti (la FDN di Edgar Chamorro) che venne smantellata dalle operazioni militari delle forze speciali dell’Esercito sandinista, non certo dalla polizia nazionale costaricense che avrebbe dovuto, per decenza, impedire che sul suo territorio s’installassero basi militari da cui partivano aggressioni al paese confinante.
Allo stesso modo, non si può certo dire che la mediazione di Oscar Arias (ex-Presidente della Costa Rica e Nobel per la pace) tra il legittimo presidente dell'Honduras, Manuel Zelaya, e i golpisti filo-Usa guidati da Micheletti, sia stata all'insegna del ripristino della legalità. Come se vittime e carnefici fossero sullo stesso piano, come se l'isolamento dei golpisti non fosse l'unica strada percorribile per il ripristino della democrazia a Tegucigalpa, la mediazione di Arias ha avuto come conseguenza la legittimazione dei golpisti e il rapido ritiro delle sanzioni più dure da parte dell'OSA (Organizzazione Stati Americani).
all'insegna del ripristino della legalità. Come se vittime e carnefici fossero sullo stesso piano, come se l'isolamento dei golpisti non fosse l'unica strada percorribile per il ripristino della democrazia a Tegucigalpa, la mediazione di Arias ha avuto come conseguenza la legittimazione dei golpisti e il rapido ritiro delle sanzioni più dure da parte dell'OSA (Organizzazione Stati Americani).
Ma oggi San Josè compie un ulteriore, gravissimo, salto in avanti. Con la decisione del Parlamento della Costa Rica, infatti, gli Stati Uniti circondano decisamente il Centroamerica e i Caraibi. Il Pentagono avrà ora un altro grande dispositivo militare da affiancare a quello già presente a Palmarola, in Honduras, la più grande base militare statunitense fuori dai confini (anche per questo Tegucigalpa è definita una portaerei statunitense).
Il nuovo spiegamento di truppe in Costa Rica si aggiunge poi alle 13 nuove basi Usa in Colombia (di cui allocazione, armamenti, numero degli effettivi e raggio d’azione sono secretati dal governo di Bogotà, in spregio alla stessa Costituzione colombiana), alla spedizione militare ad Haiti, alla base di Curazao e a Panama, oltre che al ripristino del dispiegamento della IV Flotta nel Mar dei Caraibi, voluto da un altro Nobel per la Pace: Barak Obama.
Il livello di armamenti e soldati che Washington ha raggiunto nell’area, con la complicità dei regimi alleati, è ormai difficile da interpretare come ordinario. E’ invece un vero e proprio costante riposizionamento militare e politico, che punta senza equivoci al dominio del “giardino di casa”. Uno spiegamento di forze che non solo altera profondamente gli equilibri militari tra paesi sovrani nell’area, ma si pone come ipoteca pesante sullo sviluppo dei processi politici locali e continentali e la stessa sovranità degli stati che la compongono.
Un triste evolversi della realtà latinoamericana anche per chi, meno di un anno fa, aveva ingenuamente sperato che, a Washington, i tempi stavano cambiando. L’evidenza della minaccia a Nicaragua e Venezuela la vede chiunque non voglia chiudere gli occhi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Luca Mazzucato
di Luca Mazzucato
NEW YORK. Una buona notizia: il tappo tiene! Il video in live streaming dal fondo del Golfo del Messico, che da tre mesi getta l'America nella disperazione, è improvvisamente cambiato: ora tutto tace. Non si vede più il fiume rosso della falla di greggio ad alta pressione. Al suo posto, la tranquilla immagine di un tappo bianco e acqua pulita. Ma si tratta solo di un test e gli esperti sono scettici: presto dovranno riaprire la valvola.
Alle 2:25 di pomeriggio di giovedì scorso, i robot sottomarini sono riusciti ad avvitare la valvola di contenimento sulle estremità slabbrate del pozzo petrolifero, a millecinquecento metri di profondità. Tutti i precedenti tentativi di contenere la falla erano falliti miseramente e ormai nessuno si aspettava che questo invece riuscisse. Ma infine il miracolo è arrivato.
La valvola rimarrà sigillata per almeno due giorni, per dare il tempo agli esperti di studiare la pressione sul tappo e all'interno del pozzo. Un'improvvisa diminuzione della pressione segnalerebbe l'apertura di una nuova in un altro punto e, in quel caso, la valvola verrà riaperta immediatamente. Se il test fornirà i risultati sperati, a quel punto forse si potrà capire quale sarà il passo successivo.
Le possibilità che il governo americano e British Petroleum stanno ora valutando sono tre: attaccare una cannuccia alla valvola e riaprirla per riprendere l'estrazione del petrolio, tornando alla situazione precedente all'incidente; oppure ricominciare l'estrazione e, se il tappo passerà i test sotto sforzo, usare la valvola per chiudere il pozzo durante i frequenti uragani; oppure, se il tappo tiene, chiudere il pozzo definitivamente.
Sembra più probabile che BP decida di riaprire la valvola ed estrarre il petrolio: l'unica situazione che assicura un profitto certo. Due navi preposte all'estrazione sono già sul posto e altre due stanno per arrivare. L'ammiraglio Thad Allen, responsabile della gestione della crisi per l'amministrazione Obama, si è affrettato però a precisare che la chiusura del pozzo è solo temporanea, per poter abbandonare il sito in caso di uragano, ma l'unica soluzione definitiva è la trivellazione dei pozzi paralleli che prenderà ancora qualche settimana.
Nonostante la buona notizia, la reazione dei pescatori lungo la costa non è proprio entusiasta, anzi tendono a non credere più alle notizie provenienti da BP. Il New York Times ha raccolto alcune testimonianze: “È come mettere un cerotto su un cadavere” - sospira un raccoglitore di granchi - “all'inizio li stavo a sentire ma ora credo più a una parola di quello che dicono”. Un'altra pescatrice di gamberetti è sarcastica: “Cosa c'è da celebrare? La mia vita è finita, hanno distrutto tutto quello che avevo e che amo”.
Ma i guai non sono finiti. Nei giorni scorsi, un'inchiesta dell'Associated Press aveva denunciato la presenza di 27.000 pozzi petroliferi abbandonati nel Golfo del Messico, potenzialmente delle bombe ambientali ad orologeria. Alcuni dei pozzi risalgono agli anni quaranta, agli albori della trivellazione sottomarina. 3.500 di questi pozzi risultano “temporaneamente abbandonati”, il che significa che il rubinetto è stato chiuso ma la valvola non è stata sigillata, alcuni addirittura dagli anni Cinquanta. E siccome nessuno si è mai preso la briga di controllare, potrebbero benissimo essere diventati dei colabrodo nel disinteresse generale. Dopo la denuncia dei giornalisti, il Congresso americano ha avviato un'ispezione approfondita dei pozzi e i parlamentari sono già volati sul posto per investigare.
 La situazione politica resta ingarbugliata e non si vede alcuna facile soluzione al problema delle trivellazioni offshore. Obama, sulla scia della rabbia popolare seguita al disastro, aveva varato moratoria di sei mesi sulle trivellazioni offshore. Ma un giudice ha bloccato la moratoria e al momento non è chiaro il prossimo passaggio.
La situazione politica resta ingarbugliata e non si vede alcuna facile soluzione al problema delle trivellazioni offshore. Obama, sulla scia della rabbia popolare seguita al disastro, aveva varato moratoria di sei mesi sulle trivellazioni offshore. Ma un giudice ha bloccato la moratoria e al momento non è chiaro il prossimo passaggio.
Nel frattempo, la popolazione del Golfo si divide a metà tra i lavoratori dell'industria petrolifera, infuriati per i blocchi all'estrazione, e quelli che si guadagnano da vivere sfruttando il pesce e il turismo e che hanno perso ogni fonte di sostentamento. Ma hanno intascato denaro contante da BP, impegnandosi a non chiedere i danni in una eventuale class action contro la compagnia petrolifera.
Un'altra inchiesta giornalistica ha scoperto che, nonostante la moratoria sulle trivellazioni offshore, l'Ufficio preposto alla valutazione delle domande di trivellazione continua a lavorare senza sosta, approvando decine di nuovi progetti tra cui anche quelli presentati da BP. Alcuni di essi prevedono l'apertura di pozzi sottomarini al Polo Nord, dove qualsiasi falla avrebbe conseguenze assai più catastrofiche (se possibile) di quelle attuali.
Una fuoriuscita di petrolio al Polo sarebbe impossibile da richiudere durante quasi tutto l'anno e si spanderebbe senza ostacoli dal Canada alla Norvegia fino alle coste russe. L'amministrazione ha risposto che si tratta solo di “firme su delle carte,” e procedure burocratiche e che “nessuna nuova trivellazione è stata avviata.” Ma il comico Jon Stewart ci tiene a ricordare al Presidente che “non è stato eletto per mettere la firma su delle carte ma per cambiare le cose”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Al termine di una seduta estenuante, durata quasi sedici ore, nella prima mattinata di giovedì il Senato argentino ha dato il via libera definitivo alla legalizzazione dei matrimoni gay. Lo storico provvedimento fa dell’Argentina il primo paese latinoamericano ad introdurre una legislazione così avanzata su scala nazionale e attesta degli enormi progressi fatti dalla lotta per i diritti civili in un paese dove è tuttora molto forte l’influenza della Chiesa Cattolica.
La nuova legge era già stata approvata dalla camera bassa del Parlamento argentino lo scorso mese di maggio e, dal momento che il presidente Cristina Fernández de Kirchner si era già espressa favorevolmente, entrerà in vigore a breve. Con il sostegno opposto di gruppi di manifestanti contro e a favore delle nozze gay che hanno sfidato il freddo dell’inverno australe fuori dal palazzo del congresso, 33 senatori si sono espressi a favore, mentre 27 sono stati i contrari e tre gli astenuti.
Il crescente clima favorevole per le coppie omosessuali in Argentina era stato già confermato negli ultimi mesi, quando una serie di tribunali aveva di fatto riconosciuto la costituzionalità delle nozze gay, concedendo nove licenze per la celebrazione di altrettanti matrimoni, alcuni dei quali però successivamente invalidati. La città di Buenos Aires, inoltre, già prevedeva la possibilità di celebrare unioni civili tra persone dello stesso sesso. La legge appena approvata, tuttavia, oltre ad avere un importante significato simbolico, garantirà, tra l’altro, anche il diritto di adozione e di ereditare i beni del coniuge.
La discussione sui matrimoni gay in vista dell’approvazione definitiva era stata pesantemente condizionata da una campagna di opposizione da parte della Chiesa Cattolica. Quella stessa Chiesa Cattolica che non aveva mostrato altrettanti scrupoli nell’appoggiare i massacri del regime di Videla, alla vigilia del voto al Senato aveva organizzato una marcia di protesta con alcune migliaia di manifestanti per convincere i parlamentari a bloccare la legge. A conferma delle pressioni, molti senatori che si sono espressi contro il provvedimento hanno fatto appello precisamente alla loro fede cattolica nelle rispettive dichiarazioni di voto.
Da parte sua, l’arcivescovo di Buenos Aires, Cardinale Jorge Bergoglio, ha tuonato contro la legislazione con i consueti toni apocalittici. I matrimoni gay, ha sostenuto il rappresentante della Chiesa di Roma, costituiscono un “attacco al piano di Dio” e “una sconfitta per tutti”, dal momento che a suo dire i “bambini hanno il diritto di essere cresciuti ed educati da un padre e da una madre con ruoli ben definiti”.
 Impegnata in una visita ufficiale in Cina, la Presidenta ha reagito duramente alle invettive della Chiesa e dei gruppi religiosi, dicendosi preoccupata nell’ascoltare parole come “guerra santa” o “progetto demoniaco” tra i contrari ai matrimoni gay, toni che sembrano rievocare cupamente i “tempi dell’Inquisizione o delle Crociate”. Sempre secondo la Kirchner, “la Chiesa sta invocando una questione morale e religiosa che minaccerebbe l’ordine naturale, quando in realtà quello che stiamo facendo è semplicemente prestare attenzione a ciò che sta già accadendo nella nostra società. Per questo, sarebbe una tremenda distorsione della democrazia se negassimo alle minoranze i loro diritti”.
Impegnata in una visita ufficiale in Cina, la Presidenta ha reagito duramente alle invettive della Chiesa e dei gruppi religiosi, dicendosi preoccupata nell’ascoltare parole come “guerra santa” o “progetto demoniaco” tra i contrari ai matrimoni gay, toni che sembrano rievocare cupamente i “tempi dell’Inquisizione o delle Crociate”. Sempre secondo la Kirchner, “la Chiesa sta invocando una questione morale e religiosa che minaccerebbe l’ordine naturale, quando in realtà quello che stiamo facendo è semplicemente prestare attenzione a ciò che sta già accadendo nella nostra società. Per questo, sarebbe una tremenda distorsione della democrazia se negassimo alle minoranze i loro diritti”.
Nei sondaggi, tra l’altro, la maggioranza della popolazione argentina (quasi il 70%) si è dimostrata favorevole alle nozze tra persone dello stesso sesso, anche se i consensi scendono sensibilmente sulla questione delle adozioni alle coppie gay. Proprio l’aver cavalcato un tema inaspettatamente così popolare in Argentina rappresenterebbe, secondo alcuni esponenti dell’opposizione, una mossa opportunistica da parte di Cristina Kirchner e del marito, l’ex presidente Néstor Kirchner, possibile candidato alle elezioni presidenziali del prossimo anno.
Il capitale politico investito nei matrimoni gay, piuttosto, potrebbe creare una frattura nella base del partito peronista di Néstor e Cristina Kirchner, così come alienare loro una parte dei consensi degli elettori delle province rurali del paese, tradizionalmente più conservatori sulle questioni sociali.
Se come detto, l’Argentina, diventa così il primo paese latinoamericano a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, qualche mese fa era stata in realtà Città del Messico la prima giurisdizione in assoluto a muoversi in questo senso. A sud degli Stati Uniti, poi, le unioni civili gay sono già garantite, sia pure riconoscendo diritti differenti a seconda dei casi, in Uruguay, Colombia e in alcuni stati del Brasile.
Per quanto riguarda invece i matrimoni gay, essi sono stati legalizzati a tutt’oggi - oltre che in Argentina - in Belgio, Canada, Islanda, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Sudafrica e Svezia; nonché negli Stati Uniti, limitatamente al District of Columbia e agli stati di Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire e Vermont.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Alle 18 e 30 di lunedì scorso, un anonimo taxi ha scaricato un ricercatore iraniano di fronte all’ambasciata pakistana a Washington, presso cui si trova la sede diplomatica di Teheran che cura gli interessi della Repubblica Islamica negli Stati Uniti. Scienziato nucleare con un ruolo non del tutto chiaro in patria, il 32enne Shahram Amiri era improvvisamente sparito nella primavera del 2009 durante una “umra” (pellegrinaggio) a Medina, in Arabia Saudita, sollevando immediatamente più di un sospetto circa il coinvolgimento della CIA nella sua scomparsa.
La sparizione di Shahram Amiri dalla sua camera d’albero saudita, il 3 giugno dello scorso anno, aveva aperto un nuovo capitolo nel confronto tra Stati Uniti e Iran. Secondo il governo di Teheran, l’operazione andava attribuita alla principale agenzia d’intelligence a stelle e strisce, orchestrata per mettere le mani su una fonte di informazioni ritenuta preziosa in merito al programma nucleare iraniano. Per Washington, al contrario, Amiri aveva defezionato di sua spontanea volontà e, ugualmente senza pressioni, aveva deciso di raccontare quanto aveva avuto modo di conoscere grazie al suo impiego in Iran.
Subito dopo il probabile rapimento, l’Iran aveva manifestato il proprio disappunto per il comportamento americano, chiedendo addirittura al Segretario Generale delle Nazioni Unite di adoperarsi per la restituzione del ricercatore. Ammettendo un qualche ruolo nei fatti, la CIA da parte sua aveva confermato il trasferimento immediato di Amiri dall’Arabia Saudita agli Stati Uniti. Qui, secondo Teheran, quest’ultimo era stato imprigionato e torturato al fine di estorcergli informazioni segrete.
Comunque si siano svolti i fatti, a un certo punto la CIA ha inserito Amiri in un programma di protezione per fuoriusciti, facendolo risiedere a Tucson, in Arizona. Secondo la ricostruzione americana, nei primi mesi del 2010 la volontà di collaborazione dello scienziato iraniano avrebbe mostrato qualche segno di cedimento, dal momento che iniziavano a farsi strada serie preoccupazioni per possibili ritorsioni da parte delle autorità di Teheran ai danni della moglie e del figlio rimasti in patria.
Ad infittire il mistero creatosi attorno alla sorte dello scienziato, svanito nel nulla sul territorio del principale alleato americano nel mondo arabo, era stata poi la comparsa in rete di una serie di filmati contraddittori. Nel primo, risalente al 5 aprile scorso, un Amiri provato descriveva in lingua persiana le fasi del suo rapimento. L’operazione, a suo dire, era stata organizzata dalla CIA e dai servizi segreti sauditi. Dopo un’iniezione di una sostanza imprecisata somministratagli dai rapitori, Amiri si era addormentato e, al risveglio, si era reso conto di essere in volo verso gli USA.
Solo poche ore dopo il primo video, su YouTube ne sarebbe apparso un secondo, realizzato in maniera decisamente più professionale, tanto da far pensare al contributo della stessa CIA. Scrupolosamente curato nell’aspetto, Amiri parlava all’interno di una stanza ben illuminata, verosimilmente una biblioteca, con un mappamondo e una scacchiera sullo sfondo. In questo filmato negava di essere stato rapito, affermando invece di essere giunto spontaneamente negli Stati Uniti per frequentare un dottorato di ricerca e, una volta ultimato, tornare dalla sua famiglia in Iran.
Rassicurando circa il suo ottimo stato di salute, Amiri definiva come falsi i filmati diffusi in precedenza su di lui e negava di avere alcun interesse nella politica o di possedere esperienza in ambito di armamenti nucleari. Successivamente, venne caricato un terzo e ultimo video il cui contenuto appariva simile a quello del primo.
Se per gli iraniani il primo e il terzo filmato erano la prova del rapimento di Amiri, per l’intelligence americana erano dettati unicamente dai suoi timori per la famiglia, tanto che alla fine sarebbe arrivata appunto la richiesta di tornare in Iran. Giunto all’ambasciata del Pakistan negli USA, Amiri ha dichiarato alla televisione pubblica iraniana di essere stato sottoposto a “enormi pressioni psicologiche sotto la supervisione di agenti armati durante gli ultimi 14 mesi” ed ha aggiunto che il suo “rapimento è stato un atto inammissibile da parte degli americani”.
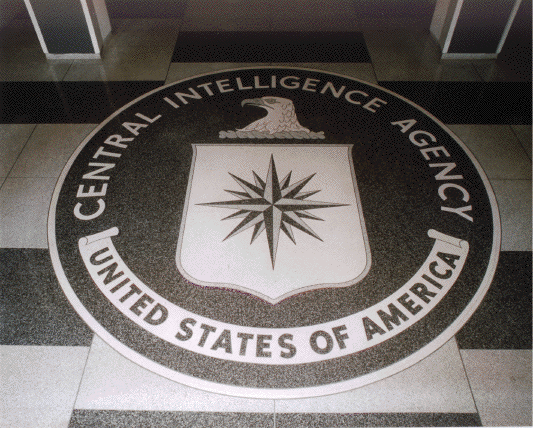 A negare ogni atto illecito ci ha provato il Segretario di Stato in persona, Hillary Clinton, ribadendo che lo scienziato iraniano era giunto di sua spontanea volontà nel paese e che era libero di andarsene in qualsiasi momento, come poi ha fatto. I media iraniani, al contrario, sostengono che le autorità americane hanno deciso di rilasciare Amiri dopo aver preso atto del “fallimento del loro piano propagandistico per screditare il programma nucleare iraniano”, creando artificialmente interviste con un cittadino della Repubblica Islamica.
A negare ogni atto illecito ci ha provato il Segretario di Stato in persona, Hillary Clinton, ribadendo che lo scienziato iraniano era giunto di sua spontanea volontà nel paese e che era libero di andarsene in qualsiasi momento, come poi ha fatto. I media iraniani, al contrario, sostengono che le autorità americane hanno deciso di rilasciare Amiri dopo aver preso atto del “fallimento del loro piano propagandistico per screditare il programma nucleare iraniano”, creando artificialmente interviste con un cittadino della Repubblica Islamica.
Se dietro alla vicenda di Amiri rimangono molte zone oscure, è possibile che i servizi americani nelle ultime settimane abbiano iniziato a sentire qualche pressione che ha portato infine il presunto esule a “riparare” presso la rappresentanza diplomatica pakistana. Le accuse da parte di Teheran stavano infatti aumentando e, ai primi di luglio, il Ministero degli Esteri iraniano aveva convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata svizzera, che cura gli interessi americani in Iran, presentandogli una serie di documenti che avrebbero provato le responsabilità della CIA nel rapimento.
Il giorno successivo all’apparizione di Amiri a Washington, inoltre, il network satellitare iraniano Press TV aveva diffuso un comunicato dei servizi segreti di Teheran, nel quale si spiegava come al ricercatore erano stati promessi dieci milioni di dollari per apparire sulla CNN e annunciare la sua intenzione di defezionare negli Stati Uniti. La pratica del rapimento di personalità in grado di fornire notizie classificate sul nucleare iraniano da parte della CIA, oltretutto, non è nuova. All’inizio del 2007, ad esempio, l’ex vice-ministro della Difesa Ali-Reza Asgari venne con ogni probabilità rapito da un’azione congiunta di CIA e Mossad durante un viaggio a Istanbul, in Turchia.
A far scemare l’interesse per Shahram Amiri dei servizi statunitensi, e a decretare il loro sostanziale fallimento nell’intera operazione, c’è poi la sua probabile scarsa conoscenza dei supposti “segreti” nucleari dell’Iran. Ricercatore presso l’Università Malek Ashtar di Teheran, secondo alcuni collegata al Ministero della Difesa e al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, Amiri non avrebbe l’esperienza necessaria per entrare in contatto con i leader del programma nucleare e quindi non ne conoscerebbe sufficientemente le eventuali implicazioni.
Qualche indicazione in più sull’esilio volontario o forzato di Amiri negli Stati Uniti la si avrà forse dopo il suo arrivo in Iran, da dove mancava da oltre tredici mesi. Quel che è certo è che le polemiche attorno alla sua vicenda continueranno ad alimentare la guerra fredda in corso da tre decenni tra i due paesi nemici.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
L’ayatollah iracheno Muhammad Hussein Fadlallah, definito ufficialmente “terrorista” dal Governo USA nel 1995, si è spento lo scorso 4 luglio a settantacinque anni per un’emorragia interna. Il religioso sciita, assai popolare nel suo paese ed in tutto il Medio Oriente, viene comunemente considerato uno degli sponsor più blasonati (addirittura uno dei “padri spirituali”, per così dire) di Hezbollah, a dispetto del fatto che negli anni 90 i suoi rapporti con il movimento politico-militare fossero piuttosto tesi.
La sua “benedizione” all’attacco terroristico di Hezbollah alle caserme delle Forze di Pace del 23 ottobre 1983 (cinque tonnellate e mezzo di tritolo, trecento militari americani e francesi uccisi, una sessantina di feriti) non lo rende un personaggio simpatico - almeno in questa parte del globo, né particolarmente potabile per i funzionari delle cancellerie dei Paesi Occidentali (con qualche rilevante eccezione, come si vedrà oltre).
Racconta Robert Pollock, il giornalista del Wall Street Journal che lo intervistò nel marzo del 2009, che nei corridoi dei suoi uffici Fadlallah aveva appeso i ritratti di quelli che egli considerava “martiri” islamici: tra di essi, quello di Imad Mughniyah, peso massimo del terrorismo internazionale, assassinato dal Mossad (pare con la complicità di qualcuno dei “suoi” cui non era particolarmente simpatico) con una carica esplosiva nascosta nel poggiatesta dell’auto il 12 febbraio del 2008; quando Mughniyah, cui viene attribuito un lungo elenco di crimini terroristici ributtanti (tra cui l’ideazione dell’attacco del 23 ottobre 1983) morì, Fadlallah ne pianse la dipartita con le seguenti parole: “Oggi la resistenza ha perso uno dei suoi pilastri”.
Per completezza ed obiettività storica, sia pure nel sordido pantano del terrorismo e delle guerre di occupazione, occorrerà comunque aggiungere che lo stesso Fadlallah fu oggetto di un tentativo di assassinio organizzato dalla CIA con la complicità dei sauditi che, oltre a fallire l’obiettivo (anche se alcune delle sue guardie del corpo perirono nell’esplosione dell’autobomba, l’ayatollah si salvò), uccise 60 persone e ne ferì duecento; tutta gente che passava di là per caso o che era andata in moschea.
 Da un punto di vista politico, la scomparsa di Fadlallah coinciderà con un rafforzamento della stretta iraniana in Libano; considerazioni morali a parte, bisogna riconoscere che l’opposizione di Fadlallah alla Repubblica Islamica avrebbe costituito un’ottima carta per porre un limite alla nefasta influenza iraniana nel Paese dei Cedri: una carta che, tanto per cambiare, né gli USA né gli altri Paesi occidentali interessati a quello che accade in quell’area, hanno saputo giocarsi nel modo giusto. Come nota Pollock, infatti, Fadlallah non ha mai accettato la dottrina inventata da Khomeini e nota come “velayat-e faqih” (in persiano, “tutela dell’esperto della Legge”) secondo cui un giurista musulmano ha il diritto di bloccare qualsiasi legge del Parlamento che non sia perfettamente conforme alla sua propria interpretazione della shari’a (legge islamica): di fatto, la premessa all’imposizione di una teocrazia. “Sempre meglio l’influenza di Fadlallah rispetto a quella degli agenti iraniani che ora si presenteranno come i suoi eredi”, conclude Pollock.
Da un punto di vista politico, la scomparsa di Fadlallah coinciderà con un rafforzamento della stretta iraniana in Libano; considerazioni morali a parte, bisogna riconoscere che l’opposizione di Fadlallah alla Repubblica Islamica avrebbe costituito un’ottima carta per porre un limite alla nefasta influenza iraniana nel Paese dei Cedri: una carta che, tanto per cambiare, né gli USA né gli altri Paesi occidentali interessati a quello che accade in quell’area, hanno saputo giocarsi nel modo giusto. Come nota Pollock, infatti, Fadlallah non ha mai accettato la dottrina inventata da Khomeini e nota come “velayat-e faqih” (in persiano, “tutela dell’esperto della Legge”) secondo cui un giurista musulmano ha il diritto di bloccare qualsiasi legge del Parlamento che non sia perfettamente conforme alla sua propria interpretazione della shari’a (legge islamica): di fatto, la premessa all’imposizione di una teocrazia. “Sempre meglio l’influenza di Fadlallah rispetto a quella degli agenti iraniani che ora si presenteranno come i suoi eredi”, conclude Pollock.
A quanto pare, lo scomparso ayatollah era dotato di un carisma non comune: sono infatti ben due le professioniste (un’ambasciatrice e una giornalista della CNN) che hanno perso (o rischiato di perdere) il loro lavoro a causa dei commenti riservati alla memoria del religioso islamico subito dopo la sua scomparsa. Frances Guy, ambasciatrice del Regno Unito in Libano, nel suo blog ha così tratteggiato la figura del religioso: “Quando gli si faceva visita, si poteva esser certi di godere di un autentico dialogo, di uno scambio rispettoso di opinioni, e quando si andava via, si aveva la sensazione di essere una persona migliore. [...] Il mondo ha bisogno di più persone come lui, desiderose di spingersi oltre gli steccati delle diverse fedi”.
Sembra quasi incredibile che una persona di consumata esperienza, quale necessariamente deve essere quella che siede sulla poltrona attualmente occupata dalla signora Guy, possa lasciarsi andare ufficialmente a commenti di tale imbarazzante ingenuità. “Ciò non vuol dire”, conclude Pollock, “che qualsiasi commento positivo su quell’uomo debba automaticamente diventare off-limits”. Si noti che a dirlo è un giornalista non immune al fascino di Fadlallah, visto che nel suo pezzo fa sapere ai suoi lettori di quel “luccichio disarmante” che ha visto balenare negli occhi dell’anziano Fadlallah. Ma il mondo va in modo diverso da come vorrebbe Pollock e, ovviamente, la signora Guy ha dovuto ritrattare in fretta e furia per salvare il posto.
 Peggio è andata a Octavia Nasr, redattrice senior della CNN per il Medio Oriente, costretta a dare le dimissioni per aver postato sul suo account Twitter un commento nel quale manifestava il suo dolore per la scomparsa di Fadlallah, da lei salutato come “uno dei giganti di Hezbollah”. Tanto è bastato per farla cadere nella graticola sulla quale gli ultrà pro-Israele sono stati lieti di cacciarla, e dalla quale ha potuto liberarsi solo dopo aver lasciato la CNN.
Peggio è andata a Octavia Nasr, redattrice senior della CNN per il Medio Oriente, costretta a dare le dimissioni per aver postato sul suo account Twitter un commento nel quale manifestava il suo dolore per la scomparsa di Fadlallah, da lei salutato come “uno dei giganti di Hezbollah”. Tanto è bastato per farla cadere nella graticola sulla quale gli ultrà pro-Israele sono stati lieti di cacciarla, e dalla quale ha potuto liberarsi solo dopo aver lasciato la CNN.
Il caso della Nasr fa particolarmente riflettere: come nota acutamente Brian Whitaker, del Guardian, decano dei corrispondenti dal Medio Oriente, sono in parte anche i moderni giornali ad invitare i loro giornalisti a “sconfinare nei cosiddetti social media, per stabilire un rapporto più personale ed informale con i propri lettori”. Un’interessante innovazione, si dirà, anche se capace di trasformarsi in doccia fredda per tutti i lettori che vivono nell’illusione che il giornalista sia un essere privo di opinioni proprie sul materiale che “copre”. E certo mettersi alla prova su un social network basato sull’impossibilità di veicolare messaggi più lunghi di 140 caratteri è una bella sfida.
