- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Una recente, importantissima sentenza della Corte Suprema americana, ha messo ancora una volta in evidenza il pericoloso restringimento delle libertà individuali negli Stati Uniti in nome della lotta al terrorismo. Con una netta maggioranza, il tribunale costituzionale a stelle e strisce ha fissato una pesante limitazione alla libertà di parola dei cittadini, sancita dal Primo Emendamento della Costituzione, subordinandola alle necessità della sicurezza nazionale e al dettato delle leggi federali in materia di anti-terrorismo.
La disputa finita di fronte alla Corte Suprema (“Humanitarian Law Project contro Holder”) riguardava una serie di associazioni a difesa dei diritti umani, gruppi no-profit e singoli cittadini americani che, nel 2007, erano stati al centro di una sentenza della Corte d’Appello di San Francisco, con la quale veniva stabilita la non perseguibilità delle loro attività pacifiche a favore di organizzazioni bollate come terroristiche dal governo americano.
Tali attività riguardavano, in particolare, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) attivo clandestinamente in Turchia, e il gruppo nazionalista delle Tigri Tamil (LTTE) dello Sri Lanka, entrambi ufficialmente dichiarati organizzazioni terroristiche nel 1997 dall’allora Segretario di Stato di Bill Clinton, Madeleine Albright. Il lavoro svolto dagli attivisti americani a favore del PKK e delle LTTE consisteva esclusivamente in aiuti umanitari, consulenze legali per risolvere pacificamente i conflitti con le autorità governative e consigli per promuovere le rispettive cause presso organismi internazionali come le Nazioni Unite.
Secondo il governo, appellatosi alla sentenza dei giudici federali, queste attività pacifiche violano la legge sul terrorismo del 1996 (“Antiterrorism and Effective Death Penalty Act”), traducendosi in “supporto materiale” ad organizzazioni terroristiche straniere che possono mettere a rischio la sicurezza nazionale. Un punto di vista alquanto discutibile, fatto proprio dalla Corte Suprema, che ha così deciso che la legge in questione deve vietare non solo contributi in denaro, armi ed altri beni tangibili, ma anche la fornitura di “servizi”, “addestramento” e “consulenza legale” a scopi interamente pacifici.
Secondo il presidente del supremo tribunale americano, John G. Roberts, un supporto di questo genere “libererebbe altre risorse” all’interno delle organizzazioni terroristiche, favorendo il perseguimento di azioni violente, e “legittimerebbe gli stessi gruppi, mettendo a repentaglio le relazioni degli Stati Uniti con i paesi alleati”. Oltre al presidente, con la maggioranza hanno votato i tre giudici di estrema destra (Antonin Scalia, Clarence Thomas e Samuel Alito), il conservatore più moderato Anthony Kennedy e il progressista John Paul Stevens. Contrari si sono dichiarati invece gli altri tre giudici liberal, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor e Stephen Breyer.
A riassumere l’assurdità della sentenza è stato proprio il giudice Breyer, il quale, con una mossa insolita per la Corte Suprema, ha voluto leggere una parte dell’opinione della minoranza. Secondo Breyer, la maggioranza ha erroneamente messo sullo stesso piano il supporto “materiale” e quello “morale” o “umanitario”. Una collaborazione di quest’ultimo genere, infatti, rientra precisamente nelle protezioni garantite dal Primo Emendamento. La decisione della Corte Suprema, al contrario, rischia pericolosamente di limitare o punire la libertà di espressione se valutata pericolosa per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
 Ciò risulta tanto più grave se si pensa che la classificazione dei gruppi terroristici, o presunti tali, da parte di Washington risponde pressoché esclusivamente alle esigenze della politica estera americana. Solo per citare un paio di esempi, negli anni Ottanta, l’African National Congress che si batteva contro il regime di apartheid in Sudafrica rientrava nella categoria delle organizzazioni terroristiche, mentre al contrario i guerriglieri islamici che combattevano le truppe sovietiche in Afghanistan, da cui sarebbe nato il fondamentalismo legato ad Al-Qaeda, trovavano ampio sostegno negli USA.
Ciò risulta tanto più grave se si pensa che la classificazione dei gruppi terroristici, o presunti tali, da parte di Washington risponde pressoché esclusivamente alle esigenze della politica estera americana. Solo per citare un paio di esempi, negli anni Ottanta, l’African National Congress che si batteva contro il regime di apartheid in Sudafrica rientrava nella categoria delle organizzazioni terroristiche, mentre al contrario i guerriglieri islamici che combattevano le truppe sovietiche in Afghanistan, da cui sarebbe nato il fondamentalismo legato ad Al-Qaeda, trovavano ampio sostegno negli USA.
Lo stesso giudice Breyer ha offerto poi un altro confronto che rivela la pericolosa deriva sulla questione dei diritti civili degli ultimi anni. In passato, la Corte Suprema aveva cioè garantito le protezioni del Primo Emendamento anche ai cittadini americani aderenti al Partito Comunista, nonostante esso propagandasse il rovesciamento del governo statunitense.
Come previsto, le reazioni da parte delle organizzazioni umanitarie sono state molto dure. Con questa sentenza si rischiano fino a 15 anni carcere anche solo discutendo o parlando pubblicamente a favore di una delle organizzazioni sulla lista nera del Dipartimento di Stato americano. Secondo un avvocato difensore, la decisione della Corte in sostanza “rende un crimine il lavoro di quanti si battono per la pace e per il rispetto dei diritti umani”.
Il principio che l’interesse del governo nel combattere il terrorismo sia sufficiente per calpestare la libertà di parola prevista dal Primo Emendamento ha così ottenuto la suprema ratifica negli Stati Uniti. Ben poco rassicurante per le prospettive future sarà poi la prossima composizione della Corte Suprema, dal momento che la candidata a sostituire a breve il giudice John Paul Stevens è proprio il procuratore generale (“solicitor general”) Elena Kagan, la quale aveva appunto sostenuto le ragioni del governo in difesa della legge anti-terrorismo nel corso del dibattimento che ha preceduto la sentenza.
Il caso in questione, in definitiva, ha dimostrato come la Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, non fa altro che assecondare il progressivo attacco ai diritti democratici in corso negli Stati Uniti ormai da quasi un decennio. Un assalto iniziato dall’amministrazione Bush e portato avanti, senza distinzioni, anche dal presidente Obama.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Sul numero di Rolling Stones in edicola il 25 giugno verrà pubblicato un lungo articolo con cui il giornalista Michael Hastings ha tratteggiato un bel ritratto del Generale Stanley McChrystal, Comandante delle forze statunitensi in Afghanistan (USFOR-A) e dell'ISAF (International Security Assistance Force, anche se i soldati americani lo hanno soprannominato "I Suck At Fighting" - faccio la guerra da schifo, oppure "In Sandals And Flipflops", ovvero "in sandali ed infradito") - in poche parole, il capo di tutte le forze americane in Afghanistan. O, almeno, lo era, fino alle dichiarazioni su Obama e Afghanistan che gli sono costate il comando.
Eccellente pezzo di giornalismo in grado di coniugare l’analisi politica con lo studio psicologico del personaggio, in cui i fatti chiamano le valutazioni, senza per questo perdere il gusto per divertenti dettagli di colore. Un collage delle impressioni in presa diretta di Hastings, che ha ronzato attorno al generale per circa un mese, e delle opinioni (non di rado abrasive, sempre lontane dal protocollo) del suo variegato team (il cosiddetto "Team America"), da cui ha tratto il meglio dopo che una lunga serie libagioni li ha resi allegramente privi di freni inibitori.
Hastings è un giornalista di razza, un tipico rappresentante di quel giornalismo anglosassone, vivido ed obiettivo, che è l'invidia dei colleghi degli altri continenti. Particolare ammirazione suscita il sangue freddo con cui Michael ci racconta la guerra americana in Medio Oriente, che, tra le tante migliaia di vite innocenti, si è rubato l'amore della sua vita: la compagna Andrea Parhamovich, dipendente della sede di Baghdad del National Democratic Institute for International Affairs, uccisa a nemmeno trent'anni nel 2007 in un agguato terrorista diretto al convoglio su cui viaggiava.
Piaccia o meno ammetterlo, lo Stanley McChrystal di Hastings è un personaggio non comune. Figlio di un generale ed uscito negli anni Settanta da West Point con un punteggio di 299 (su 855), "una seria ipoteca per una persona che si è abituati a considerare brillante", al termine di un cursus honorum segnato da oltre cento ore di punizioni per ubriachezza e insubordinazione, ha dimostrato sin da giovane un vero talento nel rivoluzionare le organizzazioni obsolete, introducendo negli Anni Ottanta, da comandante del III battaglione dei Rangers corsi di MMA (mixed martial arts), marce con zaini pesanti e dotando tutti i soldati di visori notturni.
Pur non mancando di educazione giuridica e letteraria - ha studiato Scienze politiche e Relazioni internazionali ad Harvard e ha scritto diversi racconti - ha la meritata fama di "duro". E non solo grazie a quelle che si potrebbero bollare come gag alla Chuck Norris: il mito che si nutre con molta parsimonia è ben manutenuto, dato che lo stesso Hastings lo ha visto mettere qualcosa sotto i denti una sola volta nel corso del mese in cui lo ha frequentato per l'inchiesta. Inoltre, ha fatto fabbricare per una serie di nunchaku (coppia di corti bastoni da combattimento legati da una corta catena, arma tipica di diverse discipline marziali orientali) con su incisi il suo nome e le quattro stelle del grado, e sembra si trovi più a suo agio citando Bruce Lee che non Sun Tzu.
 E' stato capo della Joint Special Operations Command (JSOC), un gruppo di élite altamente letale, noto per aver ucciso o catturato migliaia di rivoltosi (tra cui Ab? Musab al-Zarq?w?, assassinato in un raid congiunto americano-giordano nel 2006). E’ stato implicato in alcune vicende non particolarmente commendevoli, perfino per un militare con un bel po' di pelo sullo stomaco come lui: la cortina di bugie attorno alla morte del caporale Pat Tilman, in realtà ucciso dal cosiddetto "fuoco amico", porta la firma di McChrystal, che è stato pure implicato in un caso di torture presso una prigione sotto il suo controllo, Camp Nama in Iraq.
E' stato capo della Joint Special Operations Command (JSOC), un gruppo di élite altamente letale, noto per aver ucciso o catturato migliaia di rivoltosi (tra cui Ab? Musab al-Zarq?w?, assassinato in un raid congiunto americano-giordano nel 2006). E’ stato implicato in alcune vicende non particolarmente commendevoli, perfino per un militare con un bel po' di pelo sullo stomaco come lui: la cortina di bugie attorno alla morte del caporale Pat Tilman, in realtà ucciso dal cosiddetto "fuoco amico", porta la firma di McChrystal, che è stato pure implicato in un caso di torture presso una prigione sotto il suo controllo, Camp Nama in Iraq.
A dispetto delle ombre, Hastings tiene a precisare che è stato proprio McChrystal ad emanare le direttive più severe finalizzate ad evitare morti di civili in Afghanistan: "E’ la matematica della rivolta: per ogni innocente che facciamo fuori, ci creiamo dieci nuovi nemici" - questo il pensiero alla base della "dottrina" MacChrystal. Chi si mette al volante dei convogli militari americani, dunque, eviti la guida spericolata per cui sono note le truppe americane nel paese, limiti netti per gli attacchi aerei, rarissimi i raid notturni. Pare che il comando ISAF abbia cominciato a prendere in considerazione metodi premianti per chi NON uccide gente; per quanto possa sembrare paradossale, si tratta di un potenziale salto quantico nelle strategie militari - un tipo di cambiamento intuitivamente non molto ben accolto in un contesto culturale dominato dalle due t (terrore e testosterone).
Hastings cita un episodio che completa il quadro di un uomo difficile da catalogare: mentre si trovava in un avamposto nei pressi di Kandahar, probabilmente anche allo scopo di dimostrare alla truppa il suo sangue freddo, MacChrystal riceve una mail da un soldato di 25 anni, Israel Arroyo, che gli muove un'accusa molto dura e diretta: "Le scrivo perché si dice che a lei non importi nulla dei soldati: con le sue direttive contro i danni collaterali ci ha reso molto più difficile difenderci". McChrystal risponde di persona e si presenta di persona alla postazione di Arroyo con una pattuglia appiedata - "non una dannata operazione di immagine a base di passeggiate al mercato con foto ricordo inclusa, una vera operazione in una zona di guerra altamente pericolosa" - chiosa Hastings (che ci sia un pizzico di agiografia o di colore narrativo o no, sono cose che colpiscono).
Quando il terzo uomo del gruppo dei 25 di cui fa parte Arroyo viene ucciso in un'azione di guerra, Arroyo scrive di nuovo al generale per sapere se si presenterà al funerale del compagno. McChrystal arriva il giorno successivo: organizza una riunione nella quale parla apertamente ai suoi uomini in un'atmosfera tesa, a dispetto della quale si sforza in ogni modo di motivarli ed incoraggiarli. Ammetterà con il giornalista, più tardi: "Questa è la parte filosofica della teoria della counterinsurgency che funziona tanto bene quando mi trovo davanti gente dei think tank... Ma mi pare non abbia un gran successo quando la propino alle truppe al fronte...". E proprio in questo paradosso insanabile, scambiare la violenza per diplomazia, sta il dramma (e il fascino un po' malato) di McChrystal.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Quando il 31 maggio scorso le forze armate israeliane si resero protagoniste del massacro sul convoglio umanitario “Freedom Flotilla” diretto a Gaza, l’Unione Europea si unì al coro di condanne levatosi da ogni angolo del pianeta. Alle proteste fecero seguito le richieste per un immediato allentamento del blocco esercitato da Tel Aviv sulla striscia di territorio palestinese. Durante questi eventi, tuttavia, la stessa Unione Europea stava valutando l’opportunità di assegnare un finanziamento di svariati milioni di euro alla principale compagnia israeliana che produce aerei da guerra utilizzati, tra l’altro, proprio per seminare morte e distruzione a Gaza.
I fondi che Bruxelles stanzierà a breve rientrano nell’ambito di 26 progetti di ricerca scientifici che la Commissione Europea sta tuttora vagliando. Se sono 34 le compagnie israeliane che fanno parte della rosa dei candidati a ricevere il denaro, è soprattutto su una che si è concentrata l’attenzione delle organizzazioni a difesa dei diritti umani. La compagnia in questione è la Israel Aerospace Industries (IAI), cioè la più importante produttrice di sistemi aerei per impiego civile e militare.
La IAI realizza per il mercato militare israeliano ed estero i famigerati droni, gli aerei senza pilota che vengono impiegati in azioni ricognitive e per condurre incursioni militari che dovrebbero teoricamente limitare le perdite civili. Il drone più conosciuto uscito dalle officine della IAI è il cosiddetto Heron, in grado di volare ad altitudini medie con un’autonomia di 52 ore. Proprio questo velivolo sarebbe stato massicciamente impiegato, in un sorta di test di collaudo, nel corso dell’aggressione israeliana alla striscia di Gaza tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009, causando circa 90 vittime civili.
Due sarebbero i progetti di partnership tra UE e IAI che hanno superato la prima fase del processo di approvazione da parte di Bruxelles e che aspettano ora il via libera definitivo. Il programma di ricerca della Commissione Europea prevede complessivamente uno stanziamento di 53 miliardi di euro per il periodo 2007-2013.
Come ha documentato l’agenzia di stampa IPS News, in corsa per i contributi europei ci sono anche altre compagnie che contribuiscono alle operazioni illegali di Israele nei territori palestinesi occupati. Una di esse è Afcon, compagnia produttrice di metal detector che vengono utilizzati nei check-point dell’esercito istituiti lungo il confine tra Israele e Gaza. La stessa Afcon un paio d’anni fa aveva inoltre ottenuto un appalto per installare un sistema di sicurezza in un progetto ferroviario destinato a collegare gli insediamenti israeliani illegali di Gerusalemme Est con il centro della città.
La particolare predisposizione dell’UE nei confronti di Israele è il risultato di una aggressiva azione di lobbying messa in atto da Tel Aviv negli ultimi anni ed è singolarmente andata di pari passo con il deteriorarsi dell’immagine di questo paese agli occhi dei cittadini europei. Per quanto, comprensibilmente, gli esponenti delle istituzioni comunitarie cerchino di minimizzare la generosità europea verso il business israeliano, i numeri parlano da soli. Secondo un giornale israeliano, le aziende di questo paese potrebbero beneficiare di 17 milioni di euro con la prossima quota di finanziamenti EU da erogare. Ciò porterebbe il totale dei fondi intascati a partire dal 2007 dalle compagnie israeliane grazie ai fondi per i programmi di ricerca europei a 290 milioni di euro.
 Alle critiche giunte da più parti, la Commissione Europea ribatte sostenendo che le cooperazioni scientifiche così promosse con Israele riguardano esclusivamente il settore civile. Ma è lo stesso governo di Tel Aviv a non farsi scrupoli nel propagandare gli stretti legami che intercorrono tra le aziende civili operanti nel settore tecnologico e le forze armate. In varie pubblicazioni governative, ad esempio, viene sottolineata addirittura la “simbiosi” tra il comparto tecnologico e quello della sicurezza nazionale in Israele.
Alle critiche giunte da più parti, la Commissione Europea ribatte sostenendo che le cooperazioni scientifiche così promosse con Israele riguardano esclusivamente il settore civile. Ma è lo stesso governo di Tel Aviv a non farsi scrupoli nel propagandare gli stretti legami che intercorrono tra le aziende civili operanti nel settore tecnologico e le forze armate. In varie pubblicazioni governative, ad esempio, viene sottolineata addirittura la “simbiosi” tra il comparto tecnologico e quello della sicurezza nazionale in Israele.
Allo stesso modo, alcune compagnie sulla lista d’attesa per i fondi UE hanno confermato come il loro lavoro finisca spesso per produrre innovazioni di cui si giova l’esercito. La filiale israeliana dell’azienda tedesca produttrice di software SAP fornisce alle forze armate israeliane una serie di “equipaggiamenti” speciali. Emza e LiveU, invece, realizzano strumenti di sorveglianza fortemente richiesti dai militari per le loro operazioni.
Se qualche eurodeputato ha fatto sentire la propria voce, protestando l’incoerente politica della Commissione Europea nei confronti di Israele, sembra improbabile che questo flusso di denaro possa essere ostacolato in futuro. Tanto più che molti paesi europei acquistano regolarmente aerei da guerra ed equipaggiamenti prodotti dalle stesse compagnie israeliane (testati a Gaza ed impiegati in Afghanistan). Pur lanciando critiche a livello ufficiale, insomma, l’UE finisce così per rendersi in qualche modo complice dell’occupazione e della repressione che i palestinesi continuano a subire per mano di Israele.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Per le donne e le ragazze somale il confine con il Kenya dovrebbe rappresentare la porta verso la salvezza, una via di fuga dalle barbarie della guerra e dalle violenze del fondamentalismo; per molte di loro l’ingresso in Kenya diventa invece una tragedia nella tragedia, un’esperienza allucinante fatta di minacce e di abusi. In un report di 99 pagine, intitolato “Benvenuti in Kenya”, abusi della polizia contro i rifugiati somali”, Human Rights Watch (HRW) denuncia gli atti compiuti dalle autorità keniote a danno di coloro che, in fuga dalla Somalia, cercano di raggiungere i grandi campi profughi di Dadaab: Hagadera, Ifo e Dagahaley.
Secondo i dati diffusi dalle Nazione Unite gli sfollati presenti in Somalia sono 1,3 milioni, 370 mila dei quali ospitati nel sovraffollato corridoio di Afgooye; 170 mila sono quelli che “in tempi migliori” hanno attraversato il Golfo di Aden e che hanno trovato “rifugio” in Yemen. In Kenya è presente più della metà dei 570 mila somali che dalla caduta del regime di Siad Barre (1991) ad oggi sono riusciti a lasciare il Paese: i tre campi di Dadaab ospitano circa 280 mila profughi, il 97% dei quali di origine somala.
Estorsioni, arresti arbitrari, detenzioni illegali ed un diffuso uso della violenza; sono queste le storie raccontate da HRW; uomini, donne e bambini che chiedono asilo e che in molti casi trovano una violenza ancor più feroce di quella che si sono lasciati alle spalle. Nel rapporto diffuso la scorsa settimana, l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani parla di un diffuso uso di procedimenti giudiziari illegittimi e di un racket di estorsioni che si estende per quasi 200 chilometri, dal centro di confine di Liboi fino a Dadaab e Garissa.
Pestaggi e fustigazioni, deportazioni illegali e decine di migliaia di persone respinte oltre frontiera perché non hanno sufficiente denaro per pagare la propria salvezza. Condizioni di vita inumane che si ripetono anche all’interno dei campi dove i più deboli, soprattutto le giovani ragazze, devono fare i conti con la violenza messa in atto dalla popolazione locale e dagli stessi rifugiati o con la prepotenza della polizia, che spesso chiude un occhio anche di fronte alle violenze sessuali. Le vittime sono infatti convinte che le autorità ignorano le loro denunce al solo scopo di proteggere gli aggressori che, corrompendo la polizia, vengono quasi sempre rilasciati.
Tra i 40.000 somali che nei primi quattro mesi del 2010 si stima abbiano cercato di attraversare il confine con il Kenya, si sono registrati decine di casi di estorsione e di soprusi; chi non è stato in grado di pagare è stato respinto o picchiato e incarcerato con la falsa accusa di ingresso e presenza illegale in territorio keniota. Per raggiungere i campi di Dadaab i profughi sono quindi spesso costretti ad usare sentieri secondari, lontani dalle strade principale, ma questo li espone alle aggressioni e agli assalti della criminalità comune che, oltre a rubare il poco denaro in loro possesso, si lascia andare ad atti di crudeltà e barbarie che non risparmiano le ragazze e le donne più giovani.
 “Welcome to Kenya” sostiene che, contro ogni norma del diritto internazionale, le autorità sottopongono i rifugiati a norme restrittive rigidissime e peraltro ingiustificate. Nonostante non ci siano problemi legati alla sicurezza nazionale o alla salute pubblica, la stragrande maggioranza dei somali registrati nei sovraffollati campi di Hagadera, Ifo e Dagahaley non può infatti allontanarsi dalle tendopoli e i pochi permessi speciali concessi dal governo sono rilasciati per recarsi a Nairobi per motivi medici o di studio. Tra i 300.000 rifugiati presenti a Dadaab, nel 2009 solo in 6.000 hanno potuto lasciare i campi regolarmente; chi viaggia sprovvisto del regolare permesso viene arrestato e, se non ha niente da offrire, viene tradotto a Garissa, dove viene multato o incarcerato.
“Welcome to Kenya” sostiene che, contro ogni norma del diritto internazionale, le autorità sottopongono i rifugiati a norme restrittive rigidissime e peraltro ingiustificate. Nonostante non ci siano problemi legati alla sicurezza nazionale o alla salute pubblica, la stragrande maggioranza dei somali registrati nei sovraffollati campi di Hagadera, Ifo e Dagahaley non può infatti allontanarsi dalle tendopoli e i pochi permessi speciali concessi dal governo sono rilasciati per recarsi a Nairobi per motivi medici o di studio. Tra i 300.000 rifugiati presenti a Dadaab, nel 2009 solo in 6.000 hanno potuto lasciare i campi regolarmente; chi viaggia sprovvisto del regolare permesso viene arrestato e, se non ha niente da offrire, viene tradotto a Garissa, dove viene multato o incarcerato.
A far si che si potesse assistere ad un tale scempio e che la tragedia di un popolo potesse diventare ancora una volta una grande macchina per fare soldi, hanno certamente contribuito le decisioni del governo keniota, che nel 2007 ha chiuso la frontiera con la Somalia e il centro di transito di Liboi, un posto di primo rifugio gestito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) dove si stima siano passati centinaia di migliaia di somali.
Dal 2007, per attraversare il confine, i profughi si sono perciò dovuti affidare alla clandestinità e la polizia ha iniziato a sfruttare questa nuova condizione, minacciandoli con arresti ed espulsioni per estorcergli denaro. Nonostante il diritto internazionale proibisca la deportazione e il respingimento forzato dei rifugiati, per ordinarne l’espulsione o l’arresto dei malcapitati le autorità keniote sono addirittura ricorse all’accusa di terrorismo o di appartenenza al gruppo integralista islamico Al-Shabaab. In realtà, secondo il Kenya Refugee Act, i profughi dovrebbero essere registrarsi e, indipendentemente dal modo in cui sono entrati nel Paese, dovrebbero ottenere asilo ed assistenza.
Dopo anni di guerra civile, carestie e disastri naturali, in Somalia la situazione è diventata insostenibile. La malnutrizione acuta colpisce il 17% della popolazione e il tasso di mortalità infantile è tra i più alti del mondo, con 225 bambini morti per 1000 nati vivi. Meno del 30% della popolazione ha accesso all’acqua potabile e questo influisce in modo determinante sulle cause principali di morte che, oltre alla guerra, sono la dissenteria, le infezioni respiratorie a la malaria. Tra i profughi di Dadaab le cose non vanno meglio: Hagadera, Ifo e Dagahaley ospitano il triplo della loro capienza massima e molti rifugiati vivono in una situazione di estrema precarietà, tra violenze e soprusi; uno scandalo che si nutre anche del complice silenzio della comunità internazionale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Alla chiusura delle urne per le elezioni presidenziali in Iran nel giugno del 2009, i candidati riformisti denunciarono immediatamente presunte irregolarità in un voto che, nonostante le aspettative alimentate nelle settimane precedenti, aveva decretato la vittoria a valanga del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Le proteste diedero vita a manifestazioni di piazza, creando il cosiddetto “movimento verde” che suscitò l’entusiasmo di buona parte dell’opinione pubblica occidentale.
A un anno di distanza dalle contestate elezioni, tuttavia, l’opposizione iraniana sembra aver perso completamente la propria spinta propulsiva, schiacciata non tanto dalla repressione governativa, quanto piuttosto dai propri errori e dallo stesso progetto politico sostenuto dai leader del movimento di protesta.
Gli scontri andati in scena a Teheran e nelle altre principali città iraniane misero di fronte migliaia di giovani e studenti ai temuti Guardiani della Rivoluzione per parecchie settimane dopo il voto. La durissima risposta del regime fece decine di morti e spedì nelle carceri politiche un numero imprecisato di manifestati. A guidare la protesta erano i candidati opposti al presidente uscente, l’ex primo ministro Mir-Hossein Mousavi e l’ex presidente del Parlamento Mehdi Karroubi. Malgrado le voci che segnalavano brogli diffusi, gli esponenti dell’opposizione non furono in grado di provare in maniera concreta che il voto era stato effettivamente falsato.
Nonostante il riconteggio ufficiale delle schede e svariate analisi indipendenti dei risultati, anche da parte di organizzazioni occidentali, confermarono il successo di Ahmadinejad con oltre il 62 per cento dei consensi, Mousavi e Karroubi - appoggiati dall’eminenza grigia dell’opposizione, Hashemi Rafsanjani, e dall’ex presidente riformista Mohammad Khatami - avrebbero continuato a chiedere alla guida suprema del paese, l’ayatollah Ali Khamenei, di annullare il voto e indire nuove elezioni.
Una nuova rivoluzione colorata, sul modello di quelle spesso fallite miseramente in alcune repubbliche ex sovietiche, sembrava essere così nata nella Repubblica Islamica. Pur mantenendo ufficialmente le distanze dalle questioni interne iraniane, gli Stati Uniti non esitarono a far sentire il loro sostegno, non solo morale, ad un’opposizione auspicabilmente in grado di rovesciare il regime e installare a Teheran un governo finalmente ben disposto verso l’Occidente e pronto ad aprirsi al mercato globale.
Il seguito che il movimento verde era riuscito a raccogliere all’indomani delle elezioni dello scorso anno sembra ora in gran parte scemato e i suoi leader indeboliti o profondamente screditati. Il mancato riconoscimento della sconfitta elettorale da parte di Mousavi è senza dubbio uno dei motivi del raffreddamento degli entusiasmi tra i sostenitori dell’opposizione. Ancora di più, le critiche rivolte dai riformisti alla politica economica ed estera di Ahmadinejad, hanno fatto riconsiderare a molti la validità delle posizioni da loro sostenute.
Mousavi aveva infatti attribuito i problemi interni all’Iran e il deteriorarsi dell’immagine diplomatica del paese all’estero alla politica del presidente in carica, trascurando le pressioni che l’Occidente ha esercitato su Teheran fin dal rovesciamento dello Shah nel 1979 e la progressiva campagna intimidatoria degli ultimi anni intorno alla questione del programma nucleare.
Il desiderio dei riformisti di normalizzare le relazioni con gli USA e i loro alleati si é scontrato insomma con la realtà dei fatti e con le scelte punitive fatte dall’Occidente nei confronti dell’Iran. L’ingenuità di Mousavi sembrava tanto più evidente nel ricordo della presidenza del riformista Khatami (1997-2005), ai cui segnali di distensione era seguita la netta chiusura di Washington.
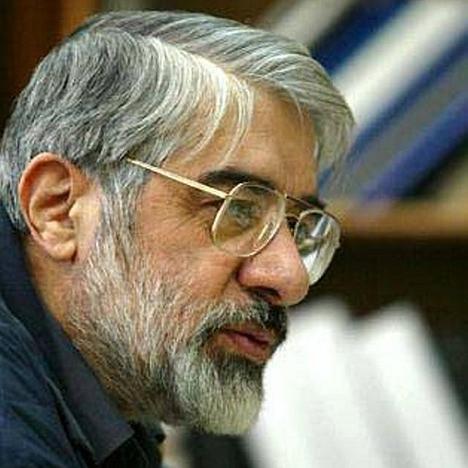 Il ruolo d’improbabile sostenitore dei valori democratici da parte di Mousavi, è stato poi fortemente minato dalle sue responsabilità nella repressione del dissenso durante gli anni da Primo Ministro tra il 1981 e il 1989. In ogni caso, però, a decretare il collasso del movimento verde è stato soprattutto il suo carattere classista e un’agenda economica marcatamente neo-liberista, connotati spesso sfuggiti anche alla sinistra europea e americana, apertamente schieratasi con l’opposizione iraniana.
Il ruolo d’improbabile sostenitore dei valori democratici da parte di Mousavi, è stato poi fortemente minato dalle sue responsabilità nella repressione del dissenso durante gli anni da Primo Ministro tra il 1981 e il 1989. In ogni caso, però, a decretare il collasso del movimento verde è stato soprattutto il suo carattere classista e un’agenda economica marcatamente neo-liberista, connotati spesso sfuggiti anche alla sinistra europea e americana, apertamente schieratasi con l’opposizione iraniana.
Fin dall’inizio, la base della protesta anti-governativa è stata rappresentata dalla classe media delle città iraniane. Per stessa ammissione di Mousavi, il movimento verde ha faticato a trovare sostegno tra le fasce più disagiate della società. Una responsabilità tanto più pesante, quanto i segnali di malcontento verso il governo tra i lavoratori e i poveri erano evidenti in seguito all’aumento della disoccupazione, al peggioramento delle condizioni di vita e alla progressiva soppressione voluta da Ahmadinejad dei sussidi statali ai prezzi di molti beni di consumo essenziali.
Già durante la campagna elettorale, Mousavi aveva inoltre definito i programmi sociali promossi dal governo come uno spreco di denaro pubblico che finiva per alimentare l’inoperosità degli strati più poveri della popolazione. Una caratterizzazione che non è sfuggita in particolare agli iraniani che vivono nelle aree rurali del paese. Già sospettosi verso le politiche liberiste avanzate dagli ex presidenti Rafsanjani e Khatami nel recente passato, essi hanno infatti votato a valanga per Ahmadinejad, snobbando un movimento di protesta che hanno visto appartenere esclusivamente alle élite urbane più agiate.
In definitiva, mentre la stella dell’opposizione verde a un anno dall’esplosione delle proteste è sempre più offuscata (tanto che alla vigilia del primo anniversario del voto contestato Mousavi e Karroubi hanno cancellato la prevista manifestazione di piazza) il governo di Ahmadinejad appare al contrario molto più solido sia sul piano interno che su quello internazionale. E, se pure persiste una certa insofferenza per un regime per molti versi repressivo, di fatto la situazione economica dell’Iran sembra reggere sia alla crisi che alle sanzioni occidentali.
Dal punto di vista diplomatico, infine, i recenti sviluppi intorno alla questione del nucleare hanno contribuito ad avvicinare non pochi paesi a Teheran - tra cui Brasile e Turchia, protagoniste di un recente accordo per l’invio dell’uranio iraniano all’estero per essere arricchito - mettendo in luce l’ottusità degli Stati Uniti e il doppio metro di giudizio adottato da Washington nel valutare le minacce agli equilibri internazionali (vedi Israele).
Più di tutto, però, e qualsiasi vera opposizione al regime dovrà tenerne conto, la legittimità del governo iraniano agli occhi dei propri cittadini deriva dalla capacità indiscutibile di scegliere il proprio percorso politico ed economico in maniera indipendente da qualsiasi potenza straniera. Non è tutto, ma non è poco.
