Politica
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Antonio Rei
di Antonio Rei
Tanti numeri, ma nessuna direzione chiara, se non quella scelta per il moribondo articolo 18. Il Presidente del Consiglio ha annunciato ieri durante l'incontro con i sindacati che la prossima legge di Stabilità conterrà una manovra da 23-24 miliardi. Di questi, sette serviranno a stabilizzare il bonus Irpef da 80 euro e uno ad allentare il patto di stabilità dei Comuni.
Le spese indifferibili come le missioni peseranno per quattro miliardi, mentre l'assunzione dei precari della scuola richiederà un miliardo e mezzo e la proroga al 2015 dell'ecobonus al 65% non dovrebbe costare più di 600 milioni. Agli ammortizzatori sociali sarà concesso un altro miliardo e mezzo, mentre resta da definire l'impatto di un eventuale primo intervento per anticipare il Tfr in busta paga.
Su questi due ultimi punti si misura tutta la vacuità e la miopia del programma economico renziano, oltre al talento dimostrato ancora una volta dal Premier nel prendere in giro gli italiani mentre finge di salvarli.
Come altro si può definire, se non come una canzonatura, quel miliardino e mezzo destinato agli ammortizzatori sociali? Non è nemmeno poco, è una somma ridicola. Per avere un termine di paragone è sufficiente dare un'occhiata all’ultimo Bilancio sociale Inps:?su una spesa di 22,7 miliardi versata nel 2012 per cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, la percentuale coperta da imprese e lavoratori è stata del 37,5% (8,5 miliardi), mentre il resto (62,3 %, pari a 14,3 miliardi) è stato a carico dello Stato.
Una vera riforma degli ammortizzatori sociali richiederebbe quindi all'incirca dieci volte la somma stanziata dal governo. Non si può fare, perché i soldi non ci sono, a meno di non sforare il beneamato tetto del 3% imposto dal trattato di Maastricht per il rapporto deficit-Pil. E noi non abbiamo alcuna intenzione di fare i cattivi bambini come i francesi: "Non ci tratti da studentelli", dice Renzi alla cancelliera Merkel, ma poi ubbidisce alla maestra e fa tutti i compiti a casa che gli vengono assegnati.
Veniamo ora al capitolo Tfr e chiariamo subito che con questa follia il Tesoro non c'entra. Anzi, i tecnici di Padoan - in prima battuta - hanno rigettato esplicitamente la paternità dell'iniziativa. L’idea è di anticipare nelle buste paga dei dipendenti del settore privato, a partire dal 2015, il Trattamento di fine rapporto (per intero o in parte). I lavoratori potrebbero scegliere se accettare o meno e l'anticipo avverrebbe grazie alla mediazione delle banche, che si sostituirebbero ai dipendenti nel ruolo di creditori delle imprese o dell'Inps. Da parte loro, le aziende e l'Istituto nazionale di previdenza continuerebbero a versare gli importi dovuti al termine dei rapporti di lavoro, come hanno sempre fatto, solo che darebbero quei soldi agli istituti di credito e non più ai lavoratori, che li avrebbero già incassati.
Da parte loro, le aziende e l'Istituto nazionale di previdenza continuerebbero a versare gli importi dovuti al termine dei rapporti di lavoro, come hanno sempre fatto, solo che darebbero quei soldi agli istituti di credito e non più ai lavoratori, che li avrebbero già incassati.
Con questo passaggio si eviterebbe di affossare i bilanci dell'Inps (che gestisce un fondo del Tesoro in cui le aziende con più di 50 dipendenti parcheggiano i Tfr lasciati in azienda dai dipendenti) e delle Pmi con meno di 50 dipendenti (che tengono in cassa i fondi dei Tfr). Non è chiarissimo cosa ci guadagnino le banche, perché pensare che lo facciano per amor di patria è assai complesso.
L'altro grande problema è fiscale. Ad oggi il Tfr gode di una tassazione privilegiata e il suo spostamento in busta paga rischia di aumentare il reddito, alzando così l'aliquota marginale Irpef. Risultato: su quei soldi, che sono già nostri, pagheremmo più tasse. Per evitare uno smacco simile a danno dei lavoratori il governo potrebbe scegliere la strada della ritenuta alla fonte o della tassazione separata rispetto allo stipendio, magari corrispondendo il Tfr in una sola busta paga l'anno.
Se anche tutte queste difficoltà tecniche fossero superate, tuttavia, rimarrebbe comunque un problema di prospettiva. Il Tfr può già essere anticipato al lavoratore, ma solo per l’acquisto della prima casa o per sostenere spese mediche. Insomma, la motivazione deve essere seria, altrimenti quei soldi non si toccano, sono una forma di risparmio forzato che servirà in futuro, quando il rapporto fra popolazione attiva e pensionati sarà più svantaggioso e il sistema previdenziale ancora meno sostenibile.
Anticipare il Tfr vuol dire trasferire il reddito futuro nel presente, scaricando il costo dei consumi di oggi sulle spalle delle future generazioni. Una specialità in cui l'Italia è campione del mondo. E dire che dovevamo cambiare verso.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Prima di uno scontro tra “vecchia guardia” e nuovisti, più che una divergenza sul tema dell'applicazione dell'articolo 18, lo scontro interno alla direzione del PD ha raccontato un dato difficile da confutare: Matteo Renzi è l’ultima, fastidiosa iperbole della vicenda politica italiana. Quella cioè che vede un uomo con idee di destra dirigere un partito che si vorrebbe del centrosinistra.
Bastava vederlo da Fazio, domenica scorsa, per cogliere questa semplicissima verità, che d’un tratto persino il solitamente fin troppo felpato Fazio è stato costretto a mostrargli, probabilmente infastidito dalla retorica berlusconiana del premier che, imitando Brunetta ripeteva come una litanìa come di tutto ciò che non va nel paese è colpa della sinistra e dei sindacati, lanciandosi in una appassionata difesa delle imprese.
Indicandone un modello buono a prescindere, con i padroni che vogliono bene ai loro dipendenti e che quindi devono sentirsi liberi di licenziare, è ansioso di dimostrare a chi conta che lui può riuscire dove altri hanno fallito: ridurre a zero i diritti dei lavoratori per ampliare ulteriormente i privilegi dei datori di lavoro. Il senso della sua agenda è qui.
Di Berlusconi, con il quale Renzi governa, ha ormai assorbito l’indecente naturalezza nel raccontare bugie clamorose, di dare numeri esistenti solo nella sua propaganda, d’inventare successi mai avuti o infilare luoghi comuni banali e mai dimostrati come fossero verità rivelate. I contenuti, la prosa torrenziale e priva di contenuto, l’ignoranza dei problemi e l’assenza di cultura generale, persino le pose sono ispirate al cavaliere, così come l’abitudine di dire di aver fatto cose che ha solo annunciato e di negare le responsabilità per quanto effettivamente fatto.
Vedendo Renzi da Fazio sembrava infatti di assistere a una delle comparsate di Berlusconi davanti alle telecamere; come il suo alleato accusava la sinistra di ogni sciagura, incluse le piogge acide. E quando Fazio obiettava che non capiva perché l’incerta ripresa economica dovesse essere pagata con la soppressione certa dei diritti, il premier mai eletto non riusciva a fornire risposte di merito.
 Quando parla di imprese è più marchionista di Marchionne, suo generoso mèntore (e non solo) e racconta la vicenda oscura e vergognosa della Fiat come Berlusconi raccontava del suo primo matrimonio; quando parla di sindacato ripete a memoria gli insegnamenti di Brunetta e Sacconi; quando parla di politica ripete quanto gli dice Verdini e quando parla di magistratura scimmiotta Alfano.
Quando parla di imprese è più marchionista di Marchionne, suo generoso mèntore (e non solo) e racconta la vicenda oscura e vergognosa della Fiat come Berlusconi raccontava del suo primo matrimonio; quando parla di sindacato ripete a memoria gli insegnamenti di Brunetta e Sacconi; quando parla di politica ripete quanto gli dice Verdini e quando parla di magistratura scimmiotta Alfano.
Particolarmente odioso ascoltarlo addossare ai sindacati e alla sinistra la precarietà del lavoro, come se le leggi che lo hanno inventato prima e trasformato in un modello poi fossero state scritte dalla CGIL e non dai suoi amici di Forza Italia. Fabio Fazio si è visto costretto a ricordagli garbatamente che lui in teoria sarebbe il segretario del partito della sinistra.
D’altra parte Renzi è un portatore sano di opinioni variabili: è quello che accusava Letta di governare con Alfano e ora lui c’ha aggiunto Berlusconi; accusava Monti e Letta di non essere stati eletti e lui non lo è mai stato, sosteneva l’intangibilità dell’articolo 18 che invece ora identifica con i mali dell’economia italiana. D’Alema sosteneva tempo addietro che la mescolanza tra la cultura socialista e cattolica voluta dagli inventori del PD era stata una pessima idea e su questo non ci piove: una fusione fredda, un esperimento di laboratorio sbagliato e dannoso, ma comunque fino a pochi mesi orsono orientato a mantenere un’idea progressista di società. Con Renzi è invece finita anche quella pallida intenzione.
Nel suo pedissequo peregrinare verso ogni posizione, purché di destra, emerge il suo fastidio istintivo non solo per il sistema di valori che ha fatto da sfondo alla storia del PCI da cui il PD comunque proviene, ma persino di quella storia della sinistra democristiana che nel PD ha inteso essere in qualche modo rappresentata. Una storia importante, che ha avuto in La Pira, Tina Anselmi, Donat Cattin, Aldo Moro, Luigi Granelli, Romano Prodi o nella stessa Rosy Bindi alcune delle personalità più rilevanti. E invece, la democristianità di Renzi é quella più destrorsa, innamorata dei tecnocrati e inginocchiata davanti a Washington; la democristianità gladiatoria e papalina, che vede nella sinistra il nemico giurato.
Renzi crede il mutamento dei rapporti politici debba produrre immediatamente quello del tessuto sociale. Qui vede la sua missione. Ritiene cioè che la crisi della sinistra debba essere confermata anche dalla rottura definitiva del patto sociale e costituzionale sui quali la società italiana si è costruita dopo la Liberazione e che la sinistra, moderata o radicale che sia, difende. Azzerare la rappresentanza politica del mondo del lavoro e le istanze di giustizia sociale ed eguaglianza non è sufficiente; si deve cancellare l’impianto giuridico e normativo che a sostenerli era stato voluto dai padri costituenti e, insieme, a quel complesso di disposizioni che tutelano i diritti del lavoro. Perché il permanere dei diritti dei lavoratori comporta anche, in automatico, quello di una dialettica nelle relazioni industriali che pone alle imprese di fronte anche alla loro responsabilità sociale e non solo alla ricerca del massimo profitto. E garantisce la piena libertà d’impresa sì, ma all’interno di un complesso di norme che la rendono compatibile con la i diritti e la libertà di tutti gli attori della scena sociale.
Perché il permanere dei diritti dei lavoratori comporta anche, in automatico, quello di una dialettica nelle relazioni industriali che pone alle imprese di fronte anche alla loro responsabilità sociale e non solo alla ricerca del massimo profitto. E garantisce la piena libertà d’impresa sì, ma all’interno di un complesso di norme che la rendono compatibile con la i diritti e la libertà di tutti gli attori della scena sociale.
Non può esserci, dunque, un doppio binario: i comportamenti illegittimi e illeciti devono essere sanzionati ovunque, aziende comprese. L’idea che il datore di lavoro sia il deux ex machina del modello produttivo, che possa permettersi tutto e il contrario di tutto senza per questo dover subire sanzioni a fronte di illeciti, è inconcepibile per quanti non hanno un’idea gerarchica e piramidale della società in spregio a qualunque idea di eguaglianza.
Renzi non è un uomo della sinistra e non è al servizio del Paese. E’ un uomo assetato di potere e dotato di una ambizione personale seconda solo all’ipertrofia del suo ego. Le sue idee, i suoi atteggiamenti, il suo modo di fare politica, la sua propaganda, sono una miscela di idee provenienti dalla destra demagogica in cui s’innesta una generale incompetenza del merito dei problemi che l’Italia ha di fronte. Incompetenza della quale è esempio recentissimo la sesquipedale sciocchezza del salario differito dato mensilmente, che provocherebbe spese insostenibili per le aziende e remissione in termini fiscali e previdenziali per i lavoratori.
La minoranza del PD può e deve votare contro in Senato e alla Camera alla porcheria del Jobs act, miscela di promesse irrealizzabili e guai facili e rapidi da realizzare. Dovrà chiedere i voti a Berlusconi se vuol applicare il programma di Berlusconi. Ogni altro ragionamento è aria fritta. Ogni altro distinguo sarebbe una moina.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Antonio Rei
di Antonio Rei
Matteo Renzi parla di "superare l'articolo 18" dello Statuto dei lavoratori, mantenendo il reintegro soltanto per i licenziamenti discriminatori e disciplinari. Il Premier attribuisce al chiacchierato articolo colpe gravissime: spaventa le imprese, frena gli investimenti e quindi la ripresa, ingessa il mercato del lavoro. Molti giovani gli danno ragione, nauseati dalla discussione infinita su qualcosa che non li riguarderà mai.
Sono i precari e i disoccupati nati negli anni Ottanta e Novanta, le generazioni che la Cgil e la Cisl hanno perso per strada. Alle loro orecchie la difesa dell'articolo 18 suona come operaismo anacronistico a tutela dei pochi fortunati che godono di un contratto a tempo indeterminato. La loro rabbia è comprensibile e giusta, ma hanno torto.
In primo luogo perché troppo spesso perdono di vista, come buona parte della classe politica, quello che nell'articolo 18 c'è scritto davvero. Purtroppo il testo non è facile da leggere, perché è lungo e scritto in legal-burocratese, lingua nemica dell'italiano e degli italiani. Ma c'è una frase chiave che non presenta alcuna difficoltà. Questa: "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso (...)annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro".
Vale a dire che l'articolo 18 impone il reintegro dei lavoratori licenziati ingiustamente. Non è vero che in Italia non si può licenziare: non si può licenziare ingiustamente. L'azienda non può mandare a casa qualcuno dicendo di avere problemi economici se in realtà non è vero. Non può liberarsi di un lavoratore sostenendo che si è comportato male se il comportamento in questione è inventato di sana pianta. Quanto al licenziamento discriminatorio, non serve nemmeno l'articolo 18 per vietarlo: è proibito dalla Costituzione e dal Codice Civile.
Tutto ciò implica anche l'altro lato della medaglia: le imprese possono licenziare per motivi economici se hanno davvero problemi con i conti, così come possono mandar via qualcuno per ragioni disciplinari se il lavoratore si è davvero comportato nel modo sbagliato. La realtà è già questa.
Bisogna ricordare poi che l'articolo 18 non è più un totem immodificabile ormai da qualche anno, dal momento che è stato cambiato con la riforma Fornero del 2012. In sintesi, la legge firmata dalla Professoressa stabilisce che in caso di licenziamento ingiusto per motivi disciplinari il giudice può imporre il reintegro con risarcimento oppure il pagamento di un'indennità risarcitoria; quanto ai licenziamenti ingiusti per motivi economici, il giudice può condannare l'azienda al pagamento di un'indennità in misura ridotta, ma se ritiene che il licenziamento sia "manifestamente infondato" può stabilire il reintegro.
Questa libertà di scelta non piace alle imprese, perché quasi sempre i giudici italiani scelgono il reintegro, ben sapendo che il lavoratore avrebbe difficoltà a ricollocarsi e che non merita di ritrovarsi in una posizione di così grande difficoltà, essendo stato licenziato ingiustamente.
 Ed è proprio contro questa libertà di scelta che Renzi intende scagliarsi, escludendo a monte l'opzione del reintegro per i licenziamenti ingiusti per motivi economici. Ciò significa che le aziende potranno mandar via chi vorranno sapendo in partenza che, se perderanno la causa, al massimo dovranno pagare un indennizzo. "E' una riforma molto più radicale della mia", ha commentato di recente Fornero in un'intervista a Linkiesta.
Ed è proprio contro questa libertà di scelta che Renzi intende scagliarsi, escludendo a monte l'opzione del reintegro per i licenziamenti ingiusti per motivi economici. Ciò significa che le aziende potranno mandar via chi vorranno sapendo in partenza che, se perderanno la causa, al massimo dovranno pagare un indennizzo. "E' una riforma molto più radicale della mia", ha commentato di recente Fornero in un'intervista a Linkiesta.
E' evidente che dopo il Jobs Act, se chiunque potrà essere licenziato ingiustamente, i contratti a tempo indeterminato avranno molto meno valore. Saranno meno convincenti anche agli occhi delle banche, quando si tratterà di decidere se concedere o meno un mutuo.
Ma di panzane sull'articolo 18 Renzi ne ha detta più d'una. Il primo settembre si espresse in questi termini: "Il problema non è l’articolo 18, non lo è mai stato... Ogni anno ci sono circa 40mila casi risolti sulla base dell’articolo 18, di questi l’80% sono risolti con un accordo. Ne restano 8mila, in 4.500 il lavoratore perde totalmente, in 3.500 il lavoratore vince e in due terzi dei casi ha il reintegro. Stiamo discutendo di una cosa importantissima che riguarda 3mila persone l’anno".
E' una sciocchezza evidente. Secondo i calcoli della Cgia di Mestre, su oltre 11 milioni di lavoratori dipendenti nel nostro Paese, più di sei milioni e mezzo lavorano per aziende con più di 15 dipendenti, soglia oltre la quale si applica l’articolo 18. La tutela interessa quindi il 57,6% dei dipendenti. Quanto al fatto che l'80% delle dispute si risolva ogni anno con un accordo, ciò avviene perché sullo sfondo esiste l'articolo 18. Se così non fosse, è facile prevedere che migliaia di trattative finirebbero in modo assai meno pacifico.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Un avviso di garanzia o, per certi versi, un avviso di sfratto. Questo il messaggio che Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, ha inoltrato al Premier a mezzo stampa il giorno dell’inaugurazione del nuovo formato tabloid. Il quotidiano di Via Solferino, espressione dei poteri forti italiani, organo per definizione dell’establishment industriale e finanziario del Paese, è da sempre ultragovernativo e si caratterizza per un stile “british”, poco incline alle intemerate. Fedele al suo stile, è tutt’altro che frequente leggere in prima pagina sul Corriere della Sera un editoriale del Direttore e, men che mai, un intervento di tale nettezza. Toni durissimi, accuse precise e da molti condivise, fuori e dentro al Palazzo.
“Renzi non mi convince”, comincia De Bortoli. Così il Premier viene immediatamente avvertito, sin dall’incipit, che chi scrive non gradisce di lui quasi niente: la tendenza smaccata al decisionismo in solitaria, la debolezza disarmante di alcuni esponenti del suo governo, per i quali pare essere la fedeltà a lui l’unica reale caratteristica e sui quali pesa, inoltre, l’appartenenza alla sua Regione come ulteriore segno distintivo.
Difficile dare torto su questo a De Bortoli: vedere la Madia, la Mogherini o Poletti occuparsi di dicasteri strategici non è affatto rassicurante, se non per Renzi stesso, che evita come la peste le personalità in grado di fargli ombra. D’altra parte, la linea del governo è ormai appannaggio degli uomini di Forza Italia, che non si vergognano di evidenziare ogni singolo passaggio del patto del Nazareno tra il pregiudicato e lo spregiudicato.
Ed è per questo che, in un crescendo rossiniano, De Bortoli, dopo averlo invitato a correggere toni ed errori che fanno di Renzi stesso il peggior nemico di Renzi, arriva alla bordata più pesante, chiedendo di “chiarire tutti i contenuti del Patto del Nazareno, liberandolo da vari sospetti (riguarda anche la Rai?) e, non da ultimo, dallo stantio odore di massoneria”.
L’attacco violentissimo al bullo vanesio di Palazzo Chigi arriva proprio il giorno in cui Renzi si pavoneggiava negli Stati Uniti, dove si è esibito al cospetto della famiglia Clinton e con Obama, con imprenditori statunitensi e quindi intervenendo all’ONU. E per quanto abbia continuato a sostenere la parte del duro che sfida venti e maree per imprimere l’ennesima torsione del sistema di garanzie e diritti chiamandola "riforme", non c’è dubbio che il colpo sia arrivato. Difficile archiviare l’editoriale di De Bortoli come un qualunque articolo di critica, difficile non vedere come il giornale da lui diretto, finora accomodante al limite della piaggeria, abbia inaugurato - stavolta davvero - un cambiamento di verso.
Il riferimento alla massoneria è direttamente rivolto alla sua corrente più importante, quella angloamericana, che ha espresso la maggior parte delle presidenze a stelle e strisce sin dalla sua fondazione (e, in alcuni momenti, dell’intero blocco occidentale) e non può sfuggire come il legame del Premier con Verdini (indagato per la loggia P4) e l’ormai co-governo con Berlusconi a tutto servano meno che a porre interrogativi in questo senso. E la smaccata, assoluta obbedienza dell’ex sindaco di Firenze nei confronti della linea statunitense sia in politica estera globale sia in Europa, fin troppo semplice da riscontrare, aumenta esponenzialmente i sospetti. Soprattutto quando, in opposizione agli interessi italiani, Renzi dapprima impone la sconosciuta Mogherini nel ruolo di lady Pesc, che non serve all’Italia ma è l’unico ruolo che interessi agli Stati Uniti, per mantenere sotto controllo la politica estera europea.
Soprattutto quando, in opposizione agli interessi italiani, Renzi dapprima impone la sconosciuta Mogherini nel ruolo di lady Pesc, che non serve all’Italia ma è l’unico ruolo che interessi agli Stati Uniti, per mantenere sotto controllo la politica estera europea.
Quindi, anche qui in opposizione agli interessi italiani, dispone l’adesione dell’Italia all’embargo antirusso, causando un ulteriore, violentissimo trauma all’economia delle nostre aziende esportatrici, con ricadute negative sul piano occupazionale nei settori calzaturiero, del pellame e ortofrutticolo e producendo danni per miliardi di euro.
Sul piano più interno la volontà di scontro contro tutti e tutto non è certo un elemento secondario nel j’accuse del direttore del Corsera. Oltre al pasticcio incostituzionale della riforma del Senato, che difficilmente vedrà comunque la luce, ci sono i numeri della nostra economia, che peggiorano sensibilmente da quando il bullo siede a Palazzo Chigi.
A questo quadro già drammatico si sommano gli annunci mai seguiti da fatti, le figuracce inanellate con i contratti della Pubblica Amministrazione e altri provvedimenti rimangiati, nella generale sensazione della navigazione a vista con un equipaggio di mozzi improvvisatisi capitani.
E a far traboccare il vaso dal punto di vista dei poteri forti italiani arriva la volontà di sopprimere l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che crea le condizioni per un nuovo scontro sociale di cui l’establishment italiano farebbe volentieri a meno. Persino i suoi amici Farinetti e Della Valle fanno eco al presidente di Confindustria Squinzi affermando che l’articolo 18 non è un obiettivo per nessuno. Addirittura Farinetti sostiene che andrebbe mantenuto.
Insomma, sull’articolo 18 si rischia uno scontro non richiesto nemmeno dagli industriali, anche perché oltre a riaprire una possibile stagione di conflitto, contribuisce ad aprire una spaccatura all’interno dei DS, considerati ormai dall’establishment italiano l’unica forza politica abile all’interlocuzione con le forze sociali, l’unico possibile elemento di mediazione nella società italiana dopo la definitiva scomparsa della destra. Una rottura interna al PD e SEL, con i 5Stelle fuori gioco, aprirebbe inevitabilmente le porte a un ritorno di Berlusconi nella maggioranza parlamentare di governo, con il risultato di andare verso lo stallo del sistema politico mentre ancora non è stata votata la legge elettorale con la quale si dovrebbe votare.
Le reazioni dell’establishment politico e finanziario italiano non sono ancora evidenti ma De Bortoli, che lascerà il Corriere nella prossima primavera, non sembra isolato. Sullo sfondo del fallimento di Renzi, che ha perso solo negli ultimi due mesi il 15% nei sondaggi, il sistema avverte come possibile una crisi politica senza uscita che rischierebbe di vedere l’arrivo della troika in Italia, cosa che, come ricorda De Bortoli, l’Italia non vuole assolutamente. A difendere il premier scende in campo Marchionne, antico idolo di Renzi. L’AD di Fiat spiega che Renzi va sostenuto e, addirittura, “aiutato finanziariamente”, mentre sono in molti a cedere che l’attacco virulento di Renzi alla minoranza del PD abbia tra i suoi scopi anche uno tutto interno: o l’umiliazione della minoranza con le ovvie ricadute sul suo potere interno o, nel caso l’opposizione venisse confermata, il favorire una scissione che consegni a lui il dominio incontrastato del maggior partito italiano e che, dato il generale sfilacciamento delle forze politiche, renda comunque impossibile aggregazioni di sostanza numerica e politica in grado di far nascere un competitor a sinistra.
A difendere il premier scende in campo Marchionne, antico idolo di Renzi. L’AD di Fiat spiega che Renzi va sostenuto e, addirittura, “aiutato finanziariamente”, mentre sono in molti a cedere che l’attacco virulento di Renzi alla minoranza del PD abbia tra i suoi scopi anche uno tutto interno: o l’umiliazione della minoranza con le ovvie ricadute sul suo potere interno o, nel caso l’opposizione venisse confermata, il favorire una scissione che consegni a lui il dominio incontrastato del maggior partito italiano e che, dato il generale sfilacciamento delle forze politiche, renda comunque impossibile aggregazioni di sostanza numerica e politica in grado di far nascere un competitor a sinistra.
Un disegno ambizioso che avrebbe diversi sostenitori, ma tutti oltreoceano. In Europa, dove Berlino e Parigi ritengono di aver bisogno anche di Roma per disputare la partita dell’egemonia condivisa con Washington, si pensa che Renzi possa portare allo sfascio l’Italia, con il risultato di mettere in difficoltà l’intera economia europea. Dal punto di vista dei poteri forti europei, Renzi non è una minaccia per l'impronta liberista delle politiche economiche, ma potrebbe comunque ostacolare le manovre continentali, anche a causa di un'assai limitata sapienza politica, sua come della sua squadretta scombinata dove nessuno sa cosa dire e cosa fare.
Vista da Bruxelles, Draghi potrebbe agevolmente guidare il governo italiano, così abbandonando la poltrona di Presidente della BCE, dove siederebbe un nuovo presidente molto più sensibile alla linea finanziaria tedesca. E Renzi potrebbe tornare alle sue amate comparsate televisive. Stavolta, però, in seconda serata.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
L’abolizione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori è una porcata peggiore di quella della legge elettorale. Che il decreto che vorrebbe abolirlo parli di “tutele crescenti” è poi un paradosso verbale simile a quello delle guerre umanitarie. Le tutele non s’intravedono e, a fare attenzione, si scopre che manca completamente il riferimento al numero di anni d’impiego oltre le quali scatterebbero. C’è una rappresentazione paradossale in tutta la vicenda che recita come la generazione di lavoro passi per la facilità a perderlo. E, non bastasse, i nuovi rapaci del renzismo vorrebbero convincerci che l’articolo 18 impedisce la piena uguaglianza dei lavoratori.
E’ falso, ovviamente. Renzi, da parte sua, ne fa una ragione di sopravvivenza. Se vuole evitare l’offensiva decisa di Bruxelles sui conti pubblici italiani (che da quando lui è a Palazzo Chigi peggiorano vorticosamente) deve dare qualcosa ai teorici della fine della civiltà del lavoro. D’altra parte, il senso di Renzi è qui: non solo annuncia ciò che non realizza, ma realizza quello che negava di voler fare.
Cosa prevede l’articolo 18, che a sentire i cantori del comando padronale impedirebbe un meraviglioso destino per il mondo del lavoro? Prevede che nelle imprese con più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, il lavoratore che venisse ingiustamente licenziato possa rivolgersi al giudice che, se lo ritiene vittima di una misura vessatoria, può annullare il provvedimento e ordinarne il reintegro al posto di lavoro.
Attenzione: non sono considerati in questa fattispecie i licenziamenti dovuti a stato di crisi, comportamento illegale o sleale del lavoratore, ristrutturazioni aziendali, cessioni di ramo d’azienda, dismissione o cessione della stessa; l’articolo 18 si applica solo quando un licenziamento viene comminato con arbitrarietà, con spirito vendicativo o ricattatorio; insomma quando è privo di ragioni corrette, quando cioè è ingiusto e discriminatorio.
Abolirlo, quindi, significa in primo luogo voler azzerare la dialettica interna alle aziende tra padroni e lavoratori, abolire il confronto anche quando è ormai tra cannoni e campane, inserire l’arbitrarietà, l’ingiustizia e la discriminazione nel novero dei comportamenti leciti per il datore di lavoro (possibili lo sono sempre stati).
Infine si dice che in un paese con svariati milioni di partite Iva, essendo l’art.18 applicabile solo alle medie e grandi imprese, la sua abolizione non costituirebbe un danno poi così rilevante per l’insieme della forza lavoro impiegata. E’ vero, molte delle piccole imprese sono a carattere familiare e dunque lì il problema nemmeno si pone. Ma se davvero così fosse, se davvero la sua abolizione non avrebbe ripercussioni sostanziali, perché allora tanta pervicacia nel volerlo cancellare?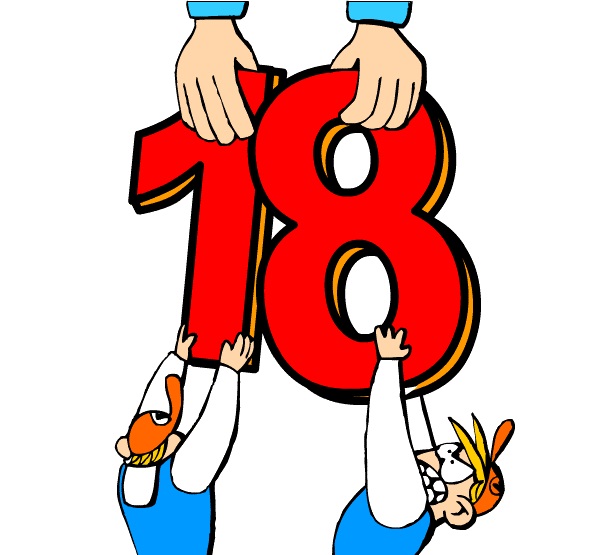 Denunciare le diverse condizioni di chi può appellarsi all’articolo 18 e chi no, è la scoperta dell’acqua calda: non solo perché ormai il contratto a tempo indeterminato è una chimera o quasi, ma anche perché in buona parte il governo Monti (la cui agenda è stata copiata e incollata da Renzi) ha già parzialmente modificato la norma, dal momento che in diversi casi l’indennizzo con 12-24 mesi di salario può sostituire il reintegro. Ma perché allora, se il fine è quello di equiparare le sorti di tutti i lavoratori proprio per quel senso di giustizia con cui Renzi si addormenta e si sveglia insieme al tweet d’ordinanza, non lo estende a tutti?
Denunciare le diverse condizioni di chi può appellarsi all’articolo 18 e chi no, è la scoperta dell’acqua calda: non solo perché ormai il contratto a tempo indeterminato è una chimera o quasi, ma anche perché in buona parte il governo Monti (la cui agenda è stata copiata e incollata da Renzi) ha già parzialmente modificato la norma, dal momento che in diversi casi l’indennizzo con 12-24 mesi di salario può sostituire il reintegro. Ma perché allora, se il fine è quello di equiparare le sorti di tutti i lavoratori proprio per quel senso di giustizia con cui Renzi si addormenta e si sveglia insieme al tweet d’ordinanza, non lo estende a tutti?
Si afferma poi che l’abolizione dell’articolo 18 potrà finalmente riaprire il mercato del lavoro, giacché le aziende, liberate dall’incubo dell’art.18, potranno riprendere ad assumere a tempo indeterminato. E come mai, se la sostanziale abolizione del diritto al reintegro è già vigente da due anni la disoccupazione cresce? Mettere in relazione diretta la crisi occupazionale con la fine delle tutele per i lavoratori è operazione di pure propaganda ideologica.
Le aziende non assumono perché non investono, non hanno idee, non hanno liquidità, non fanno ricerca, non costruiscono innovazione di prodotto, non ottengono accesso al credito, non riescono a riscuotere i crediti che vantano dalla Pubblica Amministrazione, subiscono una tassazione del lavoro insopportabile, vengono vessate da una burocrazia onnivora e dall’assenza d’interlocuzione politica sul territorio dove operano. Non c’entra niente o quasi l’articolo 18.
E non è nemmeno vero che il datore di lavoro non ha interesse ad avere la libertà di licenziamento, perché “se il lavoratore produce è interesse dell’imprenditore tenerlo”. E’ un altro luogo comune fondato sulla falsità. Il padrone è alla ricerca continua di migliorare i margini operativi e, in assenza di qualità del prodotto, prova ad erodere i diritti dei lavoratori e i costi che li accompagnano.
Il lavoratore, pur se capace, rischia comunque di essere licenziato non appena il padrone individua la possibilità di pagare il suo stesso lavoro ad un costo più basso, sia attraverso l’assunzione di una persona diversa al posto di chi c’era prima, sia con l’introduzione di nuove tipologie di contratto ancor meno costose. Il lavoratore, a quel punto, se legalmente indifeso davanti all’ingordigia e all’arroganza padronale, avrà solo due strade: accettare riduzioni di salario e aumento dei carichi di lavoro oppure andarsene senza nessun indennizzo. La competizione vera diventa solo quella tra chi ha niente e chi solo la disperazione. La giungla è servita.
Non c’é solo, come dice la Camusso, lo “scalpo” da consegnare ai tecnocrati europei. E’ molto di più e anche senza le pressioni della Commissione europea il tormentone della destra vera e di quella travestita di sinistra sarebbe comunque in scena. Quello che si vuole cancellare è l’idea stessa dei lavoratori come detentori di diritti, delle aziende come luogo della società e ad essa soggette per leggi e norme. Il sogno è quello delle "zone franche", dove la legge non entra per legge.
Si vuole abolire la possibilità che di fronte ad una ingiustizia ci si ribelli, che si possa ricorrere alla giustizia; c’è dietro l’idea non confessata (ma basta aver pazienza e l’ascolteremo) della sostanziale inutilità di tutto lo Statuto dei lavoratori in quanto anacronistico. Perché frutto dei rapporti di forza tra le classi di quando esistevano sinistra e sindacati, dunque inutile oggi che le due entità sono rispettivamente scomparse o in crisi profonda.
 Questo è il momento della rivincita storica dei padroni e dei politici a loro libro paga: approfittare delle definitiva scomparsa delle idee, dei progetti e dei sogni d’uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale seppelliti sotto il cadavere della sinistra per rimettere il lavoro sotto il tallone del padronato, unico delle componenti sociali a poter disporre di scelte, diritti e privilegi.
Questo è il momento della rivincita storica dei padroni e dei politici a loro libro paga: approfittare delle definitiva scomparsa delle idee, dei progetti e dei sogni d’uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale seppelliti sotto il cadavere della sinistra per rimettere il lavoro sotto il tallone del padronato, unico delle componenti sociali a poter disporre di scelte, diritti e privilegi.
Del resto, è quanto già successo con il welfare: una costruzione di sistema di garanzie individuali e diritti sociali a carattere universale che il padronato dovette ingoiare solo per fermare le spinte progressiste e rivoluzionarie che dal dopoguerra alla fine degli anni ’70 correvano per l'Europa. Il welfare era concepito dal padronato come un obbligatorio strumento di battaglia ideologica contro la minaccia dell’estensione sempre più ampia dell’idea di un socialismo possibile. Venuto meno il mondo bipolare, scomparsa dall’orizzonte “la grande minaccia” e scomparsa la sinistra, di quel sistema universale di garanzie si fa volentieri a meno smontandolo progressivamente.
Anzi, proprio sulle ceneri del sistema di garanzie pubbliche s’innesta nei servizi l’irruzione delle nuove forme di accumulazione per aziende private: istruzione, trasporti, salute, pensioni, assistenza, sono ogni giorno meno pubbliche e più private, meno universali e più di censo. Ma togliendo dai diritti pubblici le prestazioni, non viene meno l’esigenza delle stesse, solo le si appaltano ai privati che vi lucrano. Il principio di accumulazione, nella crisi determinata dalla guerra del capitale contro il lavoro, ha proprio nella privatizzazione dei servizi una delle leve maggiormente significative per i profitti. E’ questo il fulcro su cui si regge il nuovo patto sociale.
Non sarà comunque, se passerà, l’abolizione dell’articolo 18 a riuscire a trasformare un capitalismo senza capitali in imprenditoria capace di generare lavoro. Non sarà l'italico capitalismo di relazione (così si chiama quello degli squattrinati che si sentono signori) a poter ricollocare l’economia italiana sotto il segno della crescita. Solo un grande piano d’investimenti pubblici e un’inversione brusca della pressione fiscale tra attività finanziaria e produzione industriale potrebbe innescare la marcia giusta. Quello sull’articolo 18 non è altro che odio di classe.
