Politica
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Su La Stampa dello scorso sabato, il parlamentare Pd Stefano Esposito ha pubblicamente manifestato le sue riserve sulle capacità e i titoli dei 360 accademici che a febbraio hanno firmato l'appello al premier Monti per riconsiderare il progetto dell'Alta Velocità. Secondo Esposito - noto alle cronache per la proposta di non rinnovare la tessera del Partito Democratico a chi si fosse opposto alla TAV- il campione non è assolutamente rappresentativo, né competente in materia di ferrovie: “Soltanto il 14% svolge attività accademiche attinenti alla realizzazione della Torino-Lione e comunque si tratta appena dello 0,17% del totale degli accademici italiani accreditati al ministero”.
Probabilmente l'uscita del parlamentare Pd era solo un tentativo di fare pubblicità al suo libro - il controverso Tav Si, scritto a quattro mani con Mario Foietta e contestato duramente al salone del libro di Torino - dal momento che, stando al suo diploma di istituto magistrale, lui stesso non avrebbe né i titoli, né le competenze adeguate per parlare con cognizione di causa della Tav. Figurarsi scriverci un intero libro.
Ma non sottilizziamo, il livello scolastico spesso non è indicativo del valore di una persona ed era lo stesso Leonardo Da Vinci a dire che la sapienza è figlia dell'esperienza. Purtroppo però Stefano Esposito pare mancare anche di questa. L'Alta Velocità in Italia infatti non è nata con la Torino-Lione e sono già diverse le tratte completate: ogni singolo progetto ha avuto esternalità negative ma in nome del “progresso” si è comunque deciso di tirare dritto e di ignorare ciò che le precedenti esperienze avevano insegnato.
Per quanto riguarda le ricadute della TAV sul sistema idrogeologico del territorio, l'esperienza del Mugello è certamente paradigmatica. I lavori per la tratta Bologna-Firenze hanno lasciato dietro di sè 57 km di torrenti che in estate sono un deserto di sassi, 73 sorgenti e 45 pozzi prosciugati, cinque acquedotti oggi riforniti con un costosissimo sistema di ripompaggio a monte, e una delle gallerie ha fatto persino scomparire un intero fiume.
Un vero e proprio disastro ambientale, valutato in 174 milioni di euro dai consulenti della Procura di Firenze all’interno del processo che ha visto imputate 59 persone - tutte clamorosamente assolte in appello lo scorso giugno - fra dirigenti dell’impresa Cavet a cui sono stati affidati i lavori, imprenditori, proprietari di discariche e trasportatori.
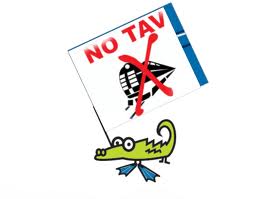 Il futuro della valle di Susa non si prospetta certo più roseo. In primo luogo perchè le montagne sono più alte, con cumuli e pressioni maggiori, poi perché il Piccolo ed il Grande Moncenisio sono costituiti prevalentemente da gessi che hanno creato enormi inghiottitoi carsici. Tutta la montagna ospita laghi fossili sotterranei, il più superficiale dei quali (16 milioni di metri cubi d'acqua) fu intercettato a Venaus dai lavori della centrale di Pont Ventoux, che penetrarono nella montagna per meno di un chilometro. La rete idrica del gruppo del Moncenisio é quindi estesissima e connessa: i traccianti gettati nel 1970 nella grotta del Giasset, uscirono pressoché dovunque solo dopo due settimane, a conferma che avevano attraversato grandi laghi sotterranei.
Il futuro della valle di Susa non si prospetta certo più roseo. In primo luogo perchè le montagne sono più alte, con cumuli e pressioni maggiori, poi perché il Piccolo ed il Grande Moncenisio sono costituiti prevalentemente da gessi che hanno creato enormi inghiottitoi carsici. Tutta la montagna ospita laghi fossili sotterranei, il più superficiale dei quali (16 milioni di metri cubi d'acqua) fu intercettato a Venaus dai lavori della centrale di Pont Ventoux, che penetrarono nella montagna per meno di un chilometro. La rete idrica del gruppo del Moncenisio é quindi estesissima e connessa: i traccianti gettati nel 1970 nella grotta del Giasset, uscirono pressoché dovunque solo dopo due settimane, a conferma che avevano attraversato grandi laghi sotterranei.
A confermare i dubbi e i timori degli attivisti No Tav e dei valsusini in generale, negli anni si sono susseguiti diversi rapporti, studi e stime di danno, primo tra tutti il cosiddetto rapporto COWI del 2006, redatto per conto della Commissaria europea De Palacio. Nonostante la committente fosse la stessa Commissaria europea per la costruzione di questa linea, gli esperti da lei interpellati non hanno potuto omettere che il solo tunnel di base drenerà da 60 a 125 milioni di metri cubi di acqua all’anno, una cifra che corrisponde al fabbisogno idrico di una citta? con un milione di abitanti.
Dal momento che l’acqua drenata é riversata nei fiumi, è possibile che a una certa distanza a valle del tunnel, lo scorrimento su un periodo di un anno non subisca influssi di rilievo, almeno per quanto riguarda la portata. Almeno, perché le risorse idriche catturate all’interno della montagna e drenate direttamente all’esterno, saranno calde e con concentrazioni di solfati ben oltre i limiti accettabili per essere immessi nei corsi d’acqua, col risultato che i fiumi sarebbero sì pieni d'acqua ma irrimediabilmente inquinati.
Per le zone situate a monte delle estremità del tunnel, la portata totale delle acque di superficie, e in particolare il flusso minimo annuo, potrebbe invece essere pesantemente modificata e quindi la ripartizione fra acque di superficie e sotterranee potrebbe cambiare radicalmente. Un problema non da poco, visto che l'acqua è un elemento primario e imprescindibile per tutta una serie di attività: dall'acqua corrente nelle case all'irrigazione dei campi, dal buon funzionamento del sistema fognario alla produzione di energia.
 La sottrazione di enormi quantitativi di acqua al gruppo del Moncenisio e dellAmbin avrà infatti inevitabili effetti anche sull’alimentazione del lago del Moncenisio. Il lago attuale alimenta una centrale da 360 MW in Francia e da 240 MW in Italia. Se il deficit indotto fosse di 25 milioni di metri cubi, in termini energetici questi significherebbero la perdita di circa 150 milioni di Kwh di energia di punta che andrebbero messi anch’essi tra i danni causati dal progetto.
La sottrazione di enormi quantitativi di acqua al gruppo del Moncenisio e dellAmbin avrà infatti inevitabili effetti anche sull’alimentazione del lago del Moncenisio. Il lago attuale alimenta una centrale da 360 MW in Francia e da 240 MW in Italia. Se il deficit indotto fosse di 25 milioni di metri cubi, in termini energetici questi significherebbero la perdita di circa 150 milioni di Kwh di energia di punta che andrebbero messi anch’essi tra i danni causati dal progetto.
C'è poi da dire che i precedenti grandi lavori hanno già inciso in modo drammatico sulle sorgenti della Valle di Susa: il raddoppio della ferrovia Torino-Modane, ha provocato la scomparsa di 13 sorgenti nel territorio di Gravere e di 11 nella zona di Mattie.
Le gallerie dell’autostrada tra Exilles e la val Cenischia hanno fatto scomparire 16 sorgenti delle frazioni di Exilles, oltre ad alcune altre in altre località. I lavori della centrale di Pont Ventoux, per una galleria di soli due metri di diametro, hanno prosciugato il rio Pontet, 2 sorgenti a Venaus, 2 a Giaglione, una decina in territorio di Salbertrand, tra cui quella che alimentava l’acquedotto di Eclause.
L'esperienza inevitabilmente insegna e non tenere conto di quanto già accaduto non è solo un atteggiamento miope, ma in questo caso volutamente lesivo. Nella sua sintesi sulla crisi mondiale dell’acqua e sull’iniziativa di cartellizzare l’acqua del mondo, Maude Barlow ha usato l’espressione “oro blu", una risorsa vitale che assume sempre più le caratteristiche del petrolio, l'oro nero per cui si è combattuto e si continua a combattere, in spregio alle perdite umane.
Alcune stime indicano che nei prossimi anni l’acqua avrà un giro d’affari del valore di centinaia di miliardi di euro e questa tendenza è legata soprattutto alla privatizzazione della sua distribuzione che, in particolare in Europa, sta diventando normalità. E, alla luce di questo, prosciugare la Val di Susa come si è già fatto col Mugello non è altro che un business nel business.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
La Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare il divieto della fecondazione eterologa previsto dalla legge 40, non ha ravvisato elementi di incostituzionalità nel merito. I ricorsi sono quindi tornati al mittente: ai Tribunali di Firenze, Catania e Milano. La decisione della Consulta nasce all’ombra del parere espresso dalla Corte Europea che, Convenzione sui diritti dell’uomo alla mano, non ravvede nel divieto dell’eterologa una compromissione dell’articolo 8 sul diritto del rispetto alla vita privata e familiare.
Un passo indietro quindi per quanti da 8 anni contestano la legge 40, modificata finora a colpi di sentenza, ma non snaturata dall’impianto censorio che la contraddistingue. A differenza che al suo debutto nel 2004 con il Ministro Sirchia, oggi è possibile eseguire la diagnosi pre-impianto (senza selezione conseguente, quasi una beffa oltre il danno) e non c’è più il limite di un unico e contemporaneo intervento con il limite massimo di tre embrioni. E’ possibile congelare gli embrioni non utilizzati per scelta medica ed è stata ampiamente riconosciuta l’autonomia del medico.
Il referendum del 2005 portò in trionfo l’astensionismo, grazie al monito della Chiesa, alla lobby dei comitati pro-vita e alla profonda ignoranza del popolo italiano che preferì non metter mano alla conoscenza della questione, precludendosi una parte importantissima del proprio diritto alla salute. Perché di questo si tratta.
Se l’Europa e la Consulta non vedono nel divieto dell’eterologa una minaccia al rispetto della vita privata e familiare, esistono però elementi concreti per indirizzare i ricorsi su un altro piano: l’eguaglianza dei cittadini e delle persone. Questo annunciano gli avvocati delle coppie penalizzate dalla legge 40 e in effetti la Corte Costituzionale, questo l’unico elemento incoraggiante, non ha sbarrato la strada, ma rimandato la materia ai giudici di primo grado. Una “non decisione” definitiva che riapre le danze e sposta gli argomenti, forse sul piano normativo e morale più decisivo. Il torto giuridico e morale più evidente della legge 40 è infatti quello di discriminare i cittadini in prima istanza sulla base di una condizione naturale (la sterilità o la trasmissione genetica di malattie) e in seconda battuta di una discriminazione di censo, ancor più indigeribile e filosoficamente meno nobile (i più abbienti, infatti, si rivolgono a strutture oltre confine).
Una “non decisione” definitiva che riapre le danze e sposta gli argomenti, forse sul piano normativo e morale più decisivo. Il torto giuridico e morale più evidente della legge 40 è infatti quello di discriminare i cittadini in prima istanza sulla base di una condizione naturale (la sterilità o la trasmissione genetica di malattie) e in seconda battuta di una discriminazione di censo, ancor più indigeribile e filosoficamente meno nobile (i più abbienti, infatti, si rivolgono a strutture oltre confine).
Chi ha problemi di sterilità o di trasmissione genetica di malattie dovrebbe trovare nella legge e nel welfare un sistema di strumenti e tutele mirate a sopperire quel limite di natura che non rimanda a scelte o a responsabilità, ma a dati di fatto, affinché uno stato moderno non assomigli alla Rupe di Sparta e i limiti naturali non si trasformino in una discriminazione rispetto a quanto dettato dalla Costituzione circa l’eguaglianza tra cittadini e il diritto alla salute per tutti, cui rientrano a pieno titolo la fertilità e la nascita dei propri figli.
Come la mettiamo infatti con quei genitori che sanno di trasmettere ai propri figli sindromi genetiche invalidanti? Qual è lo stato morale, per rispondere agli integralisti della vita, di una coscienza che sa di rendersi complice scientemente della malattia che infliggerà al proprio figlio? E qual è la coerenza normativa di un paese che vieta la selezione degli embrioni in nome della vita e legittima invece - giustamente - qualche tempo dopo, la soppressione di quello che è diventato un feto con la legge 194?
La soluzione più coerente, questa la tesi della Chiesa e di quasi tutti i cattolici in Parlamento, sarebbe quella di ripensare anche la legge 194, ovviamente dal loro pulpito. E così, finalmente, il paese mostrerebbe con coerenza tutto ciò che è sempre stato. Una propaggine etica del Catechismo cattolico romano, uno stato innamorato della provvidenza. Dove è facile vivere bene e in grazia di Dio se si è sani e ricchi. L’unico caso in cui la libertà di scelta è qualcosa cui si può rinunciare, perché tanto si ha già tutto.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
La vittoria di Pizzarotti a Parma, quella di Doria a Genova e di Leoluca Orlando a Palermo, hanno caratterizzato la seconda tornata delle elezioni amministrative. Che sul piano politico generale sono state molto più e molto altro che un voto locale, esibendo con chiarezza la riduzione a fenomeno locale e minoritario della Lega Nord e la sostanziale abdicazione del Pdl all’astensionismo. Il tracollo del centrodestra, infatti, è il dato inconfutabile delle elezioni e la Padania è tornata ad essere un’iperbole da osteria.
La diserzione delle urne, poi, è davvero il dato saliente per tutto l’insieme del quadro politico, destinatario esclusivo della disaffezione dai politicanti che diventa maggioranza. Dai politicanti, sì, non dalla politica, giacché l’affermazione del Movimento 5 stelle e dei candidati del centrosinistra sostenuti dall’insieme della sinistra, dimostra che il rifiuto della classe dirigente non è leggibile come rifiuto della politica tout court.
In questo senso, il risultato di Doria a Genova e le proporzioni con il quale è arrivato, é la notizia migliore della giornata. Nella città medaglia d'oro della Resistenza, delle magliette a striscie e dei camalli, della crisi industriale e di quella politica, é diventato sindaco un uomo perbene, un impasto di orgoglio ideale e coerenza comportamentale che raccoglie tutto ciò che a sinistra vive e che riesce a dare voce ai settori dimenticati della politicheria mediatica.
Le reazioni dei partiti vanno dalla soddisfazione al silenzio, come d’uopo. Bersani sostiene che il Pd ha vinto ovunque, ma è vero solo a metà, giacché il Pd vince dove è in uno schieramento ampio, non certo da solo, spesso anche grazie a candidati scelti fuori dal partito di via del Nazareno.
 E se la vittoria di Leoluca Orlando può essere inserita in un contesto politico particolare come quello di Palermo, la sconfitta di Parma è il dato che più dovrebbe far riflettere il gruppo dirigente del Pd. Pizzarotti ha vinto contro un sistema locale di malaffare ed inefficienza che aveva sì nel centrodestra sgangherato e corrotto (in manette o dimessosi grazie alle inchieste della magistratura) il perno principale, ma che vede anche nel Pd responsabilità precise.
E se la vittoria di Leoluca Orlando può essere inserita in un contesto politico particolare come quello di Palermo, la sconfitta di Parma è il dato che più dovrebbe far riflettere il gruppo dirigente del Pd. Pizzarotti ha vinto contro un sistema locale di malaffare ed inefficienza che aveva sì nel centrodestra sgangherato e corrotto (in manette o dimessosi grazie alle inchieste della magistratura) il perno principale, ma che vede anche nel Pd responsabilità precise.
Sarà interessante ed avvincente vedere come il nuovo sindaco gestirà la città. A Parma ha vinto perché, semplicemente, ha offerto trasparenza nei bilanci e partecipazione nelle scelte; ha dichiarato di voler chiudere, smantellare e rivendere l’inceneritore, indicando nella raccolta differenziata e nel compostaggio le politiche sui rifiuti in città. Ha vinto, Pizzarotti, rompendo quel clima consociativo esistente tra i partiti e l’associazione dei costruttori, che hanno cementificato e sfigurato la città, sommergendola di cemento e di opere inutili e in alcuni casi incompiute.
Di fronte al tergiversare dei partiti, preso atto della museruola che la lobby dei costruttori aveva imposto alla città, i parmensi hanno deciso di reagire. Ed è inutile, oltre che poco intelligente, ritenere che siano stati i voti del centrodestra che, confluendo sul candidato grillino, abbiano segnato la differenza. In primo luogo perché è tutto da dimostrare che gli elettori conservatori abbiano votato per Pizzarotti; in secondo luogo perché al primo turno avevano raccolto un bottino misero, ben inferiore al distacco con cui Pizzarotti ha trionfato.
 In realtà è la sinistra che ha fatto confluire il suo voto al primo turno (quasi il dieci per cento) sul candidato grillino e, probabilmente, una parte dello stesso elettorato Pd ha deciso d’inviare un segnale a Parma e a Roma. E ad ogni modo, quando una vittoria arriva con quelle dimensioni, non ha senso cercare le virgole delle percentuali, se non si vuole incorrere nella classica situazione del dito che indica la luna e dello stupido che guarda il dito.
In realtà è la sinistra che ha fatto confluire il suo voto al primo turno (quasi il dieci per cento) sul candidato grillino e, probabilmente, una parte dello stesso elettorato Pd ha deciso d’inviare un segnale a Parma e a Roma. E ad ogni modo, quando una vittoria arriva con quelle dimensioni, non ha senso cercare le virgole delle percentuali, se non si vuole incorrere nella classica situazione del dito che indica la luna e dello stupido che guarda il dito.
Con il Movimento 5 stelle e tutti i settori della società civile che si mobilitano e si organizzano su scala locale e nazionale il Pd deve provare a costruire un dialogo, a tessere un filo. Non serve a niente tentare di limitare le perdite ed esaltare i successi, non è il tempo della propaganda. Meglio sarebbe, per il Pd, riflettere su un dato che da un anno a questa parte si va regolarmente riconfermando: la sua stessa base elettorale ritiene che l’inciucio perenne con Casini non debba proseguire e sceglie di volta in volta il candidato più a sinistra tra quelli iscritti alle primarie. Napoli, Milano, Palermo, Genova, Cagliari, ora Parma.
E’ il popolo dei referendum per la difesa dei beni comuni e per l’abrogazione del Porcellum, della battaglia contro l’abolizione dell’articolo 18, degli indignati, dei No-Tav, che difende i licenziati e gli esodati, si schiera con la Fiom e chiede con forza una nuova igiene della politica. Chiede un’uscita a sinistra dalla crisi e non sopporta più l’idea del compromesso e la rinuncia al proprio sistema di valori come “il male necessario”. Vuole affermare la sua esistenza, i suoi temi, la titolarità dell’alternativa etica e politica; vuole vincere o perdere, ma non accetta più di non partecipare. Si svegli in fretta il Pd, se vuole evitare di passare dall’essere minoranza nel paese ad essere minoranza nella sua stessa gente.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Alessandro Iacuelli
di Alessandro Iacuelli
Adesso certamente arriverà qualcuno, probabilmente uno "storico competente", a dire che era perfettamente prevedibile, anche se siamo rimasti tutti sgomenti, perplessi, colti di sorpresa, con la sensazione di aver preso un pugno nello stomaco. Emozioni forti, certo, accompagnate da quella solita fastidiosa abitudine dell'ostentare la morte e la violenza, attraverso sequenze evitabili di foto pubblicate in rete. Il fatto, quello saliente, è che una studentessa di 16 anni dava per scontata l'esistenza di un domani, di un futuro. Non era contemplata la fatalità dell'andare a scuola una mattina per poi non tornare.
Le perplessità però sono troppe. Per carità, è un dato storico costante nel tempo che in Italia ci si lascia prendere la mano dall'emotività. E' successo troppe volte, puntualmente, che sia stato preso un granchio, sempre sulla scia dei facili giudizi e del prendere per scontate delle cose. Da Portella delle Ginestre fino alla gambizzazione dell'AD di Ansaldo Nucleare di pochi giorni fa.
Così, anche stavolta, sono bastati tre giornalisti che hanno incollato tra loro alcune coincidenze, e di colpo l'odioso pasticcio di Brindisi è stato "declassato" ad azione di stampo mafioso. A nulla è valso, per ora, al PM salentino Cataldo Motta ricordare che la pista mafiosa non è la sola possibile: è già scattata una vasta "distrazione di massa".
Se guardiamo al passato recente, le note stonate sono molte. Quale sarebbe il movente della tentata strage? Qualche giornalista ha fatto riferimento al nome della scuola: da quando la mafia mostra interesse per i nomi di scuole, strade, monumenti, intitolati a chi la mafia l'ha combattuta? Qualcun altro ha scritto che "nello stesso giorno doveva passare la carovana antimafia", quella che gira l'Italia da dieci anni e di cui da dieci anni tutte le mafie si disinteressano. Facciamo invece qualche considerazione seria.
 1) Da dove è uscita la pista mafiosa? Non dagli ambienti inquirenti, se non una tra le tante ipotesi, ma solo da quelli giornalistici, in particolare della RAI.
1) Da dove è uscita la pista mafiosa? Non dagli ambienti inquirenti, se non una tra le tante ipotesi, ma solo da quelli giornalistici, in particolare della RAI.
2) Le mafie, tutte, come ricordato dallo stesso PM, basano la loro esistenza sul consenso sociale, pertanto attaccare una scuola è altamente controproducente.
3) Le mafie colpiscono direttamente il loro nemico. Qualunque sia: un magistrato (da Pio La Torre a Rosario Livatino, passando per Falcone e Borsellino l'elenco è lungo), o un poliziotto (Dalla Chiesa), o un politico che si sgancia (Salvo Lima), o un sindacalista scomodo (Imposimato), o un imprenditore che non paga o che si schiera contro (Libero Grassi, Michele Orsi). Vogliamo mettere sullo stesso piano le studentesse di Brindisi? Qui si è andato a colpire nel mucchio.
4) Il tipo di attacco è piuttosto controverso: le mafie sono specialiste in autobombe (Roma/Firenze/Milano 1994, via d'Amelio 1992), o anche peggio, come per l'esplosivo in grado di far saltare un'intera autostrada a Capaci nel 1992. Alquanto singolare che con tutta quella potenza di fuoco si siano abbassati a tre bombole di gas.
5) E' vero, ci sono stati gli attentati del '94, anche con due bambine vittime a Firenze. Era una fase di trattativa tra Stato e mafia, come è stato di recente provato; ai Georgofili l'autobomba è esplosa con un timer, pertanto non si sapeva se per caso al momento dello scoppio ci sarebbero stati dei bambini o no, nei paraggi. Se la bomba la si mette invece fuori una scuola, si ha la certezza di colpire degli studenti in giovane età. Non certo magistrati, poliziotti, imprenditori. Colpire nel mucchio, che piaccia o meno, è storicamente una strategia eversiva.
6) Il tipo di attentato, mostra da parte dell'esecutore una precisa conoscenza delle tecniche classiche dell'eversione nera, puntualmente legata a certi apparati dello Stato.
7) Come dichiarato dal PM Ingroia al TG3: "Questo attentato punta a creare un senso di insicurezza nei cittadini e diffondere la paura", che è un vero e proprio obiettivo politico.
L'Italia è caratterizzata al momento da alcuni dati essenziali: partiti politici, soprattutto quelli di governo, ai loro minimi storici, ingovernabilità latente, incertezza elettorale, crisi economica profonda, malcontento popolare che diventa pericoloso, come ne caso delle azioni contro Equitalia. Questo è il contesto.
In questo contesto, la strage: con una tempistica perfetta, scoppia una bomba. Una bomba particolarmente "cattiva", che colpisce la gioventù inerte ed innocente, è il tipo di bomba che ci indigna, ci perfora le budella, ci fa venire paura, ci fa perdere lucidità.
 Il contesto è lo stesso del bienno 1969/1970. Il malcontento popolare c'era anche allora. L'ingovernabilità pure. In quel contesto, proprio come ora, si colpì nel mucchio, e a ripetizione. Prima Piazza Fontana, poi il treno Italicus, poi Piazza Loggia. Questo sì che è colpire nel mucchio, chi si trova per caso lì in quel momento. E non erano certo attentati di stampo mafioso. C'è qualche similitudine da brivido, con quanto successo a Brindisi?
Il contesto è lo stesso del bienno 1969/1970. Il malcontento popolare c'era anche allora. L'ingovernabilità pure. In quel contesto, proprio come ora, si colpì nel mucchio, e a ripetizione. Prima Piazza Fontana, poi il treno Italicus, poi Piazza Loggia. Questo sì che è colpire nel mucchio, chi si trova per caso lì in quel momento. E non erano certo attentati di stampo mafioso. C'è qualche similitudine da brivido, con quanto successo a Brindisi?
Se così fosse, sarebbe certamente peggio rispetto ad un attentato mafioso, ma sarebbe chiaro il movente: spostare l'opinione pubblica da certi eventi di tipo politico-economico e coalizzare il popolo italiano contro un "nemico" comune, come se gli italiano avessero dimenticato il male; un nemico del popolo, e dello Stato, quello stesso Stato che fino ad ora il popolo ha contestato. Proprio come per il rapido 904, che esplose a Vernio mentre il Parlamento approvava l'insieme di azioni finanziarie chiamato "Pacchetto Visentini".
Viceversa, se è stata la mafia, qualcuno dovrebbe indicare il movente, a meno che la mafia non sia stata semplice manovalanza dei veri mandanti. Perché la mafia non fa nulla inutilmente, e qui il movente non c'è, non contano cose come l'impegno per la legalità di quella scuola: la lotta per la legalità la fanno diecimila scuole, e da decenni le mafie se ne disinteressano e continuano a fare affari.
Qualche che sia la verità, non è dato sapere. Ma c'è da scommetterci, che anni di indagini e di commissioni di inchiesta non porteranno a nulla, se non a qualcosa che sarà coperto da segreto di Stato. Sarà anche mafia, come provano a convincerci, ma probabilmente sarebbe meglio se gli italiani si facessero coraggio e, prima che sia troppo tardi, analizzassero lucidamente anche le altre ipotesi.
In conclusione, arriva strisciante il sospetto di una nuova strategia della tensione in tempi di austerity e di rigore. Pertanto, ancora una volta, viene voglia di recitare quel famoso passo di Pasolini che inizia con un “Io so...”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Secondo il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri la questione della TAV è “la madre di tutte le preoccupazioni”. Lo ha detto ieri, a margine di una conferenza stampa sulle misure d'emergenza che l'esecutivo starebbe approntando dopo il ferimento del dirigente Ansaldo Roberto Adinolfi. Una nota del Viminale, qualche ora dopo, spiegava che la "preoccupazione" riguarda solo le problematiche delle opere da realizzare per la Torino-Lione ma, dal momento che si parlava di terrorismo, la rettifica del ministro sembra davvero una foglia di fico.
Se non altro, grazie alla gaffe del ministro Cancellieri abbiamo scoperto quali sono le vere priorità del Governo. Non è lo spread, non è nemmeno il fatto che a marzo il debito pubblico ha sfiorato i 2.000 miliardi di euro. A non fare dormire la notte i nostri tecnici sono i No Tav e le pericolose infiltrazioni terroristiche che, secondo la Digos, il movimento attirerebbe come le api col miele.
Certo in questi giorni il tema “terrorismo” è un must delle testate nostrane, ma basterebbe un po' di memoria storica e di buonsenso per liquidare gli episodi di questi giorni come gesti di disperati o di millantatori. Invece, soprattutto se si tratta della Valsusa, la tendenza delle maggiori istituzioni - stampa, governo e magistratura - è sempre quella di etichettare il dissenso come eversione, di ridurre la resistenza a becera violenza.
Ma se davvero le ansie del ministro Cancellieri riguardano solo la grande opera in se, allora fa bene a preoccuparsi di quello che succede sulla tratta Torino-Lione. Il suo problema - come quello di molti altri irriducibili Si Tav - è quello di correggere la miopia di sguardo e di riconoscere che le uniche infiltrazioni in Valsusa non sono quelle terroristiche, ma quelle mafiose.
Non è un mistero, infatti, che per la 'ndragheta il progetto dell'Alta Velocità sia un ghiottissimo boccone: i valsusini lo gridano da decenni e l'operazione Minotauro dello scorso giugno l'ha confermato con 142 arresti. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni del pentito Rocco Varacalli, e per il procuratore di Torino Giancarlo Caselli - lo stesso che ha tacciato i No Tav di squadrismo e che a gennaio ne ha fatti arrestare 26 - il quadro emerso ha dimostrato chiaramente “risvolti inquietanti”.
 I risvolti inquietanti sono i contatti con la politica e gli appalti delle aziende delle 'ndrine nella Pubblica Amministrazione. Pratiche che già Roccuzzo Lo Presti, organico al clan Mazzaferro aveva importato nel freddo Piemonte negli anni ’60. Lo Presti aprì proprio a Bardonecchia un negozio di abbigliamento, per poi prosperare in altri settori come edilizia, autotrasporti, bar, le immancabili sale da gioco e la ristorazione. Per i giudici è proprio Lo Presti a portare la mafia a Bardonecchia, e non a caso si era accasato con i Mazzaferro, già “attenzionati” nel 1976 dopo l’ottenimento di appalti per la costruzione del traforo stradale del Frejus, inaugurato poi nel 1980.
I risvolti inquietanti sono i contatti con la politica e gli appalti delle aziende delle 'ndrine nella Pubblica Amministrazione. Pratiche che già Roccuzzo Lo Presti, organico al clan Mazzaferro aveva importato nel freddo Piemonte negli anni ’60. Lo Presti aprì proprio a Bardonecchia un negozio di abbigliamento, per poi prosperare in altri settori come edilizia, autotrasporti, bar, le immancabili sale da gioco e la ristorazione. Per i giudici è proprio Lo Presti a portare la mafia a Bardonecchia, e non a caso si era accasato con i Mazzaferro, già “attenzionati” nel 1976 dopo l’ottenimento di appalti per la costruzione del traforo stradale del Frejus, inaugurato poi nel 1980.
Il matrimonio tra 'ndrangheta e Piemonte è quindi di lunga data, letteralmente delle nozze d'oro. Altre due inchieste, la prima nel 1984 e la seconda verso la fine del 1994, descrivono infatti le 'ndrine infiltrarsi negli appalti pubblici nell’alta Valsusa, fino allo scioglimento del comune di Bardonecchia il 28 aprile del 1995, primo comune del nord Italia ad essere commissariato per infiltrazioni mafiose. E anche all'interno della relazione della Commissione Parlamentare Antimafia del 1994, si censivano le presenze persistenti di ‘ndrangheta, cosa nostra e camorra in Piemonte, confermando tutta una serie di situazioni sospette nel settore finanziario.
Già nel 1994 emergeva quindi chiaramente quella “zona grigia” fatta di professionisti, politici e funzionari pubblici su cui la mafia da sempre si appoggia per trasformare l’illecito in apparentemente lecito. Ciò nonostante, negli ultimi vent'anni la criminalità organizzata ha tranquillamente continuato a fare ottimi affari, grazie anche alle ghiotte occasioni degli appalti - e in particolare dei subappalti - per le Olimpiadi invernali di Torino 2006 e per l'Alta Velocità Torino-Lione.
Arriviamo così all'operazione Minotauro, in cui 191 persone sono state indagate - 142 delle quali incarcerate - e in cui viene sciolto per mafia il comune di Leinì, il secondo nella provincia di Torino. All'interno dei faldoni elaborati dalla procura di Torino, si fa chiaramente riferimento agli illeciti presenti nell'aggiudicazione della commessa per la recinzione del cantiere di Chiomonte, l'area dove sorgeva il presidio permanente dei No Tav e che è stata dichiarata di “interesse strategico nazionale” dall'ordinanza del Cipe.
 Nell’ultima delle 604 pagine del dossier il colonnello Domenico Mascoli inserisce uno schema dei lavori aggiudicatisi da Foglia Costruzioni e condivisi con Italcoge spa della famiglia Lazzaro, vincitrice dell'appalto per la recinzione del non-cantiere della Maddalena: i carabinieri sottolineano uno snodo societario a loro dire cruciale, ovvero l’acquisto della fallita Foglia Costruzioni da parte di Finteco, altra società che riconducono al controllo occulto di Giovanni Iaria, arrestato con il blitz di giugno e personaggio di spicco della 'ndrangheta.
Nell’ultima delle 604 pagine del dossier il colonnello Domenico Mascoli inserisce uno schema dei lavori aggiudicatisi da Foglia Costruzioni e condivisi con Italcoge spa della famiglia Lazzaro, vincitrice dell'appalto per la recinzione del non-cantiere della Maddalena: i carabinieri sottolineano uno snodo societario a loro dire cruciale, ovvero l’acquisto della fallita Foglia Costruzioni da parte di Finteco, altra società che riconducono al controllo occulto di Giovanni Iaria, arrestato con il blitz di giugno e personaggio di spicco della 'ndrangheta.
Lo schema finanziario utilizzato sino ad ora negli appalti Tav è un meccanismo noto: il meccanismo della concessione, che sostituisce la normale gara d'appalto in virtù della presunta urgenza dell'opera, e fa sì che la spesa finale sia determinata sulla base della fatturazione complessiva prodotta in corso d'opera, permettendo di fatto di gonfiare i costi e creare fondi neri per migliaia di miliardi. La Direzione nazionale Antimafia, nella sua relazione annuale per il 2011, ha dato al Piemonte il terzo posto sul podio della penetrazione della criminalità organizzata calabrese e il flusso di denaro destinato alla TAV rischia di diventare linfa per il suo potenziamento, aumentandone la capacità di investimento, di controllo del territorio, accrescendone il potere economico e, di conseguenza, politico.
La storia della TAV in Italia è la storia infinita di accumulazione di capitali da parte dei cartelli mafiosi e questa, se non è “la madre di tutte le preoccupazioni”, è certamente una problema di cui il Viminale dovrebbe occuparsi con urgenza.
