Politica
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giuliano Luongo
di Giuliano Luongo
"Senza l’Italia faremmo meglio”. Dopo una marea di convenevoli alquanto inutili, il caro Sergio Marchionne ha espresso la citata dichiarazione durante un’intervista di Fabio Fazio alla trasmissione “Che Tempo che Fa” della passata domenica. Senza cambiare espressione, senza battere ciglio, ha candidamente ammesso che la casa automobilistica che anni or sono ha messo le ruote all’Italia...non ha bisogno dell’Italia.
O meglio, ha bisogno di non avere l’Italia. Marchionne si riferiva alla quota di produzione fatta nel nostro Paese, costosa e generalmente antieconomica rispetto a quelle prodotte all’estero: inoltre parlava della scarsa attrattività dell’Italia per gli investimenti stranieri, vista la costante situazione di instabilità economica e politica mista ad un clima sindacale troppo teso.
Dunque pare che il bisogno fondamentale dell’Ad Fiat non sia solo una terapia d’urto dal dentista, ma soprattutto una cura di fosforo: il fatto che il decesso della sua compagnia sia stato evitato dal governo italiano con i soldi dei contribuenti italiani innumerevoli volte sembra totalmente evaporato dalla sua memoria, senza parlare dell’importante ruolo degli incentivi statali sulla quota di vendite. Il suo intervento televisivo è proseguito con una serie di pretesti che a sua detta avrebbero dovuto spiegare la momentanea cattiva situazione della Fiat, del tutto imputabile a decisioni delle gestioni precedenti, ai sindacati, alla diretta concorrenza.
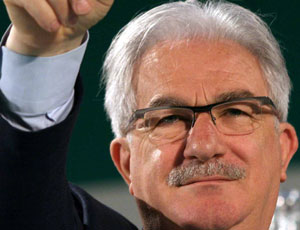 Le reazioni del mondo politico a questa esternazione atipica, degna del peggior Cossiga beccato durante una sbornia euforica, sono state alquanto eterogenee. Riportiamo la reazione dell’ormai suo funzionario sindacale Bonanni: senza smentire le sue posizioni recenti, ha appoggiato con vigore le posizioni dell’Ad, viste come realtà inconfutabili. L’uomo “contro” del momento, Gianfranco Fini, si è posto invece contro Marchionne, evidenziando le citate gravi amnesie di quest’ultimo sul recente passato del bilancio della sua società.
Le reazioni del mondo politico a questa esternazione atipica, degna del peggior Cossiga beccato durante una sbornia euforica, sono state alquanto eterogenee. Riportiamo la reazione dell’ormai suo funzionario sindacale Bonanni: senza smentire le sue posizioni recenti, ha appoggiato con vigore le posizioni dell’Ad, viste come realtà inconfutabili. L’uomo “contro” del momento, Gianfranco Fini, si è posto invece contro Marchionne, evidenziando le citate gravi amnesie di quest’ultimo sul recente passato del bilancio della sua società.
In disaccordo ma più neutrale invece Angeletti. Dal PD toccano problemi più strettamente industriali: il responsabile economico Fassina ricorda come Marchionne dovrebbe prima pensare a ristrutturare le carenze della sua azienda in termini di progettazione, politiche di investimenti ed organizzazione del lavoro, prima di sparare a zero su tutto e tutti.
Al di là della polemica strettamente politica, la cosa migliore è dirigere lo sguardo verso i problemi legati all’industria stessa, dalla qualità dei prodotti lanciati sul mercato sino ai piani più complessi della struttura organizzativa. La bagarre politica, come al solito, distoglie l’attenzione dalle carenze prettamente di gestione.
Il problema centrale è evidente: per Marchionne il solo modo per far risollevare l’azienda passa per l’abbassamento dei costi di produzione tagliando dal lato dei salari, peggiorando direttamente le condizioni dei lavoratori sul nostro suolo oppure spostando gli stabilimenti nel più vicino e conveniente paese slavo o latino americano. Non dimentichiamo che la Serbia è solo l’ultimo in termini cronologici: la produzione Fiat è presente in Polonia - non dimentichiamo il malcontento degli operai a Tychy, che hanno dovuto sudare parecchio per un mensile di 500 euro - Brasile, India e Russia.
L’importante è trovare un paese con manodopera disorganizzata a basso costo, magari al di fuori delle mura comunitarie dove non arrivano gli standard sulle condizioni di lavoro, e dove magari vi sono facili incentivi per le imprese straniere. Nonostante nel nostro paese ormai due terzi delle principali sigle sindacali siano molto più che malleabili, ciò non è ancora sufficiente per il manager: per l’attuale gestione l’idea di relazioni industriali serene si concretizza nell’imposizione di condizioni inique per il lavoratore che ha diritto solo a stare in silenzio. Il pensiero di Marchionne è evidente: la colpa della situazione attuale è esclusivamente dei lavoratori “recalcitranti”, che da egoisti non accettano condizioni più dure per il bene dell’azienda, inasprendo il clima e rendendo l’impresa poco appetibile per gli investitori esteri.
Sarebbe poi utile concentrarsi sulla mera qualità delle auto prodotte. Marchionne incolpa gli incentivi statali anche per auto straniere (su 10 auto comprate, solo 3 sono italiane): ma si è chiesto perché le preferenze si spostano sui prodotti esteri? Il primo problema è che la qualità Fiat è oggettivamente bassa, con avarie frequenti e componenti fragili, a fronte di un prezzo elevato per la fascia di riferimento.
 In secondo luogo, si veda il problema dell’innovazione. Si rilanciano sul mercato modelli obsoleti, resi “nuovi” grazie al totale snaturamento degli stessi, con conseguente cambio di target commerciale. Si pensi alla Panda, da utilitaria a pseudo 4WD per signore, o alla 500, veicolo nato storicamente per motorizzare i meno abbienti e divenuto mini super car per fighetti dalle facoltà mentali ridotte ma dai capienti portafogli.
In secondo luogo, si veda il problema dell’innovazione. Si rilanciano sul mercato modelli obsoleti, resi “nuovi” grazie al totale snaturamento degli stessi, con conseguente cambio di target commerciale. Si pensi alla Panda, da utilitaria a pseudo 4WD per signore, o alla 500, veicolo nato storicamente per motorizzare i meno abbienti e divenuto mini super car per fighetti dalle facoltà mentali ridotte ma dai capienti portafogli.
E in entrambi in casi, un prezzo di partenza per lo più elevato, taglia fuori la fascia bassa di utenza, quella sulla quale la Fiat ha fatto la propria gloria nei “bei” tempi andati. Si noti che questi due modelli sono stati anche particolarmente “ingannevoli” per le sorti dell’azienda: dopo un iniziale successo - dovuto peraltro ad un battage pubblicitario assordante - sono finiti nel dimenticatoio (e nei reparti “usato” dei concessionari) molto presto, per la serie di motivi appena elencati.
Il problema dell’innovazione non si lega esclusivamente ai modelli: ricerca e sviluppo di nuove tecnologie rimangono spesso a livello embrionale. L’Opel già installava motori Euro 4 nel 2003, oggi in Francia si corre verso l’auto elettrica, ma dalle nostre parti si rimane al palo: non che la cosa ci stupisca, visto che qui si ritiene ancora che il nucleare sia una fonte energetica moderna e pulita. Già, la concorrenza francese in particolare. Marchionne ha sostenuto che la Fiat ha fatto l’errore di specializzarsi nella produzione di auto piccole a basso valore aggiunto, che concedono profitti minori, a differenza ad esempio della Germania, che produce principalmente auto di lusso.
Ma proprio nel settore utilitarie low cost i francofoni ci stracciano. E come mai? Perché noi produciamo low cost costose: abbiamo perso la nostra fascia ideale e per di più la qualità dei componenti si attesta su livelli nettamente inferiori. Concentrare risorse nella progettazione invece che nelle follie di marketing, tra campagne pubblicitarie milionarie e linee d’abbigliamento indesiderate sarebbe un passo importante da fare.
Detto questo, non rimane che fare alcune considerazioni. Il problema è strettamente produttivo, ma si cerca di buttarla sul piano politico, a metà tra le responsabilità del “governo ladro” e soprattutto dei lavoratori, i veri bersagli dell’attuale gestione, vittime del nuovo maccartismo italiano: la coscienza di classe e la fame di diritti viene bollata come mentalità sovversiva e va appianata per il raggiungimento del profitto. Non vengono viste strade alternative. Come nota Landini, Marchionne riesce solo a parlare di “sfascio”, senza spendere una parola su investimenti, rinnovo del piano industriale o qualsivoglia strategia. Perché non c’è nulla di tutto questo. C’è solo la ferma intenzione a comandare un’impresa col pugno di ferro verso l’obiettivo del profitto familiare, senza curarsi di chi costituisce davvero l’ossatura dell’azienda. Come quando la rivoluzione industriale era appena iniziata.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giovanni Gnazzi
di Giovanni Gnazzi
A centinaia di migliaia scendono in piazza e, di rimando, qualcuno sale in cattedra. Se una straordinaria manifestazione di popolo (talmente pacifica da trasformare in figuraccia i desideri di Maroni) pone l’accento sull’organizzazione del lavoro, sull’equità fiscale e sulla ricetta giusta per uscire dalla crisi, alcuni personaggi sentono il bisogno di rimarcare la loro assenza con un sussulto di presenze davanti alle telecamere.
Succede spesso, purtroppo; in questo sgangherato paese i Tg vengono confezionati così: un minuto ai settecentomila in piazza, due minuti ai censori e tre a quelli che in piazza non ci sono andati. In un ribaltamento penoso delle notizie, la priorità non viene assegnata all’iniziativa, ma a quelli che si pronunciano in opposizione alla stessa.
Ovviamente, quando si tratta dell’azione di governo, le priorità si ribaltano: al governo va il 75% dello spazio, a chi denuncia le sue malefatte va il 25%. La teoria del "panino" dei Tg subisce quindi una metamorfosi a seconda delle occasioni. Gira che ti rigira, cambia la farcitura del panino, ma il risultato è che il governo ha spazio, l’opposizione molto meno. Fin qui, si dirà, niente di nuovo, ce lo si aspettava e non c’era certo bisogno di Minzolini per assistere a tutto questo. Ma la proiezione televisiva della manifestazione indetta dalla Fiom ha superato le attese.
 Intanto, giornalisticamente parlando, aveva quattro caratteristiche che la rendevano importante. La prima è rappresentata dalla scelta del maggiore sindacato italiano dei metalmeccanici di scendere in piazza a difesa del Contratto collettivo Nazionale, ribaltando la teoria fondamentale di Marchionne e dei suoi seguaci, per la quale si deve scegliere: prima il lavoro poi i diritti. Come se il lavoro non fosse un diritto, il primo, fondamentale diritto cui devono seguire tutti gli altri previsti dalla Carta, dallo Statuto dei lavoratori e dalla giurisprudenza giuslavorista.
Intanto, giornalisticamente parlando, aveva quattro caratteristiche che la rendevano importante. La prima è rappresentata dalla scelta del maggiore sindacato italiano dei metalmeccanici di scendere in piazza a difesa del Contratto collettivo Nazionale, ribaltando la teoria fondamentale di Marchionne e dei suoi seguaci, per la quale si deve scegliere: prima il lavoro poi i diritti. Come se il lavoro non fosse un diritto, il primo, fondamentale diritto cui devono seguire tutti gli altri previsti dalla Carta, dallo Statuto dei lavoratori e dalla giurisprudenza giuslavorista.
La seconda è che la manifestazione è presto diventata una marcia dell’opposizione contro il governo; non stupisca l’assenza del PD, semmai la cosa conferma l’affermazione precedente. La terza, invece, è tutta politica; la manifestazione della Fiom ha messo in luce come il sindacato dei metalmeccanici abbia preso non solo un’iniziativa al di fuori dei partiti dell’opposizione “ufficiale” (e indifferente alle sue lacerazioni interne) ma che abbia lanciato un segnale forte a tutto il movimento sindacale e last but no least, anche al prossimo congresso della Cgil.
La quarta, per i palati sociologicamente più fini, è che la manifestazione ha rimesso al centro della vicenda politica l’esistenza delle tute blu; sì, gli operai, quelli di cui con dotte analisi sulla composizione del mercato del lavoro si nega ormai non solo la centralità, ma l’esistenza stessa.
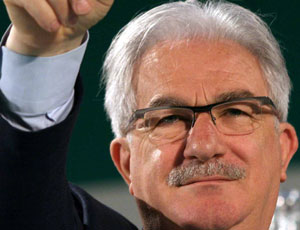 E invece, dopo trenta secondi d’immagini della folla oceanica che riempie Piazza San Giovanni, ci tocca vedere e sentire Sacconi e Bonanni dire rispettivamente che si è trattato di una manifestazione con parole d’ordine del secolo scorso, insomma anacronistica (Sacconi) e che l’unità sindacale su queste posizioni è una chimera (Bonanni). per carità, dichiarazioni scontate, si potrebbe osservare: però quello che risulta insopportabile è che l'informazione non ha ritenuto - salvo rarissime eccezioni - di approfondire questo spaccato del Paese, la sua nuova identità, il suo essersi messo di traverso rispetto all'aria montante della fine del lavoro.
E invece, dopo trenta secondi d’immagini della folla oceanica che riempie Piazza San Giovanni, ci tocca vedere e sentire Sacconi e Bonanni dire rispettivamente che si è trattato di una manifestazione con parole d’ordine del secolo scorso, insomma anacronistica (Sacconi) e che l’unità sindacale su queste posizioni è una chimera (Bonanni). per carità, dichiarazioni scontate, si potrebbe osservare: però quello che risulta insopportabile è che l'informazione non ha ritenuto - salvo rarissime eccezioni - di approfondire questo spaccato del Paese, la sua nuova identità, il suo essersi messo di traverso rispetto all'aria montante della fine del lavoro.
E’ bene allora far presente a Sacconi e ai suoi suggeritori che a essere ascrivibili al secolo scorso sono le sue proposte di restaurazione del mondo del lavoro. Il Ministro berlusconiano, nell’odio ossessivo per le organizzazioni sindacali degli operai, propone ricette che da 30 anni almeno sono state superate in tutta Europa. Sacconi è un pessimo esempio di come la politica possa diventare ossessione patologica. Quanto a Bonanni, meglio avrebbe fatto a tacere.
Sarebbe bene, infatti, che il segretario della Cisl tenesse presente come l’unità sindacale - bene preziosissimo - sia stata distrutta dalla scelta (sua e di Angeletti) di firmare accordi separati dalla Cgil e di sedersi a tavoli di confronto con il governo senza la presenza del maggior sindacato italiano. Risultato, questo, dalla progressiva politicizzazione della Cisl e della Uil in chiave di sostegno al centrodestra italiano, che da sedici anni in qua, con scarse soluzioni di continuità, ha fatto ogni cosa in suo potere per ridurre le relazioni industriali ad un confronto tra le pistole e le tempie.
 Bonanni, del resto, contento non poteva essere: la manifestazione di Roma ha reso ancor più evidente la differenza tra l’essere popolare ai tavoli del governo e l’essere decisivo nelle fabbriche e nelle piazze. Lui ed Angeletti potranno andare anche mille volte da Vespa o a Ballarò, ma nelle fabbriche la situazione è ben diversa. E' la Fiom che rappresenta oggi il coagulo del mondo del lavoro, non certo la Cisl o, tantomeno, la Uil.
Bonanni, del resto, contento non poteva essere: la manifestazione di Roma ha reso ancor più evidente la differenza tra l’essere popolare ai tavoli del governo e l’essere decisivo nelle fabbriche e nelle piazze. Lui ed Angeletti potranno andare anche mille volte da Vespa o a Ballarò, ma nelle fabbriche la situazione è ben diversa. E' la Fiom che rappresenta oggi il coagulo del mondo del lavoro, non certo la Cisl o, tantomeno, la Uil.
Non si hanno, invece, notizie di Maroni; silente prima dell’assalto ultrà allo stadio di Genova in occasione della partita tra Italia e Serbia, aveva ritenuto in cambio di lanciare l’allarme sulla manifestazione Fiom. A Genova, ovviamente, era successo di tutto; a Roma, invece, niente. A dirla tutta, la minaccia di possibili incidenti era sembrata da subito come un auspicio più che un timore: l'organizzazione del servizio d'ordine della Fiom e, prima ancora, l'assoluta assenza di pulsioni suicide da parte di chiunque, hanno reso le "avvertenze" del Ministro dell'Interno parole senza tempo e senza senso. Se Maroni suonasse il sax a tempo pieno, invece d’intestardirsi con la politica, avremmo più musica e meno provocazioni. L’Italia intera se ne gioverebbe.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Quattro italiani muoiono in Afganistan. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa è a Milano. Dopo le dichiarazioni di cordoglio, gli insulti: chiedere il ritiro delle truppe sarebbe “sciacallaggio”. Ma una giornata del genere non si può lasciar passare così. La Russa convoca una conferenza stampa e sale su un aereo per Roma. Si fa riprendere in ministero, circondato da generali. “Non bisogna lasciar nulla d’intentato per proteggere i nostri ragazzi”. Cioè servono nuove armi. Parla di mezzi corazzati come i “fenice” e i “lince”, disturbatori elettronici, rinforzi aerei. Poi la butta lì: “Chiederò alle commissioni parlamentari di valutare la possibilità di armare i nostri caccia di bombe”.
In realtà potrebbe decidere in autonomia, ma è meglio che la responsabilità se la prenda tutto il Parlamento. La Russa continua a parlare di ‘missione di pace’ perfino mentre propone di adottare la misura più pericolosa per la popolazione, il bombardamento aereo. Può darsi che il massacro quotidiano di civili in Afghanistan (in aumento rispetto agli anni passati, secondo dati Onu) non faccia più notizia. Forse è semplicemente trascurabile. In ogni caso, è tempo di armare i caccia. Perché? Per “proteggere i nostri ragazzi”?
No. Il pericolo più grave per i soldati è quello delle imboscate e le bombe sparate dal cielo non proteggono da questo genere d’attacco. Sempre che il ministro non immagini di bombardare a tappeto ogni singola strada prima di farla attraversare dai beneamati “lince”. A ben vedere, i nostri caccia Amx sono gli unici privi di bombe di tutta la missione Isaf e questo ci crea un po’ d’imbarazzo davanti alla Nato. Tant’è vero che il segretario generale Anders Fogh Rasmussen si è affrettato a farci presente che “armare i caccia con le bombe non è in contraddizione con la missione Isaf”. Sarebbe a dire, datevi una mossa.
Rimane oscuro come tutto questo si concili con il ritiro delle truppe entro il 2011. Un termine che lo stesso La Russa continua a ripetere, salvo poi specificare che “la guerra vera in Afghanistan è cominciata da poco” e che “nelle ultime fasi del confitto i talebani si sono rafforzati”. Per così dire. In realtà, i talebani non sono mai stati così forti e il meccanismo che li ha rianimati è in moto da qualche anno. In molti, oggi, parlano di neo-talebani.
Quasi scomparsi dopo la caduta del regime nel novembre del 2001, gli studenti coranici si riorganizzano in Pakistan, nelle aree tribali pashtun. Le fila s’ingrossano: non solo si affiancano uomini di Al Qaeda, ma anche islamisti di vario tipo provenienti dall’Asia centrale. Gli stati Uniti fanno pressioni sul Pakistan perché contrasti i gruppi talebani nelle cosiddette Fata (Federal administrated tribal areas), ma ottengono l’effetto opposto a quello sperato. Le popolazioni pakistane della zona finiscono con l’avvicinarsi ai talebani, visti come difensori dell’identità pashtun contro il demone americano. Intanto Islamabad non si lascia piegare e tiene la situazione in bilico, senza opporsi in maniera davvero decisa né ai talebani, né alle incursioni militari Usa.
 Se esiste un’uscita d’emergenza per risolvere lo stallo, forse l’ha intuita Hamid Karzai. In un’intervista alla Cnn, il presidente afgano ha confermato quello che il Washington Post aveva anticipato qualche giorno prima. Da diversi mesi sono in corso negoziati segreti fra il governo di Kabul e i delegati autorizzati della Quetta Shura, il gruppo di talebani afgani nascosti in Pakistan e guidati dall’evanescente mullah Omar.“Non si tratta di comunicazioni regolari - ha spiegato Karzai - ma di contatti personali, non ufficiali”. Grazie all’alto consiglio per la pace, il neonato organo di governo destinato ad aprire le trattative con i ribelli, il presidente auspica “che questi negoziati continuino in modo ufficiale e rigoroso”.
Se esiste un’uscita d’emergenza per risolvere lo stallo, forse l’ha intuita Hamid Karzai. In un’intervista alla Cnn, il presidente afgano ha confermato quello che il Washington Post aveva anticipato qualche giorno prima. Da diversi mesi sono in corso negoziati segreti fra il governo di Kabul e i delegati autorizzati della Quetta Shura, il gruppo di talebani afgani nascosti in Pakistan e guidati dall’evanescente mullah Omar.“Non si tratta di comunicazioni regolari - ha spiegato Karzai - ma di contatti personali, non ufficiali”. Grazie all’alto consiglio per la pace, il neonato organo di governo destinato ad aprire le trattative con i ribelli, il presidente auspica “che questi negoziati continuino in modo ufficiale e rigoroso”.
Ora, i talebani di Omar hanno sempre detto che avrebbero rifiutato ogni dialogo finché le truppe infedeli avessero occupato il suolo afgano. Perché alla fine hanno deciso di trattare? Secondo fonti del Washington Post, gli uomini di Omar sono alla ricerca di un accordo per evitare di essere scavalcati alla guida del movimento talebano dal clan più radicale degli Haqqani, un gruppo vicino ai servizi segreti pakistani, escluso da ogni negoziato.
La Quetta Shura pretende il ritiro completo delle truppe straniere, dopo di che si accontenterebbe di qualche poltrona per i suoi leader in un successivo governo d’unità nazionale. Probabilmente Karzai sarebbe disponibile a concessioni di questo tipo. Ma sembra impensabile che la Nato e soprattutto gli Stati Uniti possano accettare una soluzione del genere. Non dopo nove anni di guerra.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Sostiene Bersani che il PD è pronto ad allearsi con l’UDC per governare. Della dichiarazione, la parte che stupisce è dove si dice che il PD é “pronto” a fare qualcosa. Intendiamoci: nel contenuto non è certo una notizia positiva, dal momento che unire le forze con l’UDC per mandare a casa il governo è un conto, costruirci un progetto di governo è un altro. Ma ci sarà modo più avanti di verificare se questo sarà l’unico epilogo possibile per un partito nato in laboratorio; per ora è più utile tentare di dare una lettura alla cosiddetta “fase di transizione” del berlusconismo e ai pericoli che porta con sé, vagamente evocati da Bersani stesso.
Che cacciare Berlusconi sia un’urgenza democratica e persino una necessità per il sistema paese, non vi sono dubbi. Il fallimento clamoroso del quindicennio del regno di Arcore è sotto gli occhi di tutti. Ed é giusto - come fa Bersani - porsi il problema di una crisi di regime che, nella sua fase finale, può produrre una coda velenosa dall’impatto estremamente pericoloso per una democrazia già oggi ridotta ai minimi termini.
Oltretutto, la sentenza della Consulta, che il prossimo 14 Dicembre definirà la legittimità del legittimo impedimento, rischia di produrre un effetto devastante e definitivo nella stessa compagine governativa. D’altro canto, le crescenti difficoltà del Presidente del Consiglio sia nel suo schieramento che, più in generale, nel consenso del paese, sono il retroterra ideale per una resistenza sulle barricate di un uomo che teme che perdere questo scontro politico, per il livello al quale lui stesso lo ha portato, significherebbe molto di più che una crisi parlamentare e una successiva campagna elettorale.
“E’ un osso duro Berlusconi”, ha detto Bersani. Ha ragione: spesso è accaduto che lo si dava per battuto, ma la sua indubbia capacità propagandistica, le risorse a disposizione e l’insipienza assoluta dell’opposizione lo hanno risollevato. Oggi, però, il Premier sembra avvilupparsi in una crisi dagli esiti incerti; una volta tanto non pare che abbia la capacità di vincere contro tutti e tutto. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, in un contesto così complesso, in quella cioè che si può definire una vera e propria crisi di regime?
 Berlusconi ha già dato innumerevoli prove di come intenda la battaglia politica: a tutto campo e senza esclusione di colpi, con ogni mezzo a disposizione (lecito o illecito che sia) indifferente alle regole e pronto al “tanto peggio tanto meglio”. E’ con questa concezione che si è fatto strada nel mondo degli affari e nell’agone politico. Berlusconi non persegue il potere come legittima ambizione per veicolare un progetto politico e di sistema, cosciente che però il suo utilizzo non può e non deve elevarsi al di sopra di quanto la Carta e il sistema di regole istituzionali, scritte e no, consentono. Non ha nessun interesse per la vita del Paese se non per i vantaggi che possono derivarne per lui e per le sue aziende. Per questo è “sceso in campo” e per questo non mollerà facilmente il campo.
Berlusconi ha già dato innumerevoli prove di come intenda la battaglia politica: a tutto campo e senza esclusione di colpi, con ogni mezzo a disposizione (lecito o illecito che sia) indifferente alle regole e pronto al “tanto peggio tanto meglio”. E’ con questa concezione che si è fatto strada nel mondo degli affari e nell’agone politico. Berlusconi non persegue il potere come legittima ambizione per veicolare un progetto politico e di sistema, cosciente che però il suo utilizzo non può e non deve elevarsi al di sopra di quanto la Carta e il sistema di regole istituzionali, scritte e no, consentono. Non ha nessun interesse per la vita del Paese se non per i vantaggi che possono derivarne per lui e per le sue aziende. Per questo è “sceso in campo” e per questo non mollerà facilmente il campo.
Berlusconi ritiene che il suo disegno sia già, di per sé, più importante del Paese stesso al quale dovrebbe essere indirizzato. Difendere il suo disegno diventa quindi prioritario. E in una distorta concezione machiavellica, non solo i fini giustificano i mezzi, ma spesso i mezzi indicano con chiarezza i fini. La sua potenza di fuoco - derivatagli da un potere immenso e sproporzionato per qualunque democrazia occidentale - abbraccia la finanza, la comunicazione e il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, il sistema bancario e il commercio con l’estero ed è ben rappresentato nelle strutture palesi e occulte che governano l’Italia.
Nella concezione berlusconiana del potere, del resto, le norme e le leggi su cui si edificano le comunità, sono solo lacci che impediscono a chi comanda nella sostanza di comandare anche nella forma. Per questo vanno rimossi, invocandone ora una presunta inutilità, ora una sospetta inapplicabilità, fino a mettere sullo stesso piano una Costituzione vera e vigente con una “di fatto” inventata dai suoi legulei.
In questo senso, sarebbe quindi perfettamente inutile auspicare una fine di regime politicamente guidata, una transizione dal berlusconismo dalle grandi mascelle verso un riassesto degli equilibri politici ed economici del Paese. In questi ultimi anni abbiamo avuto prove in abbondanza: i dossieraggi mediatici, l’uso dei Servizi segreti e del potere economico sfrenato, senza pudori, nella battaglia politica, hanno inquinato a fondo un paese già piegato su se stesso e in deficit di democrazia. In questo senso, dunque, la difesa degli ultimi spazi di agibilità democratica e di dialettica politica ha una sua funzione determinante, non lo si può negare.
Si può discettare a lungo di transizione incompiuta dalla prima alla seconda Repubblica, ma seppure, storicamente, la sovranità limitata del Paese é sempre stata la ragione fondativa della sua mancata crescita democratica, da quindici anni in qua il buco nero di questa democrazia sospesa si chiama Berlusconi. Il suo dominio politico si poggia (anche) sul conflitto d’interessi che permette ai suoi tentacoli di strangolare la dialettica politica. Inutile qui ripetere ancora una volta quali e quante siano le responsabilità del centrosinistra italiano nel non volerlo affrontare in maniera decisa.
 Per alcuni c’era la convinzione che sarebbe apparso un provvedimento illiberale, per altri, autonominatisi volpi della politica, c’era l’idea che non risolverlo una volta per tutte avrebbe tenuto Berlusconi sotto scacco. Fatto sta che non è stato né risolto né affrontato e si è lasciato che questo cancro corrodesse dall’interno il già fragile equilibrio tra i poteri. Sistema che non solo andrebbe salvaguardato per rispetto all’ordinamento Costituzionale, ma che deve essere assicurato se si vuole che la dialettica democratica sopravviva alle ansie di dominio di una persona o di una cricca.
Per alcuni c’era la convinzione che sarebbe apparso un provvedimento illiberale, per altri, autonominatisi volpi della politica, c’era l’idea che non risolverlo una volta per tutte avrebbe tenuto Berlusconi sotto scacco. Fatto sta che non è stato né risolto né affrontato e si è lasciato che questo cancro corrodesse dall’interno il già fragile equilibrio tra i poteri. Sistema che non solo andrebbe salvaguardato per rispetto all’ordinamento Costituzionale, ma che deve essere assicurato se si vuole che la dialettica democratica sopravviva alle ansie di dominio di una persona o di una cricca.
Sul conflitto d’interessi non c’era bisogno di promulgare una legge liberticida, giacché tanto esteso era (e ora lo è diventato molto di più) che sarebbe stata sufficiente una legge semplicemente copiata ed incollata da quelle statunitensi o da qualunque altra esistente nel quadro giuridico europeo. Si poteva legiferare quindi senza timori per la campagna mediatica che il cavaliere nero avrebbe intrapreso. L’ha fatto comunque, per sedici anni, contro tutto e tutti, aggredendo in tutti i modi gli ostacoli che si sovrapponevano tra la sua ansia narcisistica di dominio assoluto e il mandato - limitato, seppur ampio - che le urne gli hanno concesso.
Mandare a casa il governo, senza però sapere come andare a votare successivamente, non sarebbe sufficiente. Una nuova legge elettorale, quindi, se si vuole porre fine alla stortura evidente di un sistema che assegna il 60% dei seggi a chi abbia almeno il 30% dei consensi, ha una sua urgenza intrinseca e non discutibile. L’organizzazione dei collegi e delle circoscrizioni, così come disegnata, e con le norme del porcellum, darà in partenza la vittoria al cavaliere in almeno una delle due Camere, purché egli mantenga saldo il rapporto con la Lega di Bossi. Ma serve un profondo riesame anche delle norme che disciplinano l’utilizzo dei mezzi di comunicazione in campagna elettorale, ad evitare che la già ultra evidente sproporzione di mezzi finanziari e di bocche da cannone mediatiche in campo, non renda semplicemente ridicola una competizione già decisa prima ancora di cominciare.
 Una legge elettorale, di norma, dovrebbe garantire due esigenze: rappresentatività e governabilità. E dovrebbe anche essere concepita sulla scorta della tradizione culturale e politica del Paese dove si vota. Proprio in ragione di queste considerazioni, una legge elettorale su base proporzionale, con una soglia di sbarramento al 4 o al 5%, risulterebbe la più idonea a tenere insieme gli elementi di cui sopra.
Una legge elettorale, di norma, dovrebbe garantire due esigenze: rappresentatività e governabilità. E dovrebbe anche essere concepita sulla scorta della tradizione culturale e politica del Paese dove si vota. Proprio in ragione di queste considerazioni, una legge elettorale su base proporzionale, con una soglia di sbarramento al 4 o al 5%, risulterebbe la più idonea a tenere insieme gli elementi di cui sopra.
Impedirebbe ammucchiate, ridurrebbe immediatamente il numero di partiti e partitini - favorendo quindi la governabilità - e semplificherebbe le procedure di voto; ridarebbe la parola agli elettori nella scelta dei candidati e garantirebbe il rispetto delle diverse identità politiche del Paese (favorendo quindi la rappresentatività).
A maggior ragione una legge elettorale equa si rende necessaria per contrastare il profondo squilibrio mediatico garantito dai funzionari del padrone, che occupano ignobilmente le poltrone di direttori dei Tg e dei Gr Rai. Il servizio pubblico non dovrebbe vedere rappresentato nei suoi vertici apicali la quinta colonna dell’azienda concorrente.
Un’azienda - Mediaset - che con buona pace di D’Alema, molto prima che essere una risorsa del Paese è un’arma politico-elettorale del Presidente del Consiglio e del suo partito, così come lo sono i giornali famigli e i magazine che pompano fuffa agiografica per la famiglia, progressivamente trasformati in house organ del padrone.
Questo è il quadro dell’informazione in Italia, questo lo scenario su cui si organizza il mercato della circolazione delle idee e si prefigura il consenso. Questo quindi il punto nevralgico dove l’iniziativa parlamentare deve divenire un imperativo categorico. Se non si vuole veder finire una stagione drammatica con una campagna elettorale farsesca che offra un risultato scontato. Chi ritiene di dover fare politica, è da qui che deve muovere. Se ci si crogiola aspettando di proporre uno scacco al re, si finisce per subire uno scacco matto.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Nell’autunno caldo che vede sul piede di guerra il mondo della scuola e quello del lavoro dipendente, il mondo politico non ha di meglio da fare se non impegolarsi in una telenovela: una di quelle alla Beautiful, in cui le storie si avviluppano a tal punto che ogni tentativo di capirne la trama è vano. Il caso Marcegaglia- il Giornale è solo l’ultima delle vicende che stanno inabissando il dibattito politico italiano verso un impoverimento che non ha precedenti storici.
La dinamica è presto detta. Da una parte sta il giornale della famiglia Berlusconi - intestato formalmente a Paolo, ma controllato direttamente da Silvio - e dall’altra la presidentessa di Confindustria che, per ovviare all’immagine di lobby “sdraiata” sull’azione di governo, ha rilasciato dichiarazioni di biasimo rivolte all’esecutivo. Come già successo all’ex first lady Veronica Lario e al presidente della Camera Fini, nella redazione del Giornale i “segugi” si attivano per scovare quanti più scheletri la signora Marcegaglia tenga nel suo armadio ma, non trovando nulla che già non si sappia, si limitano a millantare tramite sms il famigerato dossier.
Rinaldo Arpisella, portavoce della presidentessa di Confindustria e amico di vecchia data del vicedirettore del Giornale Porro, si allarma e lo chiama per chiedere una conferma che sibillinamente gli viene data e la Marcegaglia chiama quindi Confalonieri che pone il veto a procedere. Emma, sentendosi evidentemente il fiato dei berluscones sul collo, avverte comunque la Procura di Napoli che, con il coordinamento del “pm dei vip” Henry John Woodcock, perquisisce spettacolarmente la sede del Giornale e ne indaga direttore e vice direttore per presunta attività di dossieraggio finalizzata alle minacce.
Scoppia l’ennesimo caso mediatico e, prima ancora che scenda un velo pietoso sulla spy story dell’impropria proprietà della casa di Montecarlo, l’attenzione della vita politica viene catalizzata dal nuovo scandalo e dalle sue assurde implicazioni. Certo la coincidenza tra le critiche al governo Berlusconi e l’avvio fulmineo di campagne diffamatorie a firma delle penne più schierate con l’esecutivo, proprio verso quelli che ciclicamente hanno avuto l’arroganza di contraddire Padron ‘Silvio o di giudicarne negativamente l’operato, è un’evidenza di come anche l’informazione abbia acquisito un modus operandi a orologeria.
Ma dov’è la novità? Sin dai tempi dell’editto bulgaro contro Biagi, Santoro e Luttazzi abbiamo imparato che chiunque sia sgradito al Presidente del Consiglio ha buone probabilità di scomparire dalla scena pubblica o, quantomeno, di venire infangato pubblicamente su una delle testate di famiglia. Perché allora strapparsi i capelli dinanzi ad una versione riveduta e corretta del killeraggio attuato sull’ex direttore di Avvenire Boffo? Ma chi se ne frega! È “ciarpame” già visto, stravisto e rivisto, e poco importa che stavolta la protagonista sia la numero uno di Confindustria.
Mai come in questo frangente storico il dibattito politico dovrebbe essere concentrato sui problemi, stringenti e quanto mai esiziali, che stanno attanagliando la penisola. Un’intera generazione non vedrà mai la sua pensione, la piccola impresa boccheggia schiacciata tra l’usura delle banche e un consumo che tarda a ripartire, la scuola è allo sfascio totale, la classe media scivola sempre più verso la soglia di povertà e si potrebbe continuare ancora nel segno di un giustificato catastrofismo.
 Ma nello spaesamento programmatico e nella più totale incapacità di offrire soluzioni anche solo ad uno dei problemi sopraccitati, conviene che tutte le voci di palazzo convergano sulla fuffa al quadrato che le colonne del Giornale generosamente offrono su un piatto d’argento. Stando infatti alla teoria del two step flow - letteralmente “fluire in due mosse” - approntata da Lazarsfeld e Katz, i mass media non raggiungono tutto il pubblico in modo diretto, ma il messaggio che vogliono veicolare viene prima raccolto da un gruppo di persone influenti all'interno della comunità - i cosiddetti opinion leaders - i quali poi trasmettono il messaggio alle altre persone che sono meno attive nella fruizione dei mezzi di informazione.
Ma nello spaesamento programmatico e nella più totale incapacità di offrire soluzioni anche solo ad uno dei problemi sopraccitati, conviene che tutte le voci di palazzo convergano sulla fuffa al quadrato che le colonne del Giornale generosamente offrono su un piatto d’argento. Stando infatti alla teoria del two step flow - letteralmente “fluire in due mosse” - approntata da Lazarsfeld e Katz, i mass media non raggiungono tutto il pubblico in modo diretto, ma il messaggio che vogliono veicolare viene prima raccolto da un gruppo di persone influenti all'interno della comunità - i cosiddetti opinion leaders - i quali poi trasmettono il messaggio alle altre persone che sono meno attive nella fruizione dei mezzi di informazione.
Con questo semplice espediente la classe politica odierna, sedicente sinistra compresa, spera di deviare l’attenzione del popolo affamato e incazzato, conscia oltremodo del fatto che una storia ben raccontata e densa di colpi di scena fa presa come nient’altro sull’immaginario collettivo italiota. La stessa Emma Marcegaglia ha tutte le ragioni per offrire il fianco agli strali del Giornale: dal momento che il padre Steno è attualmente accusato di falso e associazione a delinquere all’interno di un’inchiesta “Golden rubbish” sul traffico di rifiuti tossici in Campania, la nuova immagine di vittima sacrificale dell’egotismo berlusconiano gioverebbe in seno alla stessa logica del fuoco di copertura.
In tutto questo inutile bailamme, l’unico argomento per cui varrebbe la pena spendere un ragionamento è quello che riguarda il labile confine tra prassi giornalistica e dossieraggio. Se l’inchiesta di Napoli dovesse proseguire nel piano accusatorio (al contrario delle molte inchieste principiate da Woodcock) il rischio di sconfinare dal doveroso accertamento di una notizia di reato in una prevaricazione della libertà di stampa è quanto mai tangibile. Raccogliere informazioni su un determinato personaggio pubblico fa parte dell’abc degli operatori dell’informazione e il fatto che queste possano risultare compromettenti, in senso giudiziario e non, è uno dei motivi che spinge un giornalista deontologicamente inattaccabile a fare il suo mestiere.
Sarebbe perciò un enorme danno se venisse emessa una sentenza in cui ad essere condannato fosse il lavoro giornalistico: a livello giurisprudenziale, il precedente sarebbe talmente forte da far impallidire ogni legge bavaglio. Pensiamoci.
