- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La condanna delle consuete dichiarazioni provocatorie del presidente iraniano Ahmadinejad sul ruolo del governo USA nei fatti dell’11 settembre non arriva soltanto da Washington ma, più recentemente, anche dalla stessa organizzazione terroristica accusata di aver orchestrato gli attentati alle Torri Gemelle di New York. Nell’edizione autunnale del magazine on-line di Al-Qaeda in lingua inglese, Inspire, Ahmadinejad viene criticato per le sue tesi sull’11 settembre, secondo le quali gli attentati di dieci anni fa sarebbero una cospirazione ordita dal governo di Washington per invadere l’Afghanistan e l’Iraq.
“Il governo iraniano ha sostenuto per bocca del suo presidente Ahmadinejad di non credere che Al Qaeda sia dietro all’11 settembre, ma che ci sia piuttosto il governo USA", si legge nell’articolo a firma Abu Suhail. “Quindi noi ci chiediamo: perché l’Iran sostiene una teoria così ridicola, contraria a ogni logica ed evidenza?”.
L’autore del pezzo in questione rivendica la paternità dell’attentato e definisce il presidente della Repubblica Islamica un rivale di Al-Qaeda sul fronte dell’anti-americanismo. “Per loro [gli iraniani], Al-Qaeda è un rivale nella sfida per conquistare i cuori e le menti dei musulmani oppressi in tutto il pianeta”, prosegue l’articolo. “Al-Qaeda ha avuto successo dove l’Iran ha fallito. Per questo per gli iraniani è necessario cercare di screditare l’11 settembre”.
Secondo l’editorialista della rivista Inspire, inoltre, l’anti-americanismo professato da Teheran rappresenterebbe solo un espediente politico. Dall’articolo emergono d’altronde le risaputa rivalità tra l’Iran sciita e l’organizzazione terroristica sunnita, divisi, quanto meno, dalle differenze di ordine religioso e dai rispettivi obiettivi strategici per estendere la loro influenza nel mondo islamico.
Mahmoud Ahmadinejad ha spesso sostenuto pubblicamente l’idea che dietro all’11 settembre ci fosse il governo di Washington. L’uscita più recente è stata la settimana scorsa, nel corso del suo intervento alla riunione annuale dell’Assemblea generale ONU. In quell’occasione, Ahmadinejad ha anche affermato che la stessa uccisione di Osama bin Laden fa parte della cospirazione, tesa a occultare i veri responsabili dell’attacco al World Trade Center e al Pentagono.
 Come di consueto, il discorso di Ahmadinejad ha fatto in modo che la delegazione americana e quelle di altri paesi all’ONU abbandonassero la sala in segno di protesta. Ma nonostante i toni provocatori usati del presidente iraniano, il quale ha anche nuovamente toccato il tema dell’Olocausto, nella sostanza le sue dichiarazioni sembrano rispondere in realtà più a esigenze di politica interna che ad una vera e propria convinzione personale.
Come di consueto, il discorso di Ahmadinejad ha fatto in modo che la delegazione americana e quelle di altri paesi all’ONU abbandonassero la sala in segno di protesta. Ma nonostante i toni provocatori usati del presidente iraniano, il quale ha anche nuovamente toccato il tema dell’Olocausto, nella sostanza le sue dichiarazioni sembrano rispondere in realtà più a esigenze di politica interna che ad una vera e propria convinzione personale.
Messo alle strette sul fronte domestico dall’ala conservatrice dell’establishment clericale iraniano - che lo accusa, tra l’altro, proprio di tenere una posizione troppo accomodante nei confronti degli Stati Uniti e dell’Occidente - Ahmadinejad ha verosimilmente sentito ancora una volta la necessità di mandare un segnale di inflessibilità ai propri rivali interni, rispolverando le teorie della cospirazione sorte attorno all’11 settembre.
Oltre all’articolo che attacca il governo di Teheran, il numero appena uscito del magazine Inspire presenta altri contenuti che intendono “commemorare” il decennale dell’11 settembre, tra cui una galleria fotografica dedicata a questo e ai successivi attentati terroristici portati a termine in tutto il mondo da A-Qaeda. L’orrore è online.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
A quanto sembra, indignarsi in Israele può servire a qualcosa. E’ di ieri la notizia della pubblicazione del rapporto commissionato dal governo Netanyahu a Manuel Trajtemberg, professore dell’Università di Tel Aviv, sull’onda emotiva provocata dal movimento dei cosiddetti “indignados” di Israele. In sole sette settimane, la commissione Trajtemberg ha messo assieme una serie di proposte che, nelle parole del professore, hanno l’ambizione di “creare le fondamenta di una società più equa”, come richiesto da un movimento di protesta popolare che egli definisce “genuino”.
A scorrere le cronache dei giornali israeliani, si direbbe che di carne al fuoco ve ne sia fin troppa: infatti, anche se il conto finale delle misure contenute nel pacchetto dovrebbe aggirarsi attorno all’equivalente di 6 miliardi di euro di maggior spesa, la prima buona notizia è che non vi saranno sforamenti al budget. Se fosse confermato quanto sosteneva Haaretz ieri, il programma non dovrebbe provocare nemmeno un aumento nel deficit del bilancio pubblico. Ed in effetti la copertura delle misure dovrebbe provenire da un lato da un aumento delle tasse sui redditi alti e sulle imprese e dall’altro da un taglio alle spese militari.
Le risorse così liberate, secondo il Trajtemberg, potranno essere utilizzate per sostenere istruzione, welfare ed occupazione. Nel concreto, il rapporto caldeggia la realizzazione di 200.000 nuove unità abitative, un aumento delle locazioni ed un sistema di sussidio per consentire anche alle fasce più deboli di prendere una casa in affitto. Lo stato dovrebbe garantire la scuola gratuita per i bambini a partire dai 3 anni di età (oggi si parte dai cinque), l’orario scolastico lungo ed un tetto per i prezzi degli asili nido privati: tutto questo dovrebbe rendere più facile l’accesso delle giovani coppie al mondo del lavoro.
Il rapporto, inoltre, raccomanda una sorta di coefficiente familiare per i genitori, che dovrebbe ridurre la pressione fiscale sulle famiglie, ed un sistema di negative-tax, una sorta di sussidio basato su una dichiarazione di reddito insufficiente a provvedere alle proprie necessità. La commissione, infine, richiede al governo di ridurre i dazi sui prodotti importati, una gamma molto ampia che va dai prodotti alimentari lavorati all’elettronica di consumo: da questa misura, Trajtemberg si aspetta di veder aumentare la concorrenza e conseguentemente una riduzione del costo della vita.
 Nonostante si tratti di un piano tempestivo e almeno apparentemente progressista, non c’è nessuno in Israele a concedergli per lo meno il beneficio d’inventario. Scontata la protesta dell’esercito, che ha subito levato alti lai, sostenendo che i tagli alla spesa militare avrebbero come effetto immediato una diminuzione della sicurezza per i cittadini di Israele. Immediatamente rintuzzati dal ministro delle finanze che ha invitato gli ufficiali a “cominciare a non andarsene in giro con macchine di lusso [pagate dal contribuente ndr]”.
Nonostante si tratti di un piano tempestivo e almeno apparentemente progressista, non c’è nessuno in Israele a concedergli per lo meno il beneficio d’inventario. Scontata la protesta dell’esercito, che ha subito levato alti lai, sostenendo che i tagli alla spesa militare avrebbero come effetto immediato una diminuzione della sicurezza per i cittadini di Israele. Immediatamente rintuzzati dal ministro delle finanze che ha invitato gli ufficiali a “cominciare a non andarsene in giro con macchine di lusso [pagate dal contribuente ndr]”.
Molto contrari alle misure delle commissione Trajtemberg saranno certamente gli industriali israeliani, i sindacati e gli agricoltori. Scontenti anche gli studenti-rappresentanti della protesta sociale. “Hanno usato il gergo della nostra protesta, cosa che può ingannare la pubblica opinione, perché in realtà non hanno proposto delle misure che portano tanto lontano” ha dichiarato Daphni Leef in una conferenza stampa.
Le fa eco Regev Contes, altro leader della protesta: “Non sono particolarmente stupito, dato che sin dall’inizio i numeri di cui parla Trajtemberg non riescono nemmeno ad avvicinarsi minimamente a quello che occorre per le necessità pubbliche”. Almeno Itzik Shmueli, capo del sindacato degli studenti, concede a Trajtemberg il fatto di possedere una visione “grandiosa”; che però, secondo Shmueli, contrasta drasticamente con quelli che definisce delle raccomandazioni pratiche inconsistenti.
Al di là delle polemiche, e pur riconoscendo che, come sempre, si potrebbe fare di più e meglio, è sempre possibile che la protesta di piazza finisca per portare qualche risultato concreto per gli israeliani: tutto dipende dal vigore con cui Netanyahu saprà difendere le conclusioni del rapporto ed incardinarle in un percorso parlamentare che si preannuncia già molto complicato.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
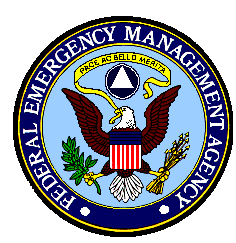 di Michele Paris
di Michele Paris
Il Senato degli Stati Uniti ha licenziato lunedì sera a tarda ora un provvedimento di emergenza che ha evitato un’imminente paralisi delle agenzie e degli uffici federali, nuovamente minacciati dalla mancanza di finanziamenti. Il più recente stallo al Congresso americano era scaturito dalla proposta di stanziare fondi straordinari per far fronte alle conseguenze dei ripetuti disastri naturali avvenuti negli ultimi mesi in varie parti del paese; un’emergenza sfruttata politicamente dai repubblicani per cercare di estrarre ulteriori tagli alla spesa pubblica.
In una vicenda che si è sostanzialmente risolta nell’ennesima capitolazione del Partito Democratico di fronte alle richieste di quello Repubblicano, alla fine da Washington non è stato praticamente stanziato nessun dollaro extra per le attività assistenziali e di ricostruzione svolte dalla protezione civile americana (FEMA, Federal Emergency Management Agency).
La sezione riguardante la FEMA faceva parte di un pacchetto di bilancio destinato a finanziare le spese federali fino al 18 novembre prossimo. Per l’agenzia governativa che si occupa di rispondere alle catastrofi naturali negli USA erano previsti un totale di 3,65 miliardi di dollari, di cui 2,65 da sborsare all’inizio del prossimo anno fiscale - che inizierà il 1° ottobre - e un miliardo in fondi straordinari per quello tuttora in corso.
Per dare il via libera al miliardo addizionale, i repubblicani pretendevano però che venissero tagliati 1,6 miliardi assegnati ad un programma federale di incentivi alla produzione di automobili a basso consumo energetico, particolarmente popolare tra i democratici. Di fronte alla ferma opposizione di questi ultimi, la Camera dei Rappresentanti a maggioranza repubblicana venerdì scorso aveva comunque proceduto a votare un provvedimento comprensivo dei tagli, pur senza alcuna possibilità di superare l’ostacolo del Senato.
L’impasse nella camera alta del Congresso è stata alla fine superata, evitando il pericolo di “shutdown” del governo federale, nella giornata di lunedì, quando la FEMA ha fatto sapere di aver reperito 114 milioni di dollari, destinati ad altri progetti ma inutilizzati, che dovrebbero consentirle di operare fino a venerdì prossimo. Superato l’ostacolo, il Senato ha così approvato il budget temporaneo con 79 voti a favore e 12 contrari. Il voto definitivo della Camera, come ha confermato lo speaker John Boehner, si terrà settimana prossima, al termine di una sospensione dei lavori di una settimana.
Grazie all’accordo bipartisan, la FEMA potrà così ottenere i 2,65 miliardi di dollari assegnati al suo bilancio per l’anno fiscale 2011-2012 a partire da sabato prossimo. Senza il miliardo extra, tuttavia, in questi ultimi giorni di settembre le sue operazioni negli USA risulteranno notevolmente ridotte, mentre non saranno possibili interventi in caso di nuove calamità.
 La FEMA, oltretutto, è penalizzata da una cronica carenza di fondi e, alla luce del moltiplicarsi delle emergenze nell’ultimo periodo, il suo budget dovrà con ogni probabilità essere nuovamente discusso dal Congresso a breve. La stessa Casa Bianca ha già fatto sapere che la FEMA avrà bisogno di almeno 4,6 miliardi di dollari nel prossimo anno fiscale, una cifra che in molti ritengono peraltro ben al di sotto delle reali necessità dell’agenzia.
La FEMA, oltretutto, è penalizzata da una cronica carenza di fondi e, alla luce del moltiplicarsi delle emergenze nell’ultimo periodo, il suo budget dovrà con ogni probabilità essere nuovamente discusso dal Congresso a breve. La stessa Casa Bianca ha già fatto sapere che la FEMA avrà bisogno di almeno 4,6 miliardi di dollari nel prossimo anno fiscale, una cifra che in molti ritengono peraltro ben al di sotto delle reali necessità dell’agenzia.
Di fronte a situazioni drammatiche, con migliaia di persone senza un alloggio, servizi pubblici e infrastrutture da ricostruire, le vittime dei recenti terremoti, inondazioni, tornado e uragani sono dunque tenute in ostaggio dallo scontro politico sul debito in corso a Washington. Fino al recente passato, gli stanziamenti per le emergenze seguite ai disastri naturali - ancorché spesso insufficienti - venivano approvati dal Congresso senza impedimenti.
La febbre del debito che ha contagiato l’intero panorama politico americano, e in particolare quello repubblicano, sembra invece aver portato all’ordine del giorno la necessità di bilanciare le spese per l’assistenza alle vittime delle calamità con altri tagli alla spesa pubblica. Se questo principio non è stato per ora adottato, appare in ogni caso inevitabile che, visto il clima attuale, venga riproposto già in occasione della prossima emergenza.
L’ennesima messa in scena di un Congresso che non sa dare risposte né alle conseguenze della crisi economica né a quelle delle catastrofi naturali, ha rappresentato una nuova occasione per mettere in atto ulteriori misure di austerity. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati escogitati più volte ultimatum e scadenze inderogabili, utilizzate per implementare tagli devastanti alla spesa federale, puntualmente presentati come inevitabili per la sopravvivenza stessa dei servizi garantiti dal governo.
Ad aprile, ad esempio, lo speaker repubblicano della Camera, John Boehner, e il presidente Obama trovarono un accordo sull’estensione del finanziamento della macchina federale addirittura a pochi minuti da un clamoroso “shutdown”. L’esempio più eclatante di questa strategia, deliberatamente adottata per far digerire gli assalti alla spesa pubblica, è però quello dello scorso agosto, quando venne raggiunto un accordo bipartisan in extremis per innalzare il tetto dell’indebitamento americano in cambio di colossali tagli.
Da quel patto tra repubblicani e democratici è uscita una speciale commissione incaricata di individuare e proporre al Congresso entro la fine dell’anno tagli alla spesa per almeno 1.500 miliardi di dollari. A ciò va aggiunto poi il recente piano della Casa Bianca per ridurre la spesa federale di altri 4 mila miliardi di dollari nel prossimo decennio. Una proposta propagandata direttamente da Obama e che include anche tagli per oltre 4 miliardi di dollari al programma della FEMA per la copertura assicurativa dei danni causati dai disastri naturali.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Alfredo Mignini
di Alfredo Mignini
EDIMBURGO. L'aula magna di George Square è semi-deserta. Fuori la pioggia va e viene, come al solito. Dentro ci sono una ventina di studenti, quasi tutti del secondo o del terzo anno, impegnatissimi a discutere i contenuti della loro protesta: cosa chiediamo all'università, alla città di Edimburgo e, infine, al governo. Alcuni sono venuti fin qui da Glasgow o da St. Andrews, che significa qualche ora di treno. Scoprirò in seguito che si tratta di attivisti avveduti, accorsi per l'occasione con striscioni e volantini, che grazie agli sforzi di questo ultimo anno di lotte hanno iniziato a fare rete, mettendo da parte alcune (normalissime) divisioni.
In assemblea, infatti, ritrovi gli ambientalisti di People&Planet così come gli anarchici con le bandiere rosso-nere e il collettivo femminista, ma c'è anche il candidato alle elezioni studentesche e gli altri dell'EUSA, l'associazione che raccoglie tutti gli immatricolati e li rappresenta negli organi accademici.
Si tratta di gente, comunque, che da più di un anno ha smesso di aspettare. A Glasgow, ad esempio, è grazie a loro che da febbraio scorso l'Hetherington Research Club ha riaperto i battenti nelle vesti di quello che in Italia si chiamerebbe un centro sociale. D'altronde anche prima era uno spazio di socializzazione e scambio fra studenti e studiosi aperto nel 1954 e chiuso nel 2010 per via dei numerosi tagli che l'istruzione britannica ha subito e sta subendo a svariati livelli.
E forse è proprio per questo attacco generalizzato ai servizi sociali, che si è scatenata una sorta di “febbre del fare” capace di riallacciare legami e rapporti fra i molti gruppi della sinistra studentesca. «Il momento - mi dicono - è così serio, che non ti puoi permettere di essere frammentato in mille gruppuscoli». Una cosa che in Italia sembra una bestemmia. Gli slogan invece, e solo quelli, sono gli stessi che ho lasciato a casa: il nostro «noi la crisi non la paghiamo» trova un gemello in «we won't pay their crisis».
Qui ad Edimburgo il “nuovo anno di rivolta e resistenza” è precocemente iniziato il 5 settembre, quando l'università ha deciso di alzare le tasse di iscrizione al massimo consentito dal governo: £9000 (contro le £1800 attuali). Si tratta di un aumento considerevole, spiegabile in parte dal fatto che in Scozia, a pagare davvero, sono da un lato gli studenti che vengono dal Galles e dall'Inghilterra, i cosiddetti RUK Students (Rest of UK), e dall'altro gli internazionali.
 L'università, infatti, è gratis tanto per gli scozzesi quanto per gli studenti europei, essendo impossibile per un paese UE discriminare i cittadini degli altri stati membri. Dico in parte perché, in realtà, da quando il governo Cameron ha innalzato a 9mila il tetto massimo, 47 università su 123 hanno già chiesto di poter applicare il massimo dall'anno accademico 2012/13, segno che comunque le cose non vanno affatto bene, anche fuori di qui. E sono molti i giovani che hanno rinunciato al consueto gap year, l'anno sabbatico fra liceo ed università, pur di non pagare il salasso il prossimo settembre.
L'università, infatti, è gratis tanto per gli scozzesi quanto per gli studenti europei, essendo impossibile per un paese UE discriminare i cittadini degli altri stati membri. Dico in parte perché, in realtà, da quando il governo Cameron ha innalzato a 9mila il tetto massimo, 47 università su 123 hanno già chiesto di poter applicare il massimo dall'anno accademico 2012/13, segno che comunque le cose non vanno affatto bene, anche fuori di qui. E sono molti i giovani che hanno rinunciato al consueto gap year, l'anno sabbatico fra liceo ed università, pur di non pagare il salasso il prossimo settembre.
E così a quasi quindici giorni dall'aumento, che ha subito trovato il parere negativo dell'EUSA in consiglio, quel gruppo eterogeneo che risponde al nome di Anti-Cuts Movement ha deciso di lanciare un ciclo di occupazioni da 36 ore, come saranno 36mila le sterline da pagare per avere una normale laurea di quattro anni, che per ora è partito dal Lecture Theatre di Edimburgo e si sta allargando alle altre città universitarie.
Il programma è mobilitare più persone possibili in vista dei prossimi mesi, soprattutto i nuovi che si sentono salvi per essere saliti a bordo dell'ultima scialuppa di salvataggio e forse per questo fanno più fatica a rimboccarsi le maniche.
Non è così, nessuno è salvo se quella scialuppa deve affrontare la tempesta, come sembra. Le richieste (http://bit.ly/pUKxgS) che vengono discusse, infatti, tengono conto, seppur in maniera naif, di questo quadro ed é cercando intelligentemente di inscrivere la lotta dentro l'università in una cornice comune con le altre lotte, soprattutto sindacali, che stanno prendendo piede in tutto il paese.
Staremo a vedere come questo movimento riuscirà a gestirsi nel futuro, visti anche i primi successi dell'anno scorso in termini di visibilità e di capacità di non farsi criminalizzare e stroncare sul nascere. Non è dato sapere, ad oggi, se la cosa verrà risolta in termini classici con qualcuno che saprà raccogliere politicamente le loro richieste, oppure se dal movimento verranno fuori idee politicamente nuove.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Per la prima volta da oltre cinquant’anni, la sinistra francese ha conquistato ieri la maggioranza assoluta nella camera alta del Parlamento di Parigi. Il voto per il Senato ha inflitto una nuova batosta al presidente Nicolas Sarkozy, sempre più impopolare tra l’elettorato d’oltralpe a ormai meno di sette mesi dalle elezioni presidenziali. Era dal 1958 che la destra in Francia deteneva la maggioranza al Senato.
I partiti di centro-sinistra (Socialisti, Verdi e Comunisti) hanno guadagnato 24 seggi nel voto di domenica, abbastanza per raggiungere la maggioranza di 177 su un totale di 348. Il voto è stato il primo dopo l’entrata in vigore della riforma elettorale che ha decretato l’aumentato del numero dei senatori, conseguenza dell’aumento della popolazione, e il rinnovo della metà dei componenti della camera alta ogni tre anni.
Lo storico cambio di maggioranza al Senato è la diretta conseguenza delle vittorie fatte segnare dalla sinistra nelle elezioni locali degli ultimi anni. L’elezione dei membri del Senato in Francia avviene infatti in maniera indiretta. A scegliere i senatori è cioè una delegazione di “superelettori” - 150 mila in totale, di cui poco meno di 72 mila si sono espressi domenica - composta da deputati, consiglieri regionali, rappresentanti dei consigli municipali e membri dell’Assemblea dei francesi all’estero. “Il 25 settembre 2011 rimarrà nella storia”, ha affermato Jean-Pierre Bel, capogruppo socialista al Senato, ad una televisione transalpina. “I risultati di questa elezione per il Senato rappresentano un’autentica punizione per la destra”.
Concretamente, la sconfitta della destra non dovrebbe creare troppi impedimenti all’azione del governo, dal momento che il Senato francese dispone di poteri decisamente inferiori rispetto all’Assemblea Nazionale (camera bassa), dove la destra conserva la maggioranza. Sarkozy, tuttavia, potrebbe veder svanire la possibilità di modificare la Costituzione per inserire l’obbligatorietà del pareggio di bilancio.
Come le recenti elezioni locali, anche quelle per il Senato hanno dunque confermato la popolarità in declino dell’inquilino dell’Eliseo, penalizzato, tra l’altro, dalla crisi economica persistente, da un livello di disoccupazione ancora elevato e dagli assalti portati allo stato sociale francese. A ciò vanno aggiunti anche gli scandali giudiziari che hanno colpito svariati alleati e amici di Sarkozy.
Per i vertici del partito del presidente (UMP), in ogni caso, la sconfitta di ieri va attribuita principalmente alle divisioni all’interno dello schieramento di centro-destra, confermate dalla presenza di numerose liste di candidati “dissidenti” che avrebbero sottratto voti ai partiti principali.
D’altro canto, nonostante i toni trionfalistici del Partito Socialista, la corsa alla presidenza appare tutt’altro che in discesa per l’opposizione. Oltre alla consueta combattività di Sarkozy in campagna elettorale, i Socialisti, dopo lo scandalo che ha colpito l’ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, dovranno fare i conti con la carenza di un candidato forte per il voto di aprile. I favoriti per la vittoria nelle imminenti primarie socialiste sono la segretaria del partito, Martine Aubry, e, soprattutto, il suo predecessore, François Hollande.
