- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La progressiva implementazione delle decisioni sulla Siria della nuova amministrazione Trump sembra avere impresso una svolta a un conflitto entrato ormai nel settimo anno. Gli effetti delle iniziative già più o meno adottate e di quelle che si prospettano nel prossimo futuro si sono tradotti in un’impennata delle vittime civili in Medio Oriente, proprio mentre i colloqui di pace stanno per riaprirsi quasi senza aspettative a Ginevra e la cosiddetta coalizione anti-ISIS si è riunita a Washington senza i rappresentanti delle forze che i fondamentalisti islamici stanno realmente combattendo sul campo.
Il summit nella capitale americana ha avuto un qualche rilievo soprattutto per le dichiarazioni del segretario di Stato, Rex Tillerson. L’ex amministratore delegato di ExxonMobil ha chiarito come gli Stati Uniti non intendano abbandonare il proprio ruolo in Medio Oriente e, con buona pace di coloro che si attendevano una de-escalation della guerra in Siria dopo l’ingresso di Trump alla Casa Bianca, come siano allo studio manovre che rischiano seriamente di aggravare il conflitto in corso.
Tillerson è tornato a ipotizzare la creazione di “zone di sicurezza” in territorio siriano, controllate dai militari americani o dalle milizie armate che si battono contro il regime di Damasco, ufficialmente per facilitare il ritorno dei rifugiati nelle loro abitazioni.
Questa misura circola da tempo tra gli ambienti USA che da più di sei anni cercano di rovesciare il governo di Assad. La fazione del governo americano che faceva capo all’ex segretario di Stato, Hillary Clinton, aveva promosso negli anni scorsi l’istituzione di aree off-limits alle forze del regime o all’ISIS, così come il presidente turco Erdogan aveva a lungo cercato di ottenere il via libera dall’amministrazione Obama per questo stesso progetto.
Tillerson, riprendendo una promessa che lo stesso Trump aveva fatto subito dopo il suo insediamento, è ora tornato sull’argomento, tralasciando di far notare come una misura simile sia del tutto illegale e rischi di innescare un confronto militare diretto con le forze russe o di Damasco, dal momento che, come minimo, sarebbe necessario creare e far rispettare una “no-fly zone” nei cieli siriani.
Nel comunicato finale seguito al vertice della coalizione anti-ISIS non è stata comunque citata la possibile creazione di queste “zone di sicurezza”. Tuttavia, a Washington se ne continua a discutere seriamente. In queste aree, dopo avere cancellato la presenza dell’ISIS, le forze “ribelli” – curde o sunnite – potrebbero riorganizzarsi grazie ai propri sponsor internazionali e lanciarsi una nuova fase della guerra, diretta esclusivamente contro il regime di Assad.
Al di là delle forme che prenderà a breve il rilancio dell’impegno degli USA nel conflitto in Siria, il segretario di Stato di Trump ha assicurato che la presenza militare americana in questo paese e in Iraq, ma anche ovunque il “califfato” dovesse radicarsi, resterà una realtà non solo fino alla sconfitta di quest’ultimo ma anche in seguito per contribuire ai processi di “ricostruzione” che si renderanno necessari.
Delle conseguenze della nuova attitudine della Casa Bianca si è avuta un’anticipazione proprio mentre andava in scena la riunione di Washington. La stampa americana ha raccontato di come gli USA abbiano avviato a partire da martedì un’operazione militare che non ha precedenti in Siria, inviando uomini dei reparti speciali a sostegno delle Forze Democratiche della Siria, all’interno delle quali prevalgono le milizie curde, “al di là delle linee dell’ISIS”.
L’operazione rientra nel quadro del progettato assalto alla capitale dell’ISIS in Siria, Raqqa, e si sta concentrando in questa fase iniziale su una diga sul fiume Eufrate nelle mani degli uomini del “califfato”, allo scopo di aprire una via di penetrazione da occidente verso la città. L’attacco sembra essere condotto con un imponente dispiegamento di forze, tanto che gli stessi vertici militari hanno faticato a ribadire la solita versione ufficiale, cioè che i soldati americani impegnati sul campo hanno un semplice ruolo di “consiglieri” in appoggio delle milizie curde e sunnite. Il New York Times ha spiegato che la strategia USA in Siria assomiglia sempre più a quella in Iraq, dove da mesi è in corso una durissima battaglia per la liberazione della città di Mosul dalle forze dell’ISIS. Anche in Siria, cioè, gli Stati Uniti stanno sempre più facendo ricorso a forze convenzionali con incarichi di combattimento a fianco delle milizie locali che, almeno ufficialmente, dovrebbero condurre la gran parte delle operazioni.
Il New York Times ha spiegato che la strategia USA in Siria assomiglia sempre più a quella in Iraq, dove da mesi è in corso una durissima battaglia per la liberazione della città di Mosul dalle forze dell’ISIS. Anche in Siria, cioè, gli Stati Uniti stanno sempre più facendo ricorso a forze convenzionali con incarichi di combattimento a fianco delle milizie locali che, almeno ufficialmente, dovrebbero condurre la gran parte delle operazioni.
Il dibattito sull’intensificazione dell’impegno americano in Siria continua in ogni caso a evitare il punto più importante della questione, vale a dire la totale illegalità delle operazioni militari in corso. L’amministrazione Trump sta in sostanza accelerando un’offensiva iniziata da Obama e che già non aveva alcuna base legale legittima, se non quella creata appositamente dallo stesso governo americano.
È importante inoltre sottolineare come il rinnovato sforzo militare USA sia già drammaticamente visibile nonostante Trump non abbia ancora formulato in modo ufficiale la nuova politica relativa al conflitto in Siria. Gli sviluppi di questi giorni sarebbero infatti solo la conseguenza dell’allentamento delle regole a cui devono sottostare i militari nel condurre le operazioni sul campo.
La Casa Bianca ha cioè cancellato le limitazioni decise da Obama e che intendevano limitare le vittime civili, anche se spesso in maniera del tutto inefficace. Il Pentagono ha ora la facoltà di agire senza ricevere l’autorizzazione dell’autorità civile e senza la necessità di adoperarsi affinché le operazioni non si risolvano in stragi di innocenti.
Il bilancio dei civili massacrati in Siria dalle bombe americane nelle ultime settimane è perciò salito vertiginosamente. L’episodio più recente è stato registrato martedì, quando i jet americani hanno distrutto una scuola nell’area della città di Raqqa che ospitava un centinaio di rifugiati. Le prime notizie davano più di 30 morti, ma il numero delle vittime potrebbe essere in realtà molto più alto.
Solo qualche giorno prima, un’altra incursione nella provincia di Idlib aveva ucciso più di 40 civili dopo che era stata colpita una moschea. I militari americani avevano sostenuto che il bombardamento aveva interessato un edificio vicino, dove si trovavano miliziani qaedisti, ma le testimonianze dei residenti e delle organizzazioni umanitarie hanno smentito questa versione, costringendo il Pentagono ad aprire un’indagine sull’accaduto.
Oltre alle conseguenze per la popolazione civile, il maggiore coinvolgimento americano in Siria, destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane, rischia anche di allargare un conflitto già complicatissimo. La nuova strategia di Trump dovrà fare i conti ad esempio con le resistenze della Turchia ad accettare come legittime le forze curde, a cui gli Stati Uniti sembrano essere intenzionati ad assegnare un ruolo ancora più importante nel conflitto. Soprattutto, però, la maggiore presenza e intraprendenza americana in Siria minaccia di scontrarsi con le operazioni militari della Russia in difesa del regime di Assad. Nonostante Trump avesse prospettato una qualche collaborazione con Mosca nella lotta all’ISIS anche in Siria, finora su questo fronte non sembrano esserci stati particolari progressi.
Soprattutto, però, la maggiore presenza e intraprendenza americana in Siria minaccia di scontrarsi con le operazioni militari della Russia in difesa del regime di Assad. Nonostante Trump avesse prospettato una qualche collaborazione con Mosca nella lotta all’ISIS anche in Siria, finora su questo fronte non sembrano esserci stati particolari progressi.
Anzi, gli sviluppi degli ultimi due mesi indicano piuttosto l’aggravamento del rischio di un confronto militare diretto tra le due principali potenze coinvolte in una guerra che continua a martoriare il paese mediorientale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Il misero spettacolo offerto questa settimana dal Congresso americano, nel corso delle prime audizioni pubbliche sul “caso” della presunta interferenza russa nelle elezioni presidenziali del novembre 2016, ha confermato come negli Stati Uniti sia in atto un’autentica caccia alle streghe, basata sul nulla, per spingere la nuova amministrazione Trump verso lo scontro aperto con il Cremlino.
Le testimonianze rilasciate alla commissione servizi segreti della Camera dei Rappresentanti dai direttori di FBI e NSA, James Comey e Michael Rogers, hanno generato un interesse enorme nella stampa ufficiale americana. Le parole di entrambi sono state però sfruttate quasi soltanto per alimentare un’operazione propagandistica in atto da tempo e che non ha finora trovato alcun reale riscontro nella realtà dei fatti né, peraltro, nelle stesse audizioni di lunedì.
Il punto centrale delle deposizioni raccolte dai deputati americani è stato senza dubbio la rivelazione da parte del numero uno dell’FBI dell’esistenza di un’indagine ufficiale sulle possibili “collusioni” tra Donald Trump, o membri del suo staff, e agenti del governo russo al fine di influenzare l’esito del voto per la Casa Bianca.
Questa vicenda ha prevedibilmente occupato quasi per intero un’audizione durata più di cinque ore. Al contrario, l’altra questione all’ordine del giorno, l’accusa di Trump di essere stato intercettato in campagna elettorale in seguito a un ordine diretto dell’ex presidente Obama, si è risolta in pochi minuti dopo che lo stesso Comey ha assicurato di non avere elementi per confermare quanto sostenuto per la prima volta lo scorso 4 di marzo in un “tweet” scritto dal miliardario newyorchese.
Le modalità con cui le due vicende sono state trattate lunedì in un’aula del Congresso di Washington riflettono l’attitudine dei media “mainstream” in queste settimane. L’accusa di Trump è stata cioè scartata rapidamente come una delle solite uscite bizzarre del neo-presidente, mentre le presunte operazioni di hackeraggio russe negli USA sarebbero del tutto reali e rappresenterebbero una seria minaccia alla democrazia americana.
In realtà, per entrambe le accuse non esiste una sola prova concreta presentata pubblicamente che ne attesti l’attendibilità. Lo stesso Comey ha ricalcato in sostanza il copione della stampa nel suo intervento, limitandosi a interpretare in maniera ridicola il pensiero e le azioni del presidente russo Putin per spiegare l’intervento del suo governo nelle elezioni, così da favorire Trump o, più precisamente, per danneggiare la candidatura di Hillary Clinton.
Il tono surreale dell’audizione di lunedì è stato dato dal discorso di apertura del numero uno dell’opposizione nella commissione servizi segreti, il deputato Democratico della California Adam Schiff. Quest’ultimo ha riassunto in pochi minuti le teorie cospirazioniste fatte proprie dal suo partito per offrire un resoconto dell’interferenza russa nel processo elettorale americano basato su una serie di “fake news”, ampiamente screditate o smentite da analisi indipendenti, o su rivelazioni e rapporti provenienti da non meglio definite fonti all’interno dell’intelligence USA.
La natura artificiosa e del tutto politica del circo messo in piedi in particolare dal Partito Democratico contro Trump è provata anche dal fatto che, come hanno spiegato i giornali americani, l’FBI è solito rivelare l’esistenza di indagini in corso solo “in rare circostanze”.
Per il suo direttore, quello relativo ai legami tra gli uomini di Trump ed esponenti del governo di Mosca sarebbe un caso di “pubblico interesse” che giustifica la rivelazione delle indagini. Piuttosto, l’iniziativa di Comey è motivata dal fatto che le accuse rivolte a Trump e al Cremlino, non avendo alcun fondamento nella realtà, necessitano di un’ampia risonanza pubblica attraverso l’azione coordinata dei media, dei politici e, ora, dei vertici della sicurezza nazionale, la cui indipendenza e imparzialità viene data per scontata. L’FBI, così come la NSA o la CIA, è invece tutt’altro che estraneo alle lotte politiche all’interno della classe dirigente d’oltreoceano. L’attuale direttore Comey, d’altra parte, proprio alla vigilia delle presidenziali di novembre era stato protagonista di un’uscita pubblica, giudicata universalmente inopportuna e contraria al tacito impegno dell’FBI di non influenzare il processo elettorale.
L’FBI, così come la NSA o la CIA, è invece tutt’altro che estraneo alle lotte politiche all’interno della classe dirigente d’oltreoceano. L’attuale direttore Comey, d’altra parte, proprio alla vigilia delle presidenziali di novembre era stato protagonista di un’uscita pubblica, giudicata universalmente inopportuna e contraria al tacito impegno dell’FBI di non influenzare il processo elettorale.
Singolarmente e a conferma dell’esistenza di uno scontro durissimo nel cuore dei poteri dello stato, in quell’occasione l’intervento di Comey aveva con ogni probabilità penalizzato Hillary Clinton, a carico della quale aveva annunciato l’esistenza di un’indagine per l’uso di un server di posta elettronica non governativo durante il mandato della ex first lady alla guida del dipartimento di Stato.
Lunedì, il direttore dell’FBI non ha in effetti aggiunto nulla di concreto alle teorie anti-russe che circolano a Washington, ma ha anzi ammesso in sostanza che eventuali responsabilità di Mosca e dello stesso Trump o dei suoi fedelissimi sono tutte da indagare. Quali siano i fatti o gli indizi che giustifichino un’iniziativa in questo senso a carico del presidente degli Stati Uniti continuano però a non essere spiegati.
Comey, oltretutto, ha ammesso che non esistono prove del fatto che eventuali cyber-operazioni russe abbiano contribuito a modificare l’esito del voto che ha portato Trump alla Casa Bianca. Questa affermazione, assieme agli altri elementi della vicenda, solleva ancor più l’interrogativo su quale sia esattamente il contenuto delle accuse rivolte alla Russia.
A ben vedere, le accuse di interferenza nelle elezioni sembrano essere tutt’al più scaturite da normali operazioni di intelligence debitamente ingigantite e che senza dubbio Mosca conduce ai danni degli Stati Uniti, così come però questi ultimi fanno, con ogni probabilità in maniera più aggressiva, nei confronti della Russia e di altri paesi.
L’intera operazione montata contro l’amministrazione Trump serve a impedire qualsiasi forma di disgelo tra Washington e Mosca, in modo da garantire che gli orientamenti strategici anti-russi promossi dall’apparato militare e della sicurezza nazionale americano, rappresentato dal Partito Democratico e da una parte di quello Repubblicano, continuino a essere al centro della politica estera americana, così come lo sono stati negli otto anni di presidenza Obama.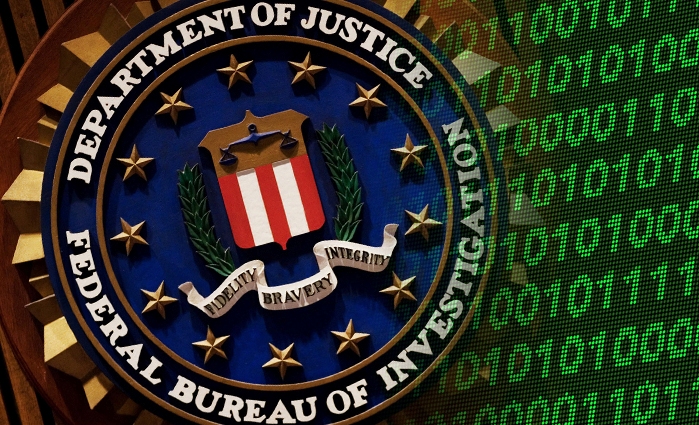 Il clima da maccartismo, alimentato da iniziative come quella inaugurata lunedì dalla commissione servizi segreti della Camera dei Rappresentanti di Washington, ha inoltre l’obiettivo di ostacolare il coagularsi di un’opposizione popolare progressista contro l’agenda ultra-reazionaria dell’amministrazione Trump, in modo da indirizzarla verso una campagna anti-russa ugualmente reazionaria e guerrafondaia.
Il clima da maccartismo, alimentato da iniziative come quella inaugurata lunedì dalla commissione servizi segreti della Camera dei Rappresentanti di Washington, ha inoltre l’obiettivo di ostacolare il coagularsi di un’opposizione popolare progressista contro l’agenda ultra-reazionaria dell’amministrazione Trump, in modo da indirizzarla verso una campagna anti-russa ugualmente reazionaria e guerrafondaia.
La testimonianza del direttore dell’FBI segna così l’inizio di un processo politico che vedrà pendere sulla nuova amministrazione la perpetua minaccia di un’incriminazione per i presunti rapporti del presidente con il governo russo. Come ha spiegato il direttore dell’FBI, infatti, l’indagine in corso non è di natura “criminale”, bensì “contro-spionistica”, caratterizzata cioè da tempi lunghissimi, da accuse vaghe molto difficilmente dimostrabili e, soprattutto, dalla scarsa probabilità di sfociare in una qualche incriminazione formale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il mancato accordo tra i membri del G-20 sull’inserimento del consueto appello a “resistere a ogni forma di protezionismo” commerciale nel comunicato finale, seguito al vertice dello scorso fine settimana in Germania, ha segnato probabilmente uno snodo cruciale nell’evoluzione sia dei rapporti tra le principali potenze economiche del pianeta sia della crisi del sistema di regole costruito dopo il secondo conflitto mondiale.
I ministri delle Finanze riuniti a Baden Baden sono riusciti a concordare una blanda dichiarazione che ha semplicemente affermato l’impegno a “rafforzare il contributo del commercio” alle economie dei rispettivi paesi. Il rappresentante del governo americano, Steven Mnuchin, ha inoltre chiesto e ottenuto un riferimento alla necessità di “ridurre gli squilibri globali”, ovvero di porre rimedio al deficit della bilancia commerciale che gli Stati Uniti fanno segnare con molti paesi.
Secondo le ricostruzioni della stampa, a favore degli USA si sarebbe schierato solo il Giappone, anche se in maniera tiepida e per un preciso calcolo politico-strategico, mentre praticamente tutti gli altri paesi membri si sono mostrati contrari alla mancata condanna ufficiale delle pratiche protezioniste.
La distanza tra le prese di posizione ufficiali dei G-20 nel recente passato e quelle dell’ultimo summit dipende in primo luogo dall’agenda ultra-nazionalista dell’amministrazione Trump. Mnuchin ha cioè bloccato un comunicato che avrebbe contraddetto apertamente le iniziative e le promesse fatte dalla Casa Bianca in ambito commerciale.
Nelle scorse settimane, così come in campagna elettorale, Trump e il suo staff hanno prospettato, tra l’altro, l’imposizione di dazi doganali sulle merci in ingresso negli Stati Uniti e misure punitive nei confronti di paesi esportatori, come Germania e Cina, fino a minacciare di ignorare le decisioni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) se esse dovessero risultare contrarie agli interessi americani.
Al G-20, vista l’esplosività della questione e l’inopportunità di aprire uno scontro aperto con un’amministrazione americana appena insediatasi, ha prevalso la mediazione tra le posizioni di Washington e quelle degli altri paesi. Tuttavia, la volontà di evitare una rottura e il probabile naufragio del G-20 stesso ha soltanto rinviato l’esplosione a tutti gli effetti di una crisi della governance globale che il “fenomeno” Trump ha accelerato nel tentativo di salvare il capitalismo americano a spese del resto del mondo.
Il possibile riemergere di guerre doganali e delle tendenze protezioniste, che già contribuirono in maniera decisiva allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, risponde a una logica distruttiva, secondo la quale gli Stati Uniti devono adottare provvedimenti di questo genere per invertire il proprio declino economico, attribuito in primo luogo al deficit commerciale registrato nei confronti di Berlino o Pechino.
Com’è puntualmente successo in passato, l’applicazione di dazi e tasse sulle importazioni da parte di un determinato paese spinge quelli colpiti a mettere in atto ritorsioni simili, provocando un’escalation che rischia di spostarsi facilmente dall’ambito commerciale a quello militare.
Dopo il vertice di Baden Baden, alcuni leader dei G-20 hanno cercato di fare buon viso a cattivo gioco e di minimizzare il conflitto con Washington. L’ospite del summit, il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha fatto riferimento alla necessaria prudenza di un’amministrazione che, come quella americana, ha assunto pieni poteri solo da un paio di mesi.
L’esito del G-20 e le posizioni americane hanno però smentito del tutto lo stesso Schäuble, il quale solo qualche giorno prima del summit aveva lanciato un appello per un sistema commerciale globale “multilaterale, basato su un sistema di regole condiviso, trasparente, non discriminatorio, aperto e inclusivo”.
Questo modello è stato da subito messo in discussione dall’amministrazione Trump e le scintille anche con paesi formalmente alleati degli Stati Uniti, come appunto la Germania, non erano mancate nelle scorse settimane. Alla minaccia del presidente USA di applicare un dazio del 35% sulle automobili tedesche importante in America, il ministro dell’Economia di Berlino, Brigitte Zypries, aveva ad esempio minacciato un ricorso al WTO, alludendo sarcasticamente a una possibile nuova sconfitta di Trump nei tribunali dopo quelle collezionate con i due bandi anti-migranti firmati di recente dal presidente. L’epilogo del G-20 di Baden Baden segna dunque anche formalmente l’allontanamento dalle modalità consensuali con cui le principali potenze economiche del pianeta si erano impegnate a risolvere le conseguenze della crisi finanziaria del 2008-2009.
L’epilogo del G-20 di Baden Baden segna dunque anche formalmente l’allontanamento dalle modalità consensuali con cui le principali potenze economiche del pianeta si erano impegnate a risolvere le conseguenze della crisi finanziaria del 2008-2009.
In realtà, le tendenze protezionistiche non sono state inaugurate dall’amministrazione Trump, né sono limitate agli Stati Uniti, dal momento che rappresentano la manifestazione di contraddizioni oggettive del sistema capitalistico.
Come ha ricordato un commento apparso in questi giorni sul sito web della testata tedesca Deutsche Welle, il protezionismo è tornato a ripresentarsi da qualche tempo, malgrado i governi di tutto il mondo negli ultimi anni abbiano “sempre promesso gli uni agli altri di promuovere il libero commercio e di ridurre le barriere doganali”. A partire dal 2008, infatti, il WTO ha registrato, tra i paesi che ne fanno parte, l’implementazione di più di duemila provvedimenti restrittivi del libero commercio.
Queste tendenze erano però state sempre smentite a livello ufficiale, in particolare nel corso delle riunioni dei G-20, mentre i negoziati per trattati di libero scambio tra gli USA e l’Europa (TTIP) e tra gli USA e una manciata di paesi asiatici e del continente americano (TPP) indicavano l’esistenza di uno sforzo, guidato da Washington, per rafforzare un sistema di regole condiviso per il commercio globale, sia pure nell’interesse primario del capitalismo americano.
Solo lo scorso mese di luglio, poi, il G-20 di Chengdu, in Cina, aveva concluso i lavori emettendo un comunicato ufficiale nel quale vi erano numerosi riferimenti al “libero commercio” e l’impegno a combattere “ogni forma di protezionismo”.
L’ingresso di Trump alla Casa Bianca ha invece segnato una rottura anche formale in questo senso. Il nuovo presidente ha subito fermato il processo di approvazione del TPP, così come ha promesso una revisione del trattato di libero scambio NAFTA con Canada e Messico.
L’inversione di rotta rispetto all’amministrazione Obama consiste nell’abbandonare il multilateralismo e i metodi apparentemente cooperativi nella promozione degli interessi delle corporation americane, privilegiando un’attitudine più aggressiva nella ricerca di accordi, preferibilmente bilaterali, che risultino apertamente favorevoli agli Stati Uniti.
Visti gli equilibri commerciali tra questi ultimi e paesi come Cina o Germania, nonché alla luce della spietata competizione per l’accaparramento di nuovi mercati a livello internazionale, è evidente che l’accelerazione protezionistica di Washington rischia di fare esplodere gravissimi conflitti nel prossimo futuro.
Berlino, ad esempio, basa la propria potenza economica e la propria stabilità interna sull’export, così da rendere straordinariamente delicata qualsiasi alterazione a proprio sfavore della situazione attuale. Secondo i dati del governo americano, le compagnie tedesche nel solo 2016 hanno esportato negli USA beni per oltre 114 miliardi di dollari e il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Germania nello stesso anno è stato di quasi 65 miliardi di dollari.
Come già accennato, i precedenti storici ricordano che l’escalation del protezionismo raramente ha conseguenze limitate al solo ambito economico-commerciale. Un commento al vertice di Baden Baden del Wall Street Journal ha spiegato come l’adozione di nuovi dazi e barriere doganali, oltre a minacciare la crescita economica globale, “potrebbe inasprire le tensioni geopolitiche”.
La situazione più calda in questo senso è quella della penisola di Corea, dove lo scontro tra Washington e Seoul da una parte e il regime di Pyongyang dall’altra si intreccia con le manovre americane per contenere l’espansione della Cina, non a casa bersaglio principale, assieme alla Germania, della polemica sugli “squilibri” commerciali globali. Gli scenari descritti stanno determinando infine un rimescolamento delle relazioni internazionali. Oltre a provocare frizioni con i propri alleati europei, le inclinazioni dell’amministrazione Trump spingono questi ultimi a occupare gli spazi lasciati liberi dagli USA, quanto meno in ambito commerciale.
Gli scenari descritti stanno determinando infine un rimescolamento delle relazioni internazionali. Oltre a provocare frizioni con i propri alleati europei, le inclinazioni dell’amministrazione Trump spingono questi ultimi a occupare gli spazi lasciati liberi dagli USA, quanto meno in ambito commerciale.
Subito dopo la chiusura del G-20, la cancelliera tedesca Merkel ha incontrato il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, con il quale ha preso apertamente le distanze dalle tendenze protezionistiche del nuovo governo americano. Il faccia a faccia ha preceduto l’incontro di martedì tra lo stesso premier nipponico e il presidente della Commissione europea Juncker con al centro la conclusione dei negoziati per un trattato di libero scambio tra Tokyo e Bruxelles, avviati formalmente già nel 2013.
In precedenza, il commissario europeo per il Commercio, Cecilia Malmström, aveva messo in chiaro la strategia dell’Unione, interessata ad accordi simili anche con Messico, Filippine e Indonesia, in quella che apparirebbe come una vera e propria interferenza, difficilmente ignorabile dall’amministrazione Trump, con gli interessi degli Stati Uniti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La corsa verso destra delle principali forze politiche olandesi nelle elezioni legislative di mercoledì è stata vinta dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) dell’attuale primo ministro, Mark Rutte. I liberali al governo avevano fatto propria buona parte dell’agenda di estrema destra del Partito per le Libertà di Geert Wilders (PVV), considerato il vero sconfitto del voto, puntando sulla promozione di sentimenti xenofobi anti-islamici per contenere i riflessi negativi delle politiche di austerity adottate negli ultimi cinque anni.
I sondaggi avevano correttamente anticipato una certa flessione del PVV dopo le previsioni di qualche mese fa che sembravano doverlo trasformare nel primo partito d’Olanda. Alla fine, Wilders e i suoi hanno aggiunto appena 5 seggi ai 15 che già occupavano nella “Tweede Kamer”, ovvero la camera bassa elettiva del parlamento de L’Aia.
Con poco più del 13% dei voti, il PVV è comunque il secondo partito olandese, dietro al VVD di Rutte. Quest’ultimo, nonostante i toni trionfalistici dei suoi leader e le reazioni sollevate di quelli europei, ha fatto segnare una netta flessione, passando dal 26,6% del 2012 al 21,3% odierno e da 41 a 33 seggi sui 150 totali.
Il VVD è sembrato beneficiare in maniera relativa dell’allontanamento dal PVV di Wilders di una parte di elettori orientati vero la destra estrema, grazie anche alla radicalizzazione del messaggio politico del primo ministro e, nei giorni che avevano preceduto l’apertura delle urne, agli effetti dello scontro con il governo della Turchia sul divieto imposto ad alcuni ministri di Ankara a tenere comizi in Olanda.
Ciò ha limitato parzialmente i danni per un partito che ha in ogni caso perso un numero importante di elettori. Il prezzo più caro per il sostegno al governo uscente lo ha pagato però il Partito Laburista di centro sinistra (PvdA), crollato dal 25% al 6%, con una perdita netta di ben 29 seggi.
La fuga degli elettori dai due partiti che formavano la coalizione di governo ha regalato qualche seggio in più a varie formazioni moderate e centriste, alcune delle quali si erano peraltro allineate al clima populista e di ostilità verso i migranti che ha dominato la campagna elettorale olandese. Così è stato soprattutto per i Cristiano Democratici (CDA), i quali hanno guadagnato 6 seggi grazie a un progresso di circa 4 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni.
Il CDA è stato a lungo forza di governo negli scorsi decenni e, da ultimo, tra il 2010 e il 2012 sotto la guida di Rutte. Vista la frammentazione del quadro politico olandese dopo il voto di mercoledì, è probabile che i Cristiano Democratici possano tornare a far parte dell’esecutivo olandese nell’immediato futuro.
In generale, anche in Olanda si è confermata la tendenza alla dispersione del voto, con i tradizionali partiti più importanti sempre meno in grado di intercettare la maggioranza dei consensi. Secondo alcuni dati riportati dalla stampa internazionale, nel 1986 i primi tre partiti olandesi raccoglievano complessivamente l’85% dei voti, mentre nel 2003 questa quota era scesa al 74% ed è oggi al 45%.
Se il clima di intolleranza che ha prevalso nelle scorse settimane ha finito per premiare con due seggi un altro partito di estrema destra da poco fondato, l’ultra-nazionalista e anti-europeista “Forum voor Democratie” (FvD), i segnali provenienti dagli elettori sono stati anche di segno diametralmente opposto. La frustrazione nei confronti dell’establishment e del pensiero unico neo-liberista non ha infatti preso solo la strada del populismo di destra, ma ha premiato anche qualche formazione di (centro-)sinistra. Il Partito Socialista ex maoista (SP) ha aumentato di un solo seggio la sua delegazione in parlamento, ma i Verdi-Sinistra (GL) hanno più che triplicato i loro consensi, passando da 4 a 14 seggi.
La frustrazione nei confronti dell’establishment e del pensiero unico neo-liberista non ha infatti preso solo la strada del populismo di destra, ma ha premiato anche qualche formazione di (centro-)sinistra. Il Partito Socialista ex maoista (SP) ha aumentato di un solo seggio la sua delegazione in parlamento, ma i Verdi-Sinistra (GL) hanno più che triplicato i loro consensi, passando da 4 a 14 seggi.
L’immagine di modernità proiettata dal leader di quest’ultimo partito, il 30enne di origine marocchino-indonesiana Jesse Klaver, ha contribuito al raggiungimento di questo risultato, anche se ancora più determinanti sembrano essere state le posizioni anti-razziste e a favore dell’accoglienza di immigrati e rifugiati promosse dal suo partito in campagna elettorale.
L’aspetto più singolare dell’esito del voto in Olanda è stato però probabilmente l’entusiasmo manifestato dal partito del primo ministro Rutte e dai leader di molti governi europei per avere scongiurato l’ondata populista e xenofoba con la relativa sconfitta del PVV di Wilders.
L’euforia e l’auto-compiacimento che hanno caratterizzato le reazioni post-voto sono totalmente ingiustificate. I liberali olandesi, pur avendo vinto le elezioni, hanno visto una netta erosione dei consensi e, soprattutto, si sono confermati la prima forza politica dopo avere impostato una campagna elettorale nei termini dell’estrema destra. Ciò ha spinto il baricentro politico di questo paese ancor più verso destra e ha fatto in modo che la voce di Wilders rimanga influente nei prossimi cinque anni.
Pur nel riconoscere il mancato sfondamento, il leader del PVV ha espresso una certa soddisfazione, spiegando che il suo partito è tutto fuorché sconfitto e giocherà anzi un ruolo di spicco nella legislatura entrante, sia pure dall’opposizione. Soprattutto, l’estrema destra olandese sarà in grado di capitalizzare la debolezza di un governo che risulterà probabilmente debole, vista la necessità di mettere assieme una coalizione di almeno tre-quattro partiti, e che manterrà la stessa rotta di quello uscente per quanto riguarda le politiche economiche.
Archiviato il voto, Mark Rutte inizierà a breve i sondaggi e le trattative per la formazione della nuova maggioranza di governo. Secondo la stampa olandese, i partiti che hanno le maggiori probabilità di entrare in una nuova coalizione sono quelli cristiano-democratici, il CDA ma anche il più piccolo CU (“Unione Cristiana), seguiti dai social-liberali” Democratici 66 (D66), anch’essi in netta ascesa dopo il voto di mercoledì. Il numero relativamente esiguo di seggi rimasti al partito del premier richiede un appoggio piuttosto ampio per far nascere il nuovo governo, così che i negoziati potrebbero essere lunghi e complicati. Il VVD parte infatti da una posizione più debole rispetto a cinque anni fa. Inoltre, a complicare il quadro sono anche le differenze ideologiche tra i partiti cristiani e i D66, nonché la prudenza di tutti questi ultimi nell’abbracciare un progetto di governo che rischia di tradursi in un rapido deterioramento della loro popolarità appena ritrovata.
Il numero relativamente esiguo di seggi rimasti al partito del premier richiede un appoggio piuttosto ampio per far nascere il nuovo governo, così che i negoziati potrebbero essere lunghi e complicati. Il VVD parte infatti da una posizione più debole rispetto a cinque anni fa. Inoltre, a complicare il quadro sono anche le differenze ideologiche tra i partiti cristiani e i D66, nonché la prudenza di tutti questi ultimi nell’abbracciare un progetto di governo che rischia di tradursi in un rapido deterioramento della loro popolarità appena ritrovata.
Le esperienze dei due gabinetti guidati da Rutte dopo il voto del 2010 e quello del 2012 si sono infatti concluse in una disfatta per i partner di governo del VVD – rispettivamente il CDA e, appunto, il Partito Laburista – a causa delle politiche impopolari adottate. Le forze che accetteranno di entrare nella nuova maggioranza chiederanno perciò con ogni probabilità garanzie e concessioni non indifferenti, così da rendere particolarmente incerto il cammino del gabinetto che nascerà a L’Aia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Gli ultimi sviluppi della crisi che sta nuovamente investendo la penisola di Corea continuano a far crescere le preoccupazioni per l’esplosione di un possibile conflitto armato. Il comportamento del governo americano dopo l’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca ha evidenziato un’accelerazione dei preparativi per un confronto militare, diretto nell’immediato contro il regime nordcoreano, ma che rischia di coinvolgere anche l’unico vero alleato di quest’ultimo, vale a dire la Cina.
Quasi come ogni anno, il mese di marzo è contrassegnato da una drastica impennata delle tensioni in Asia nord-orientale, dovute alle tradizionali massicce esercitazioni militari tra le forze armate USA e quelle sudcoreane. Le manovre, denominate “Foal Eagle” e “Key Resolve” proseguiranno per alcune settimane e, in questa occasione, hanno l’obiettivo di simulare un attacco alle installazioni militari e ai centri del potere politico in Corea del Nord.
Pyongyang ha sempre visto con giustificato sospetto queste esercitazioni condotte ai propri confini dai suoi due principali nemici, rispondendo puntualmente con provocazioni che includono spesso test missilistici condannati dalla comunità internazionale. Settimana scorsa, infatti, il regime di Kim Jong-un aveva effettuato un lancio di quattro missili balistici, tre dei quali precipitati al largo delle coste giapponesi.
Alle tensioni già solitamente alle stelle, si è aggiunto quest’anno un clima infiammato dalle iniziative della nuova amministrazione Repubblicana a Washington, determinata a mettere da subito la Nord Corea al centro della propria strategia asiatica, diretta principalmente al contenimento della Cina.
Se ufficialmente Trump e il Pentagono stanno ancora elaborando la condotta da tenere nei confronti di Pyongyang, le indiscrezioni riportate dalla stampa e, soprattutto, le misure adottate in queste settimane lasciano pochi dubbi sul fatto che Washington possa includere anche un’aggressione militare preventiva tra le opzioni a propria disposizione.
Ciò è apparso evidente dalla notizia circolata in questo inizio di settimana sull’impiego in Corea del Sud di forze inequivocabilmente “offensive”. A circa 270 km a sud di Seoul sarà stazionata una flotta di droni “Grey Eagle”, ciascuno in grado di portare quattro missili aria-terra Hellfire e altrettante bombe “plananti” Viper Strike.
Un portavoce delle forze armate americane in Corea del Sud ha sottolineato come la presenza dei droni nella penisola rafforzerà le capacità di “sorveglianza” e la “raccolta di informazioni”, anche se la loro reale utilità sembra essere ben diversa, come hanno chiarito la stampa e fonti militari sudcoreane.
L’agenzia di stampa Yonhap ha spiegato ad esempio come le armi trasportate dai droni “Grey Eagle” siano in grado di “colpire le principali installazioni militari [nordcoreane]” situate in prossimità della “Linea di Demarcazione” che separa i due paesi fin dall’armistizio che mise fine alla guerra nel 1953. Inoltre, i droni potrebbero facilmente “distruggere i comandi militari a Pyongyang” ed eliminare lo stesso Kim Jong-un in caso di guerra.
Parallelamente a questa notizia, gli Stati Uniti fatto sapere di avere inviato in Corea del Sud una unità di forze speciali appartenenti ai “SEAL Team 6” per partecipare alle esercitazioni in corso. Questa squadra è la stessa che nel 2011 uccise in Pakistan Osama bin Laden e il suo potenziale compito in Corea del Nord è facilmente intuibile. Il ruolo delle forze speciali USA in Corea del Nord si comprende alla perfezione se si considera il contenuto del cosiddetto “OPLAN 5015”, concordato da Washington e Seoul già nel 2015. Questo piano dovrebbe delineare le azioni dei due alleati per abbattere il regime stalinista nordcoreano, secondo la testata giapponese Asahi Shimbun per mezzo di “guerriglia, assassinii [portati a termine] dalle forze speciali e attacchi mirati contro installazioni strategiche”. Soprattutto, “OPLAN 5015” prevede la possibilità di lanciare un attacco preventivo contro la Corea del Nord.
Il ruolo delle forze speciali USA in Corea del Nord si comprende alla perfezione se si considera il contenuto del cosiddetto “OPLAN 5015”, concordato da Washington e Seoul già nel 2015. Questo piano dovrebbe delineare le azioni dei due alleati per abbattere il regime stalinista nordcoreano, secondo la testata giapponese Asahi Shimbun per mezzo di “guerriglia, assassinii [portati a termine] dalle forze speciali e attacchi mirati contro installazioni strategiche”. Soprattutto, “OPLAN 5015” prevede la possibilità di lanciare un attacco preventivo contro la Corea del Nord.
Martedì, poi, nei mari della Corea del Sud è arrivata anche la portaerei a propulsione nucleare “Carl Vinson”, accolta dalle minacce del regime di Kim. Pyongyang ha denunciato i piani militari “irresponsabili” di Washington e Seoul, nonché prospettato attacchi “senza pietà” nel caso venissero violate “la sovranità e la dignità” del paese.
Un’altra iniziativa provocatoria dell’amministrazione Trump ha recentemente coinvolto in maniera diretta la Cina, oltre alla Corea del Nord. Dopo il già ricordato test missilistico di Pyongyang, gli USA e il governo di Seoul avevano avviato l’installazione sul territorio della Sud Corea del sistema antimissilistico americano THAAD (“Difesa d’area terminale ad alta quota”), già negoziato dall’amministrazione Obama.
Quest’arma serve a intercettare missili balistici a corto e medio raggio e dovrebbe ufficialmente proteggere la Corea del Sud da eventuali attacchi del vicino settentrionale. In realtà, il THAAD è rivolto in primo luogo alla Cina, da dove infatti sono giunte accese proteste e minacce poiché il sistema antimissilistico potrebbe neutralizzare il deterrente nucleare di Pechino.
La determinazione con cui l’amministrazione Trump intende perseguire le proprie politiche aggressive nei confronti della Corea del Nord era emersa anche settimana scorsa, quando era stata respinta seccamente una proposta avanzata dal governo cinese per fermare l’escalation in atto nella penisola. Il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, era stato protagonista di un’uscita insolita che rivelava l’ansia del suo governo per la situazione coreana, proponendo cioè lo stop alle esercitazioni militari tra USA e Corea del Sud in cambio di un congelamento del programma nucleare e missilistico di Pyongyang.
La risposta americana era giunta dall’ambasciatrice all’ONU, Nikki Haley, la quale aveva rifiutato categoricamente l’ipotesi di qualsiasi negoziato con il regime di Kim, riaffermando piuttosto la volontà USA di non escludere alcuna opzione nell’affrontare la questione nordcoreana.
L’evoluzione della crisi nella penisola coreana dopo il cambio alla presidenza degli Stati Uniti è la conseguenza dell’atteggiamento di un’amministrazione Trump che ha individuato la Cina come il principale ostacolo al dispiegamento dell’influenza americana nel continente asiatico.
Che la strategia nordcoreana degli USA si intrecci in maniera inestricabile con quella cinese è confermato ad esempio dal fatto che ogni iniziativa diretta contro Pyongyang è accompagnata da dichiarazioni o provvedimenti volti a esercitare pressioni su Pechino per richiamare all’ordine il proprio alleato. Il quadro in cui opera il nuovo governo americano è stato in ogni caso preparato dall’amministrazione Obama, la quale aveva inaugurato la cosiddetta “svolta” asiatica proprio per contrastare la crescente influenza economica, diplomatica e militare della Cina in Asia.
Il quadro in cui opera il nuovo governo americano è stato in ogni caso preparato dall’amministrazione Obama, la quale aveva inaugurato la cosiddetta “svolta” asiatica proprio per contrastare la crescente influenza economica, diplomatica e militare della Cina in Asia.
La strategia anti-cinese degli Stati Uniti ha così riacceso una serie di rivalità e di situazioni di crisi, tra cui quella tra le due Coree e le rivendicazioni territoriali e marittime nei mari al largo della Cina, che hanno moltiplicato il rischio dell’esplosione di un conflitto armato di ampia portata.
Proprio nel pieno dell’aggravarsi dello scontro nella penisola di Corea, infatti, il governo giapponese, anch’esso coinvolto in una serie di scontri diplomatici e (quasi) militari con Pechino in questi anni, ha annunciato l’invio della nave da guerra “Izumo” nell’oceano Indiano e nel Mar Cinese Meridionale, dove sarà impegnata per tre mesi a partire da maggio in operazioni di pattugliamento ed esercitazioni militari assieme alle flotte di India e Stati Uniti.
