- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Le sempre più inconsistenti basi su cui si fondano le accuse degli Stati Uniti contro il regime siriano di avere utilizzato armi chimiche in un attacco contro i “ribelli” il 21 agosto scorso nei pressi di Damasco, sono state ulteriormente screditate nella giornata di lunedì dalle dichiarazioni dell’insegnate belga Pierre Piccinin, compagno di prigionia per cinque mesi del reporter della Stampa, Domenico Quirico, nel paese mediorientale.
Poco prima dell’arrivo di quest’ultimo in Procura a Roma, Piccinin ha rilasciato un’intervista alla radio belga RTL nella quale, oltre a raccontare alcuni episodi del loro sequestro nelle mani degli integralisti islamici che compongono gran parte dell’opposizione al regime appoggiata dall’Occidente, ha sostenuto di essere certo del fatto che non siano state le forze di Bashar al-Assad ad avere fatto ricorso “al gas sarin o a un altro gas nella periferia di Damasco”.
Piccinin afferma di averne la certezza, dal momento che lui e Quirico hanno avuto modo di ascoltare direttamente una conversazione dei ribelli su questo argomento. La testimonianza dello storico belga appare estremamente rilevante, dal momento che egli, così come l’inviato della stampa, aveva manifestato un entusiasmo iniziale per i “ribelli” siriani. Piccinin ha evitato di fornire ulteriori dettagli in attesa degli interrogatori della Procura ma ha definito la sua presa di posizione sull’innocenza di Assad come “un dovere morale”.
Dopo essere venuti a conoscenza delle responsabilità dei “ribelli” nei fatti di Ghouta, serviti a Washington per scatenare una campagna propagandistica volta a legittimare un intervento armato in Siria, il 31 agosto Piccinin e Quirico hanno appreso dei piani di guerra dell’amministrazione Obama. I due, perciò, avevano “la testa in fiamme”, perché “prigionieri laggiù con questa informazione [dell’innocenza del regime] senza la possibilità di diffonderla”.
Le dichiarazioni di Piccinin non devono essere state particolarmente gradite dal direttore della Stampa, Mario Calabresi, né dallo stesso Quirico, il quale è successivamente intervenuto cercando di gettare acqua sul fuoco pur confermando le parole del compagno di prigionia. Il giornalista del quotidiano torinese ha ribadito di avere ascoltato la conversazione sull’attacco con armi chimiche nella quale si diceva chiaramente come l’operazione fosse stata condotta dai “ribelli come provocazione per indurre l’Occidente a intervenire militarmente”. Allo stesso tempo, Quirico ha affermato di non avere elementi per giudicare o appurare la veridicità di quanto ascoltato, aggiungendo che sarebbe “folle dire che io sappia che non è stato Assad a usare i gas”.
Se gli scrupoli di Quirico appaiono legittimi, la sua testimonianza diretta rimane un elemento di estrema rilevanza, soprattutto alla luce delle “prove” presentate dagli Stati Uniti e dai loro alleati a sostegno della tesi opposta e che consistono, tra l’altro, in filmati realizzati dai “ribelli” e in dubbie intercettazioni telefoniche frutto degli sforzi dell’intelligence israeliana.
La liberazione di Quirico e Piccinin è stata poi commentata dai vertici del cosiddetto Esercito Libero della Siria (ELS) che ha scaricato le responsabilità del rapimento sul Fronte al-Nusra, una delle principali formazioni integraliste affiliata ad al-Qaeda che compongono la galassia dell’opposizione anti-Assad. Il portavoce dell’ELS, secondo il quale anche il gesuita sostenitore del regime Paolo Dall’Oglio sarebbe nelle mani di al-Nusra, ha poi cercato di confondere le idee all’opinione pubblica internazionale, sostenendo che questo gruppo fondamentalista sarebbe “estraneo alla rivoluzione”, in quanto “più vicino al regime che alle opposizioni che combattono Assad”.
I tentativi di ripulire la propria immagine da parte dell’ELS sono però quanto meno patetici, visto che questa organizzazione screditata opera a fianco dei raggruppamenti affiliati al terrorismo internazionale sunnita, di fatto sfruttati anche dall’Occidente, dalla Turchia e dalle monarchie assolute del Golfo Persico come avanguardia nella lotta per la rimozione di Assad.
In maniera ancora più assurda e nel tentativo disperato di occultare quella che appare come una vera e propria alleanza tra, da una parte, i “ribelli” secolari e l’Occidente e, dall’altra, guerriglieri gravitanti nell’orbita di al-Qaeda, il portavoce dell’ELS ha infine sostenuto che padre Dall’Oglio sarebbe stato catturato “per assecondare una richiesta da parte di Damasco finalizzata a screditare la rivoluzione”.
Ciò che appare inesorabilmente screditata, in realtà, non è solo la stessa presunta “rivoluzione” in corso in Siria ma anche e sempre più la pretesa degli Stati Uniti sia di essere in possesso di prove certe della responsabilità di Assad nell’attacco con armi chimiche a Ghouta sia di volere condurre un’operazione militare contro la Siria di portata limitata. Sulla base delle false accuse denunciate anche da Pierre Piccinin, infatti, l’amministrazione Obama sta cercando un’autorizzazione formale del Congresso di Washington per portare a termine un’aggressione militare a tutto campo che ben poco ha a che vedere con l’uso di armi chimiche e che mira invece a provocare un cambio di regime a Damasco.
Sulla base delle false accuse denunciate anche da Pierre Piccinin, infatti, l’amministrazione Obama sta cercando un’autorizzazione formale del Congresso di Washington per portare a termine un’aggressione militare a tutto campo che ben poco ha a che vedere con l’uso di armi chimiche e che mira invece a provocare un cambio di regime a Damasco.
Come ha confermato un articolo pubblicato domenica dal Los Angeles Times, il Pentagono starebbe ultimando i preparativi per uno sforzo bellico di ampia portata, con bombardamenti previsti per un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto affermato pubblicamente dal governo statunitense.
A parlare al quotidiano californiano sono stati anonimi ufficiali dell’esercito, secondo i quali la Casa Bianca avrebbe inoltre chiesto al Dipartimento della Difesa di “espandere la lista degli obiettivi da colpire”, oltre ai 50 inizialmente selezionati.
I piani del Pentagono confermano l’imminenza di una guerra dalle conseguenze rovinose e con un numero elevatissimo di vittime. In particolare, la forza di fuoco americana si baserebbe sull’uso di missili Tomahawk lanciati da cinque navi da guerra già posizionate nel Mediterraneo e su possibili incursioni di aerei militari. Lo scopo della guerra, in definitiva, risulta essere quello di “degradare” le possibilità di difesa del regime di Damasco, in preparazione di ulteriori iniziative tutt’altro che da escludere come l’imposizione di una no-fly zone o, addirittura, un’invasione con truppe di terra.
Secondo i media americani, la decisione di utilizzare maggiore forza rispetto ai piani originari servirebbe ad assicurare agli USA l’effettiva distruzione dei bersagli eventualmente mancati nella prima fase delle operazioni e a punire possibili ritorsioni da parte delle forze regolari siriane. In altre parole, la più che legittima difesa di Assad contro un’aggressione criminale verrebbe utilizzata da Washington per infliggere una nuova e ancora più dura punizione all’esercito e alla popolazione della Siria.
Assieme al procedere della macchina della propaganda americana continuano in ogni caso ad emergere anche le contraddizioni di un’operazione che viola ogni norma del diritto internazionale. Se il governo americano nel fine settimana ha diffuso una serie di filmati di dubbia autenticità che mostrano alcune vittime delle armi chimiche a Ghouta senza provare minimamente chi siano i responsabili dell’accaduto, gli stessi vertici dell’amministrazione Obama hanno nuovamente dovuto ammettere di non avere alcuna certezza circa la colpevolezza di Assad.
In un blitz nei talk show trasmessi dalle principali reti televisive USA nella giornata di domenica, ad esempio, il capo di gabinetto della Casa Bianca, Denis McDonough, ha riconosciuto che il suo governo non dispone di “prove irrefutabili che vadano al di là di ogni ragionevole dubbio” sui fatti di Ghouta.
Anche all’interno della comunità dell’intelligence a stelle e strisce, d’altra parte, non sembra esserci stata alcuna unanimità di giudizio sull’attacco del 21 agosto con gas sarin o altri agenti chimici letali. La versione propagandata dalla Casa Bianca e dagli uomini di Obama alla stampa e nelle varie audizioni al Congresso nei giorni scorsi, come ha rivelato un’indagine del giornalista americano Gareth Porter uscita lunedì sul sito web dell’agenzia di stampa IPS News, non è infatti basata sulla effettiva valutazione dei servizi segreti ma riflette piuttosto una decisione presa in maniera unilaterale dall’amministrazione democratica. In sostanza, scrive Porter, “la Casa Bianca ha selezionato quegli elementi delle analisi dell’intelligence che supportavano i piani dell’amministrazione di colpire militarmente il governo siriano e ha escluso invece quelli andavano contro questi stessi piani”.
In sostanza, scrive Porter, “la Casa Bianca ha selezionato quegli elementi delle analisi dell’intelligence che supportavano i piani dell’amministrazione di colpire militarmente il governo siriano e ha escluso invece quelli andavano contro questi stessi piani”.
L’amministrazione Obama, in definitiva, aveva da tempo programmato un’aggressione contro la Siria in attesa di un’occasione propizia, come lo è stato appunto il presunto attacco con armi chimiche a Ghouta con ogni probabilità opera dei “ribelli” stessi, in seguito alla quale ha presentato una propria valutazione basata sulla manipolazione degli stessi rapporti delle agenzie di intelligence americane.
Ancora più delle manovre che portarono all’invasione e alla devastazione dell’Iraq nel 2003, dunque, un’amministrazione Obama sempre più isolata e screditata sta procedendo in maniera spedita verso un’altra guerra criminale dalle conseguenze incalcolabili esclusivamente sulla base di menzogne e prove senza fondamento, così da abbattere un regime sgradito ed espandere la propria influenza nella regione mediorientale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Le manovre e i discutibili colpi di mano messi disperatamente in atto alla vigilia delle elezioni generali di sabato scorso non sono servite al Partito Laburista australiano ad evitare una chiara sconfitta e il ritorno al potere del Partito Liberale in una coalizione di centro-destra. I risultati ufficiali hanno così decretato il netto successo di quest’ultima che potrà contare alla Camera bassa su una maggioranza di 85 seggi sui 150 totali contro i circa 54 ottenuti dai laburisti.
Negli ultimi tre anni il “Labor” è stato segnato da conflitti intestini che hanno prodotto due cambi al vertice del partito e del governo in seguito ad altrettanti golpe interni. Dapprima, nel 2010 Julia Gillard era riuscita ad estromettere l’allora primo ministro Kevin Rudd in un’operazione appoggiata da Washington per bloccare sul nascere i timidi sforzi del leader laburista di favorire una convivenza pacifica tra Stati Uniti e Cina in Estremo Oriente.
Successivamente, lo scorso mese di giugno lo stesso Rudd era stato clamorosamente riportato alla guida del partito di centro-sinistra e del governo di Canberra nell’estremo tentativo di evitare la prevedibile batosta alle urne. L’impopolare Gillard era stata così rimossa e sostituita con un leader che manteneva un qualche favore tra gli elettori soprattutto per le modalità anti-democratiche con cui era stato messo da parte tre anni prima.
Il crollo dei consensi per il Partito Laburista non è comunque legato esclusivamente agli eventi di questi ultimi anni. Come buona parte dei partiti di sinistra o centro-sinistra europei e nordamericani, anche il Labor australiano aveva visto crollare la propria credibilità tra la tradizionale base elettorale - lavoratori e classi più disagiate - già tra gli anni Ottanta e Novanta, con governi che avevano abbandonato i programmi di riforma sociale per mettere in atto politiche di liberalizzazione dell’economia.
Il ritorno al potere nel 2007 era stato dovuto perciò in gran parte alla profonda impopolarità del governo liberale-nazionale del premier John Howard, in particolare per il suo entusiastico appoggio alla “guerra al terrore” ideata dall’amministrazione Bush e la partecipazione alle invasioni di Afghanistan e Iraq. Nelle elezioni del 2010, infine, il Partito Laburista era riuscito a rimanere al potere creando un governo di minoranza la cui sopravvivenza è stata finora garantita da una manciata di parlamentari indipendenti. Il premier uscente Rudd, in ogni caso, è riuscito a mantenere il suo seggio in Parlamento per lo stato del Queensland ma ha rapidamente riconosciuto la sconfitta a livello nazionale, sia pure meno pesante del previsto, e consegnato di fatto le redini del governo al leader del Partito Liberale, Tony Abbott.
Il premier uscente Rudd, in ogni caso, è riuscito a mantenere il suo seggio in Parlamento per lo stato del Queensland ma ha rapidamente riconosciuto la sconfitta a livello nazionale, sia pure meno pesante del previsto, e consegnato di fatto le redini del governo al leader del Partito Liberale, Tony Abbott.
Gli equilibri al Senato, invece, sono ancora tutti da verificare anche a causa di un complesso sistema elettorale. Il centro-destra australiano, però, dovrebbe avere una maggioranza meno netta nella Camera alta, dove oltretutto i nuovi eletti verranno insediati solo nel luglio del 2014.
Noto per le proprie posizioni estremamente conservatrici sulle questioni sociali, Abbott è stato per due volte ministro nei governi Howard e le descrizioni a lui riservate dai media internazionali non mancano di ricordare la sua ossessione per la forma fisica e gli studi in un seminario cattolico.
A dare una spinta decisiva alla sua candidatura è stata anche l’incessante campagna a suo favore e contro il Labor condotta dai giornali australiani facenti parte dell’impero mediatico di Rupert Murdoch. L’entusiasmo popolare per Abbott, d’altra parte, risulta estremamente limitato, come conferma il fatto che quasi tutti i sondaggi fino a pochi giorni dal voto indicavano livelli di gradimento superiori per Kevin Rudd nonostante l’avversione generale per il Partito Laburista.
In campagna elettorale, Abbott e il partner di coalizione dei liberali - il Partito Nazionale, tradizionalmente espressione dei proprietari terrieri - hanno promosso soprattutto due iniziative per la soppressione di altrettante misure adottate dal governo Gillard, la prima delle quali costantemente definita come “impopolare” dalla stampa ufficiale: una modesta quanto inefficace “super-tassa” sui profitti dei colossi estrattivi australiani e il mercato delle emissioni dei gas serra, ritenuto il più vasto al mondo dopo quello europeo.
Tra i punti centrali del suo programma elettorale, oltre alla riduzione del carico fiscale per la maggior parte delle imprese, c’è poi un costoso e controverso piano pubblico per finanziare permessi retribuiti dei genitori australiani fino ad un periodo di sei mesi e destinato ai redditi inferiori ai 135 mila dollari l’anno. Questo progetto è già stato fortemente criticato sia dalla comunità degli affari che da molti all’interno della coalizione di Abbott e finirà con ogni probabilità per essere messo rapidamente da parte.
Il già scarso appeal di Abbott tra la popolazione australiana fa prevedere infine una luna di miele particolarmente breve con gli elettori. Nelle scorse settimane, infatti, la pubblicazione di una serie di dati statistici ha prospettato un brusco rallentamento dell’economia del paese, scampata in gran parte alla crisi di questi anni grazie ad un vero e proprio boom estrattivo.
Quest’ultimo settore contribuisce per circa il 20% al prodotto interno lordo complessivo dell’Australia, impiega il 10% della forza lavoro e ammonta a oltre il 70% delle esportazioni. Il rallentamento della domanda cinese per le risorse del sottosuolo australiano ha già ridotto la crescita dell’economia al 2,6% su base annua nel mese di giugno, contro una crescita trimestrale media del 4% registrata nel corso del 2012.
Le previsioni indicano perciò una possibile recessione nel 2014, mentre la disoccupazione - attualmente al 5,7% - è destinata a salire in maniera significativa. Con queste prospettive, le voci che chiedono “riforme” per salvare i profitti delle grandi compagnie australiane si stanno moltiplicando e si tradurranno soprattutto in ulteriori misure di riduzione della spesa pubblica e di liberalizzazione del mercato del lavoro. Sul fronte della politica estera, Abbott dovrà infine continuare a fare i conti con la contraddizione che ha caratterizzato gli anni del governo laburista, vale a dire la crescente dipendenza del business australiano dalla Cina e l’allineamento strategico del paese al tradizionale alleato americano.
Sul fronte della politica estera, Abbott dovrà infine continuare a fare i conti con la contraddizione che ha caratterizzato gli anni del governo laburista, vale a dire la crescente dipendenza del business australiano dalla Cina e l’allineamento strategico del paese al tradizionale alleato americano.
Ad indicare possibili future tensioni con Washington è stata in questi giorni la presa di posizione del premier in pectore sull’imminente intervento militare in Siria, verso il quale Abbott ha mostrato maggiore freddezza rispetto a Rudd.
A livello generale, questa tornata elettorale in Australia è stata segnata dal continuo declino dei tradizionali partiti dell’establishment, evidenziato anche dal numero record di formazioni che hanno preso parte al voto. Secondo i dati della Commissione Elettorale, alla competizione di sabato hanno partecipato 54 partiti, contro i 24 del 2010, nonostante le complicate procedure fissate per la registrazione di un nuovo movimento politico.
Tra di essi, nelle elezioni federali era in corsa anche il Partito di WikiLeaks, costruito attorno alla popolarità del suo fondatore, Julian Assange, candidato per un seggio al Senato australiano. Il nuovo partito, anche a causa di scontri interni alla propria dirigenza, ha deluso le aspettative, ottenendo poco più dell’1% dei consensi su base nazionale. Lo stesso Assange, sempre costretto a rifugiarsi nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra, a conteggi ufficiali ultimati dovrebbe rimanere escluso da uno dei sei seggi in palio nello stato di Victoria dove aveva deciso di candidarsi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La richiesta di autorizzazione ad attaccare la Siria da parte della Casa Bianca ha fatto il primo passo avanti al Senato di Washington proprio mentre sono andate in scena le audizioni dei membri dell’amministrazione Obama di fronte ad una Camera dei Rappresentanti dove l’appoggio per una nuova guerra in Medio Oriente appare relativamente più difficile da ottenere.
L’approvazione della risoluzione di guerra alla commissione Esteri della camera alta del Congresso è giunta in concomitanza con l’arrivo del presidente Obama in Svezia per una visita ufficiale che ha preceduto la sua partecipazione al G-20 di San Pietroburgo, dove a tenere banco è proprio la questione siriana e l’ennesima avventura bellica criminale degli Stati Uniti.
Alla vigilia del vertice nella città russa sono emerse tutte le differenze tra il Cremlino e la Casa Bianca attorno alla Siria e, dunque, i rischi di un pericoloso allargamento del conflitto. Il presidente Putin, il quale aveva già condannato i piani di guerra americani in un’intervista rilasciata un paio di giorni fa alla Associated Press, ha tra l’altro accusato esplicitamente il segretario di Stato USA, John Kerry, di essere un bugiardo e di avere mentito nel corso delle sue apparizioni di fronte al Congresso a sostegno della linea di Obama.
Centrando alla perfezione il significato di quanto sta accadendo a Washington, il presidente russo ha definito la discussione in corso al Congresso, in vista di un voto sull’intervento militare previsto per la prossima settimana, come un tentativo di “legittimare l’aggressione” contro la Siria.
Riguardo a Kerry, Putin ha poi messo l’accento sugli sforzi del numero uno della diplomazia USA per fuorviare i membri della Camera e i cittadini americani circa la realtà sul campo in Siria. Rispondendo alla domanda di un membro della commissione Esteri sulla prevalenza di terroristi legati al Al-Qaeda tra l’opposizione siriana, Kerry ha infatti negato l’evidenza, aggiungendo che essi sono in minoranza rispetto a “ribelli” moderati che starebbero riprendendo in mano il controllo di buona parte delle operazioni in territorio siriano.
La tesi del Segretario di Stato contraddice nettamente anche il giudizio della stessa intelligence americana che, quanto meno, continua a sostenere come i guerriglieri integralisti siano di gran lunga meglio addestrati e armati rispetto alle bande secolari o moderate sostenute direttamente dall’Occidente. Con a fianco il Segretario alla Difesa, Chuck Hagel, e il capo di Stato Maggiore, generale Martin Dempsey, Kerry nella giornata di mercoledì alla Camera ha ribadito in sostanza le menzogne già proposte il giorno precedente al Senato, aggiungendo un nuovo motivo per autorizzare un intervento militare in Siria, vale a dire la necessità di contenere l’attività delle formazioni estremiste, le quali potrebbero ulteriormente rafforzarsi se gli Stati Uniti decidessero di astenersi dall’attaccare la Siria.
Con a fianco il Segretario alla Difesa, Chuck Hagel, e il capo di Stato Maggiore, generale Martin Dempsey, Kerry nella giornata di mercoledì alla Camera ha ribadito in sostanza le menzogne già proposte il giorno precedente al Senato, aggiungendo un nuovo motivo per autorizzare un intervento militare in Siria, vale a dire la necessità di contenere l’attività delle formazioni estremiste, le quali potrebbero ulteriormente rafforzarsi se gli Stati Uniti decidessero di astenersi dall’attaccare la Siria.
Ribaltando completamente la realtà dei fatti, Kerry ha sostenuto cioè che l’azione sia necessaria anche per impedire a gruppi armati legati al terrorismo internazionale di prendere il sopravvento nel paese mediorientale, dopo che il suo paese e i suoi alleati in Medio Oriente hanno di fatto facilitato la loro proliferazione. Inoltre, il presunto stop all’attività dei terroristi in Siria dovrebbe avvenire tramite un’aggressione militare ai danni di un regime che questi stessi gruppi li ha finora duramente combattuti.
Allo stesso modo, l’operazione militare dovrebbe servire anche per impedire ai fondamentalisti islamici di entrare in possesso delle armi chimiche facenti parte dell’arsenale dell’esercito di Assad sempre abbattendo un regime che questi ordigni sta tenendo fuori dalla portata dei terroristi.
Il riferimento di Kerry alla necessità di combattere le tendenze integraliste in Siria, così come di mandare un segnale di forza a Iran o Hezbollah, conferma nuovamente come l’intervento che si sta preparando non abbia nulla a che vedere con l’uso - oltretutto per nulla provato - di armi chimiche da parte di Assad, bensì con ragioni di natura strategica e di portata ben più ampia.
Lo stesso contenuto della risoluzione approvata mercoledì dalla commissione Esteri del Senato con una maggioranza di 10 voti a 7 rivela come la Casa Bianca stia cercando di ottenere un mandato più ampio possibile per condurre la guerra in Siria, sia pure dietro ad un testo che dia l’illusione di un’operazione “limitata” e soltanto per impedire nuovi attacchi con armi chimiche.
In particolare, la misura che verrà votata tra pochi giorni in aula al Senato consentirebbe al presidente di impedire in ogni modo alla Siria di utilizzare armi di distruzione di massa come quelle chimiche e sollecita provvedimenti per cambiare gli equilibri sul campo, principalmente rafforzando determinati elementi all’interno dell’opposizione.
La risoluzione consentirebbe poi ai militari americani di condurre operazioni devastanti per un periodo iniziale di 60 giorni, con una possibile estensione di altri 30 in caso di necessità. Queste tempistiche confermano come ciò che aspetta la popolazione siriana non sia affatto un blitz di portata “limitata”. Apparentemente per venire incontro a quei senatori più preoccupati per il coinvolgimento americano in una nuova guerra, è stata poi inserita una condizione che vieterebbe l’impiego di truppe di terra in Siria, anche se “al solo scopo di combattimento”. Quest’ultima condizione lascia aperta la possibilità di utilizzare team delle Forze Speciali o dei servizi segreti.
Apparentemente per venire incontro a quei senatori più preoccupati per il coinvolgimento americano in una nuova guerra, è stata poi inserita una condizione che vieterebbe l’impiego di truppe di terra in Siria, anche se “al solo scopo di combattimento”. Quest’ultima condizione lascia aperta la possibilità di utilizzare team delle Forze Speciali o dei servizi segreti.
Coerentemente con l’obiettivo reale di promuovere o provocare il cambio di regime a Damasco, la commissione del Senato ha invece bocciato due emendamenti, presentati rispettivamente dal democratico “liberal” Tom Udall e dal repubblicano libertario Rand Paul. Il primo avrebbe limitato l’operazione all’uso di navi da guerra vietando il ricorso ad aerei all’interno dello spazio aereo siriano, mentre il secondo intendeva ristabilire lo spirito del War Powers Act del 1973 ribadendo come il presidente degli Stati Uniti possa ordinare l’uso della forza solo quando il paese si trovi di fronte ad una minaccia imminente.
Gli sforzi di Kerry a Washington proseguono di pari passo con quelli di Obama in Europa e in Russia. A Stoccolma, il presidente democratico ha fatto subito ricorso alla consueta retorica umanitaria, chiedendosi “a che punto diventa necessario un confronto con azioni che distruggono la nostra stessa umanità ?”. Secondo il premio Nobel per la Pace ciò accade quando “vediamo 400 bambini e più di 1.400 civili uccisi da gas tossici” ma non, ad esempio, quando la prima potenza del pianeta agisce nella più completa illegalità, causando la devastazione di un paese (Iraq) e la morte di centinaia di migliaia di persone anche in seguito all’uso di uranio impoverito e fosforo bianco (Fallujah).
Le parole di Obama e dei membri del suo gabinetto, così come la propaganda dei media ufficiali, stanno facendo in ogni caso ben poco per convincere sia un’opinione pubblica massicciamente ostile ad una nuova guerra criminale sia la maggior parte dei governi, alleati compresi. A parte Francia, Turchia, Israele e alcuni paesi non esattamente modelli di democrazia come Arabia Saudita ed Emirati Arabi, la nuova guerra imperialista di Washington ha trovato finora pochi sostenitori, anche tra i più solidi alleati, preoccupati per le ripercussioni di un conflitto impopolare scatenato senza nemmeno la parvenza di un’approvazione ONU.
Lo stesso primo ministro conservatore svedese che ha accolto Obama mercoledì ha sostanzialmente respinto la tesi del presidente americano, affermando che il suo paese non sosterrà una risposta unilaterale contro il regime di Damasco.
La cautela di molti governi, anche se in maniera non ufficiale, è con ogni probabilità dovuta ai dubbi che essi stessi devono nutrire nei confronti delle presunte “prove” presentate dagli Stati Uniti della colpevolezza di Assad nei fatti di Ghouta del 21 agosto scorso. Se pure non trovano praticamente eco nella stampa “mainstream” in Occidente, sono molteplici gli indizi di un utilizzo di ordigni chimici da parte degli stessi “ribelli” nell’attacco che ha causato un numero imprecisato di vittime civili nei pressi di Damasco due settimane fa.
Se pure non trovano praticamente eco nella stampa “mainstream” in Occidente, sono molteplici gli indizi di un utilizzo di ordigni chimici da parte degli stessi “ribelli” nell’attacco che ha causato un numero imprecisato di vittime civili nei pressi di Damasco due settimane fa.
A smentire infine la tesi che l’opposizione armata non avrebbe le capacità di impiegare questo genere di armi e a gettare un’ulteriore ombra sulle conclusioni dell’intelligence a stelle e strisce sono stati proprio questa settimana i risultati di un’indagine di esperti russi su un episodio avvenuto il 19 marzo scorso vicino ad Aleppo.
I tecnici di Mosca hanno analizzato le prove relative ad un attacco con armi chimiche che provocò la morte di 26 persone, di cui la maggior parte soldati dell’esercito regolare, concludendo che l’esplosivo utilizzato non corrisponde a quelli in dotazione all’esercito siriano e che sarebbero stati i “ribelli” a lanciare il missile in questione contro la località di Khan al-Assal.
Il rapporto della Russia è già stato consegnato alle Nazioni Unite e membri di questo governo hanno criticato senza mezze misure la scorrettezza dell’approccio alle indagini sull’attacco del 21 agosto da parte degli Stati Uniti, i quali oltre a non volere nemmeno attendere i risultati dell’indagine degli esperti ONU, continuano a nascondere le probabili responsabilità dei “ribelli” nella provocazione di Ghouta per promuovere i propri piani di guerra contro la Siria in fase ormai estremamente avanzata.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il prossimo martedì si terranno a New York le elezioni primarie dei partiti Democratico e Repubblicano per scegliere i rispettivi candidati alla poltrona di sindaco dove siede da dodici anni il magnate ultra-miliardario delle telecomunicazioni Michael Bloomberg. A guidare da qui a pochi mesi la città più popolosa degli Stati Uniti, sempre più segnata da disuguaglianze sociali e di reddito a livelli stratosferici, sarà il vincitore del voto previsto per il 5 novembre, al quale saranno ammessi coloro che prevarranno nell’eventuale ballottaggio delle primarie in programma il 1° ottobre.
L’attenzione dei media americani si sta concentrando quasi esclusivamente sulle vicende all’interno del Partito Democratico, dove la candidata meglio finanziata e ritenuta nettamente favorita fino a pochi mesi fa, la presidente del Consiglio Comunale, Christine Quinn, starebbe per andare incontro ad una clamorosa sconfitta nelle imminenti primarie. In testa ai sondaggi è schizzato al suo posto Bill de Blasio, il quale potrebbe addirittura superare la soglia del 40% delle preferenze che gli consentirebbe di evitare il ballottaggio e accedere direttamente alla sfida di novembre.
De Blasio è l’attuale “public advocate” della città di New York, una carica elettiva che dovrebbe agire da tramite tra i cittadini e l’amministrazione comunale, a cui è inoltre assegnato il ruolo di controllo sulle agenzie municipali e di indagine sulle segnalazioni degli elettori in merito a disfunzioni dei servizi pubblici.
La stampa d’oltreoceano ha definito de Blasio come il candidato più a “sinistra” tra quelli in corsa, un’immagine che il 52enne ex consigliere comunale in rappresentanza di un distretto di Brooklyn ha attentamente coltivato per cavalcare il malcontento verso le politiche di Bloomberg ampiamente diffuso tra gli abitanti della città, ad esclusione di quelli facenti parte delle fasce di reddito più elevate.
Cavalli di battaglia della campagna elettorale di de Blasio sono alcune proposte populiste che avranno ben poche possibilità di essere implementate, come quella di aumentare il carico fiscale su coloro che guadagnano più di 500 mila dollari l’anno per finanziare asili-nido e programmi dopo-scuola. A spingere de Blasio verso la nomination democratica è anche un certo gradimento fatto segnare tra le donne e, grazie alla frequente presenza in campagna elettorale della moglie afro-americana, tra l’elettorato di colore. L’ascesa di de Blasio ha rappresentato una sorta di shock per i sostenitori di Christine Quinn, a cominciare dagli ambienti di potere che hanno maggiormente beneficiato dei tre mandati di Bloomberg. La Quinn è sostenuta ufficialmente sia dal “liberal” New York Times che dal conservatore New York Post e il suo crollo nel gradimento degli elettori è facilmente spiegabile, dal momento che negli ultimi anni è stata una fedele alleata del sindaco uscente.
L’ascesa di de Blasio ha rappresentato una sorta di shock per i sostenitori di Christine Quinn, a cominciare dagli ambienti di potere che hanno maggiormente beneficiato dei tre mandati di Bloomberg. La Quinn è sostenuta ufficialmente sia dal “liberal” New York Times che dal conservatore New York Post e il suo crollo nel gradimento degli elettori è facilmente spiegabile, dal momento che negli ultimi anni è stata una fedele alleata del sindaco uscente.
In particolare, la presidente del Consiglio Comunale ha giocato un ruolo chiave nell’approvazione nel 2009 dell’impopolare soppressione del tetto massimo di due mandati alla carica di sindaco voluta dallo stesso Bloomberg, così come ha manifestato il proprio favore per l’odiata pratica della polizia newyorchese definita “stop-and-frisk”, recentemente giudicata incostituzionale da un tribunale federale e secondo la quale gli agenti hanno la facoltà di fermare e perquisire chiunque anche senza chiari sospetti che abbia commesso un qualsiasi reato.
Oltre alla Quinn e a de Blasio, gli altri tre candidati democratici che si presenteranno alle primarie di martedì sono William Thompson - unico afro-americano in corsa ed ex “comptroller” della città, battuto di misura da Bloomberg nelle elezioni del 2009 - John Liu - l’attuale “comptroller” o addetto alla supervisione dell’andamento finanziario dei vari dipartimenti cittadini - e l’ex membro della Camera dei Rappresentanti di Washington, Anthony Weiner, caduto in disgrazia per la seconda volta qualche settimana fa dopo essere stato nuovamente coinvolto in uno scandalo sessuale.
Di fronte ai gravi problemi che affliggono New York, i candidati soprattutto democratici stanno cercando di condurre una campagna elettorale fatta di slogan nei quali si sprecano gli attacchi ai poteri forti cittadini e si promette di far pagare ai ricchi il costo di iniziative che dovrebbero ridurre le disparità sociali.
I bersagli preferiti dei candidati sembrano essere specialmente i grandi costruttori newyorchesi che, dopo i momenti bui della crisi economica esplosa nel 2008, stanno beneficiando di un vero e proprio boom edilizio a Manhattan, destinato com’è ovvio solo a milionari e miliardari che possono permettersi residenze da sogno. L’emergenza abitativa che riguarda invece il resto della popolazione di New York, comunque, difficilmente verrà affrontata dal nuovo sindaco. Secondo un’indagine apparsa questa settimana sul New York Times, infatti, gli attacchi contro l’industria edilizia lanciati dai candidati democratici in campagna elettorale nascondono una realtà ben diversa. Tutti i cinque pretendenti democratici alla carica di sindaco, così come quelli repubblicani, hanno cioè incassato donazioni più o meno sostanziose dai costruttori che ora criticano apertamente.
L’emergenza abitativa che riguarda invece il resto della popolazione di New York, comunque, difficilmente verrà affrontata dal nuovo sindaco. Secondo un’indagine apparsa questa settimana sul New York Times, infatti, gli attacchi contro l’industria edilizia lanciati dai candidati democratici in campagna elettorale nascondono una realtà ben diversa. Tutti i cinque pretendenti democratici alla carica di sindaco, così come quelli repubblicani, hanno cioè incassato donazioni più o meno sostanziose dai costruttori che ora criticano apertamente.
Solo in questa tornata elettorale, questi ultimi hanno contribuito con 2,2 milioni di dollari, di cui più di 700 mila sono andati a Christine Quinn, 643 mila a Weiner, 300 mila a Thompson e 215 mila a de Blasio. Il business del mattone tende a contribuire in maniera massiccia alle campagne elettorali per le cariche cittadine, poiché questa industria a New York viene regolata in gran parte proprio dalle autorità comunali, al contrario degli altri settori che fanno riferimento invece al governo statale o federale.
Accuse e controaccuse di essere al servizio dei costruttori hanno così occupato anche buona parte dell’ultimo dibattito televisivo tra i candidati democratici andato in scena martedì. I loro legami con i poteri forti della città, così come la non dichiarata volontà di difendere gli interessi delle classi più agiate, sono apparsi poi ancora più chiari nel momento più imbarazzante e rivelatore della serata, quando i candidati non hanno praticamente avuto alcun esempio da citare in risposta ad una domanda relativa all’ultima volta nella quale si sono ritrovati in ristrettezze economiche. Tutti gli aspiranti alla successione di un sindaco che nei dodici anni alla guida del governo cittadino ha visto passare il proprio patrimonio da 5 a 27 miliardi di dollari, hanno infatti ammesso di godere di redditi a sei zeri. Nonostante la retorica, perciò, la polarizzazione sociale di New York non verrà intaccata nemmeno nei prossimi quattro anni. A fronte di un’immagine cittadina di estrema ricchezza proiettata in tutto il mondo, nella Grande Mela non risiedono, ad esempio, soltanto i 46 mila contribuenti che denunciano redditi per almeno 1 milione di dollari.
Nonostante la retorica, perciò, la polarizzazione sociale di New York non verrà intaccata nemmeno nei prossimi quattro anni. A fronte di un’immagine cittadina di estrema ricchezza proiettata in tutto il mondo, nella Grande Mela non risiedono, ad esempio, soltanto i 46 mila contribuenti che denunciano redditi per almeno 1 milione di dollari.
Quasi la metà della popolazione di Manhattan e, soprattutto, degli altri quattro “boroughs” (Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island) è classificata al di sotto della soglia ufficiale di povertà o prossima ad essa, con una realtà effettiva con ogni probabilità anche peggiore visto l’elevatissimo costo della vita che si registra rispetto al resto degli Stati Uniti.
Dopo un digiuno che dura dal 1989, i democratici dovrebbero in ogni caso tornare ad occupare la carica di primo cittadino di New York, anche se la partecipazione degli elettori, come di consueto, sarà tutt’altro che entusiastica. Già nelle elezioni del 2009 l’affluenza non arrivò nemmeno al 30%, mentre nelle primarie di martedì dovrebbe a malapena toccare il 15%.
In campo repubblicano, infine, a contendersi la nomination saranno il favorito Joseph Lhota - banchiere ed ex presidente dell’Autorità Metropolitana dei Trasporti di New York - John Catsimatidis - proprietario di una catena di supermercati - e George McDonald, fondatore di un’organizzazione no-profit per il reinserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti e senzatetto.
In assenza di personalità politiche del calibro di Rudolph Giuliani o ben finanziate come Michael Bloomberg, i repubblicani sembrano avere ben poche possibilità di prevalere a novembre, soprattutto perché gli elettori registrati per il loro partito nella città risultano in numero nettamente inferiore rispetto a quelli democratici.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
In seguito all’improvvisa decisione di sottoporre al Congresso americano la questione dell’attacco militare contro la Siria, la Casa Bianca ha iniziato in questi giorni una intensa campagna propagandistica per convincere i deputati e i senatori di entrambi gli schieramenti ad esprimere un parere favorevole che spiani la strada ad un nuovo conflitto in Medio Oriente.
Alla Camera e al Senato di Washington rimangono tuttavia molte perplessità ad autorizzare un’aggressione contro il regime di Damasco e solo le trattative in corso renderanno chiara l’eventuale possibilità di trovare un punto di incontro utile per i piani del presidente tra le varie posizioni emerse finora sia in campo repubblicano che democratico.
A decidere l’esito del voto che dovrebbe tenersi non prima di martedì 9 settembre, quando il Congresso riprenderà ufficialmente i lavori dopo la pausa estiva, sarà perciò il grado di convergenza che si riuscirà a raggiungere sul contenuto della risoluzione che verrà alla fine presentata in aula. L’attuale testo della richiesta di autorizzazione dell’amministrazione Obama è stato infatti criticato da una parte dei “congressmen” perché troppo vago e quindi soggetto alle consuete manipolazioni dell’apparato militare con il rischio di un coinvolgimento totale degli Stati Uniti nella crisi siriana.
Questo genere di timori sono condivisi sia dai democratici “progressisti” che dai repubblicani di tendenze libertarie e tradizionalmente su posizioni isolazioniste in merito alle questioni di politica estera riguardanti il proprio paese.
Uomini simbolo di quest’ultima fazione sono attualmente i senatori Ted Cruz del Texas e, soprattutto, Rand Paul del Kentucky, figlio del più volte candidato alla presidenza, Ron Paul, e già osannato dalla destra repubblicana nel recente passato per avere condotto una serie di battaglie libertarie contro l’invadenza del governo federale nelle vite dei cittadini americani.
Più in generale, la leadership repubblicana di Camera e Senato, così come nelle principali commissioni dei due rami del Congresso, dovrà con ogni probabilità fare i conti con un numero consistente di agguerriti parlamentari che vedono con estremo sospetto ogni nuova avventura bellica degli Stati Uniti all’estero e che cercano in tutti i modi di bloccare le iniziative della Casa Bianca.
Il fatto che la destra libertaria repubblicana sia in grado di intercettare un più che giustificato malessere diffuso nella società americana, riuscendo a proporsi come unico baluardo contro una nuova guerra impopolare, è dovuto in ogni caso alla totale assenza di una qualsiasi forma di mobilitazione alla sinistra dello schieramento politico americano contro l’aggressione alla Siria.
Su questa frangia repubblicana, molto vicina ai Tea Party, finiranno così per essere esercitate le maggiori pressioni sia da parte della Casa Bianca che dei media e dell’altra fazione del partito, composta tradizionalmente da deputati e senatori che appoggiano una politica estera aggressiva, in parte per onorare i forti legami che molti di essi mantengono con la potente lobby israeliana negli Stati Uniti.
Anche questi ultimi, tuttavia, stanno mostrando per il momento una certa cautela nei confronti della richiesta dell’amministrazione Obama, in attesa di ottenere chiarimenti e conferme sulla presunta inevitabilità dell’attacco contro la Siria. Su queste esitazioni influisce soprattutto il precedente dell’invasione dell’Iraq di cui i “neo-con” furono gli artefici e che costò enormemente al proprio partito in termini di credibilità e di risultati elettorali.
Con la corsa alle presidenziali del 2016 alle primissime battute, inoltre, a parte i consueti guerrafondai come i senatori John McCain o Lindsey Graham, sono pochi i repubblicani di spicco a volersi compromettere del tutto con un delicatissimo conflitto che potrebbe facilmente sfociare in una guerra devastante con il coinvolgimento di varie potenze regionali e planetarie.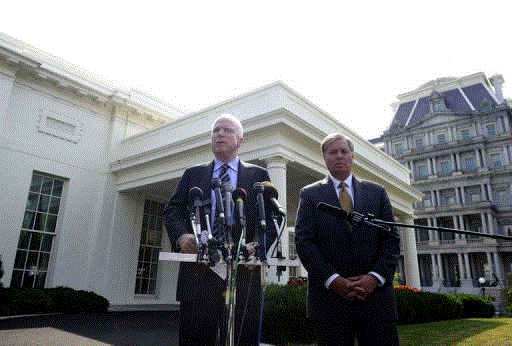 Proprio i due senatori di Arizona e South Carolina sono stati protagonisti questa settimana dell’endorsement più convinto al progetto bellico di Obama in Siria. Dopo un incontro alla Casa Bianca, i falchi McCain e Graham hanno annunciato il loro voto a favore dell’autorizzazione all’uso della forza per “punire” Assad, non prima però di avere ricevuto assicurazioni dal presidente democratico circa un imminente rafforzato impegno americano nell’assistere i “ribelli” siriani.
Proprio i due senatori di Arizona e South Carolina sono stati protagonisti questa settimana dell’endorsement più convinto al progetto bellico di Obama in Siria. Dopo un incontro alla Casa Bianca, i falchi McCain e Graham hanno annunciato il loro voto a favore dell’autorizzazione all’uso della forza per “punire” Assad, non prima però di avere ricevuto assicurazioni dal presidente democratico circa un imminente rafforzato impegno americano nell’assistere i “ribelli” siriani.
La coppia repubblicana avrebbe così rinunciato ad un’aggressione a tutto campo contro la Siria, accettando invece un attacco “limitato” che, però, a loro dire dovrebbe comunque danneggiare significativamente le strutture difensive e le capacità di offendere del regime di Damasco.
Il testo definitivo della risoluzione sulla quale si esprimerà settimana prossima il Congresso USA dovrà quindi tenere in considerazione sia i dubbi di coloro che sono disposti a dare il via libera soltanto ad un’operazione di basso profilo sia i più convinti interventisti alla McCain che hanno subordinato un voto favorevole alla prospettiva di assestare un colpo mortale alle forze di Assad. Se queste due interpretazioni sembrano a prima vista inconciliabili, è probabile che la richiesta di autorizzazione all’uso della forza avrà un linguaggio sufficientemente vago per dare mano libera alla Casa Bianca sulla gestione dell’attacco che si sta preparando.
Contraddizioni e divisioni sembrano però ancora marcate per il momento, come dimostra il lavoro della commissione Affari Esteri del Senato, guidata dal democratico Robert Menendez, che sta preparando una bozza con alcuni paletti da imporre all’azione USA, tra cui i divieti di inviare truppe in territorio siriano e di fissare come obiettivo dell’operazione il cambio di regime a Damasco. Questi limiti potrebbero però essere soltanto fumo negli occhi, dal momento che lo stesso pretesto delle armi chimiche è stato fabbricato ad arte per giustificare un intervento che abbia lo scopo preciso di ribaltare le sorti del conflitto in Siria e, quanto meno, facilitare la presa del potere delle formazioni “ribelli” finanziate e armate dall’Occidente e da svariati paesi mediorientali.
Non a caso, ciò che spicca dal dibattito avviato in questi giorni in vista del voto del Congresso è l’accettazione pressoché totale da parte dei politici di ogni orientamento delle conclusioni avanzate dall’amministrazione democratica circa le responsabilità dell’attacco con armi chimiche avvenuto a Ghouta, nei pressi di Damasco, il 21 agosto scorso.
In una serie di incontri avviati nel fine settimana tra membri del governo e del Congresso nell’ambito di un’offensiva propagandista denominata “flood the zone”, l’amministrazione Obama sembra avere convinto quasi tutti i propri interlocutori presentando “prove” della colpevolezza di Assad che consisterebbero in conversazioni intercettate tra esponenti del regime, post apparsi su svariati social media nelle ore successive all’attacco e filmati in gran parte apparsi su YouTube e girati dai “ribelli” stessi. Per stessa ammissione della Casa Bianca, tra le “prove” in proprio possesso non ci sono invece campioni raccolti sul terreno per verificare la presenza effettiva di agenti chimici nell’area colpita due settimane fa.
Nonostante quest’ultima ammissione tutt’altro che trascurabile, come ha spiegato al New York Times il deputato democratico della California, Adam Schiff, il dibattito al Congresso si è ormai spostato dalla questione della effettiva responsabilità di Assad, per nulla dimostrata, a quella delle misure da adottare per rispondere all’attacco di Ghouta. D’altra parte, anche i membri del Congresso più tiepidi nei confronti di Obama in gran parte non mettono in discussione la versione della Casa Bianca, né tantomeno la presunta autorità morale autoassegnatasi dagli USA per punire il ricorso ad armi chimiche di un qualsiasi paese. Essi, bensì, valutano troppo rischioso un intervento in Medio Oriente che avrebbe effetti destabilizzanti sull’intera regione con conseguenze negative per gli interessi americani o, tutt’al più, fanno riferimento alle tendenze isolazioniste di certi ambienti repubblicani che non vedono alcun vantaggio per il proprio paese nella partecipazione a qualsiasi guerra oltreoceano.
D’altra parte, anche i membri del Congresso più tiepidi nei confronti di Obama in gran parte non mettono in discussione la versione della Casa Bianca, né tantomeno la presunta autorità morale autoassegnatasi dagli USA per punire il ricorso ad armi chimiche di un qualsiasi paese. Essi, bensì, valutano troppo rischioso un intervento in Medio Oriente che avrebbe effetti destabilizzanti sull’intera regione con conseguenze negative per gli interessi americani o, tutt’al più, fanno riferimento alle tendenze isolazioniste di certi ambienti repubblicani che non vedono alcun vantaggio per il proprio paese nella partecipazione a qualsiasi guerra oltreoceano.
Il tentativo di Obama di ottenere l’approvazione del Congresso per l’aggressione contro la Siria, in definitiva, come dimostra il dibattito in corso non rappresenta altro che un modo per ottenere una qualche apparenza di legittimità per un’operazione illegale basata su fondamenta che sono crollate miseramente già nei giorni scorsi, spingendo il presidente a prendere atto dell’impossibilità di mettere assieme una coalizione sufficientemente ampia a livello internazionale ma anche dell’indisponibilità degli alleati di Assad ad astenersi da ritorsioni in caso di attacco su vasta scala contro Damasco.
Dal tunnel in cui egli stesso si è infilato, perciò, il presidente americano ha deciso di provare ad uscire con una manovra per la quale ha optato con ogni probabilità in fretta e furia, nella speranza di ottenere un qualche mandato per agire senza troppi vincoli pur di fronte ad una vasta opposizione popolare.
La decisione finale sull’eventuale attacco alla Siria e sulla sua portata verrà presa comunque dalla Casa Bianca in base alle circostanze che si verranno a creare nei prossimi giorni sia sul fronte interno che internazionale, come conferma il fatto che la stessa amministrazione Obama continua a non escludere la possibilità di procedere con un’operazione militare unilaterale e palesemente illegale anche in caso di voto contrario del Congresso americano.
