- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
L’ennesimo summit della Lega Araba per cercare di risolvere la crisi siriana si è risolto domenica nella prevista richiesta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di autorizzare una missione congiunta di “peacekeepers” sotto il patrocinio delle due organizzazioni. La risoluzione approvata al Cairo chiede l’invio di circa tre mila uomini in Siria, ufficialmente per monitorare l’implementazione di un cessate il fuoco, così da porre fine alle violenze tra il governo di Bashar al-Assad e l’opposizione armata e sostenuta finanziariamente dall’Occidente e dalle monarchie del Golfo.
La Lega Araba ha anche sollecitato i propri membri a “interrompere qualsiasi forma di cooperazione diplomatica” con il governo siriano, dopo che nei giorni precedenti alcuni paesi arabi avevano ritirato i loro rappresentati nel paese in seguito alla chiusura dell’ambasciata americana a Damasco. Le decisioni partorite dal vertice dell’organizzazione panaraba sono giunte mentre in Siria proseguono le violenze, soprattutto nella città di Homs, dove la resistenza armata alle forze del regime risulta particolarmente intensa.
Per mantenere alta la pressione su Assad e convincere l’opinione pubblica occidentale dell’urgenza di un intervento esterno, il solito Osservatorio per i Diritti Umani in Siria, con sede a Londra, ha di nuovo elencato una serie di scontri con decine di morti in episodi impossibile da verificare in maniera indipendente. A sottolineare la confusione attorno alle vicende relative alla Siria e la scarsa attendibilità dei resoconti pubblicati dai giornali ci sono i dati diffusi da un altro gruppo di opposizione che opera però in territorio siriano, i Comitati di Coordinamento Locale, i quali risultano ben diversi da quelli dell’Osservatorio per i Diritti Umani anche per le stesse località prese in considerazione.
Dietro la richiesta di una missione congiunta ONU-Lega Araba c’è in realtà il desiderio di alcuni paesi all’interno della stessa Lega - a cominciare da Arabia Saudita e Qatar - di aprire la strada ad un intervento armato dall’estero per rovesciare il regime di Assad. Le basi per il meeting del Cairo di domenica, e per le risoluzioni approvate, erano state fornite d’altra parte proprio da una precedente riunione del Consiglio di Cooperazione del Golfo, di cui fanno parte Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.
 Comprensibilmente, la proposta della Lega Araba è stata fermamente respinta già nella serata di domenica dal governo di Damasco. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale del regime, SANA, l’ambasciatore presso la Lega (da cui peraltro la Siria è stata sospesa), Yousef Ahmad, ha affermato che il suo governo “non è interessato in nessuna decisione presa dall’organizzazione”, le cui mosse “riflettono l’isteria e la confusione” di alcuni paesi arabi.
Comprensibilmente, la proposta della Lega Araba è stata fermamente respinta già nella serata di domenica dal governo di Damasco. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale del regime, SANA, l’ambasciatore presso la Lega (da cui peraltro la Siria è stata sospesa), Yousef Ahmad, ha affermato che il suo governo “non è interessato in nessuna decisione presa dall’organizzazione”, le cui mosse “riflettono l’isteria e la confusione” di alcuni paesi arabi.
Sempre nella giornata di domenica, poi, il capo della missione degli osservatori della Lega Araba, inviata in Siria a dicembre e cancellata qualche settimana fa, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il generale sudanese Muhammad Ahmad Mustafa al-Dabi ha criticato la decisione di Arabia Saudita e Qatar di ritirare i propri osservatori nonostante fossero emersi significativi miglioramenti nel paese e il regime stesse conformandosi alle richieste della stessa Lega.
La soppressione della precedente missione è stato un passo cruciale per giungere al coinvolgimento delle Nazioni Unite così da legittimare un intervento per rovesciare Assad. Il fallimento forzato della missione alla quale Damasco aveva dato il via libera, è stato voluto precisamente da Arabia Saudita e Qatar, con l’OK di Washington, in quanto da simili iniziative questi paesi intendono accettare unicamente le prove delle repressioni del regime siriano, al di là della realtà sul campo, in modo da sfruttarle per promuovere l’abbattimento dell’attuale governo.
Le manovre dei paesi Occidentali e dei loro alleati nel Golfo Persico ricalcano sempre più quelle messe in atto lo scorso anno alla vigilia dell’aggressione militare contro la Libia. Anche in quel caso, la risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU venne preceduta da un voto della Lega Araba che chiedeva l’intervento della comunità internazionale in appoggio ai “ribelli” libici. Con il pretesto dell’intervento “umanitario”, la NATO diede così inizio alle operazioni militari per sostituire Gheddafi con gli esponenti del Consiglio Nazionale di Transizione, causando, al termine della campagna, oltre 50 mila morti e gettando il paese nordafricano in un caos nel quale a dominare sono ora le varie milizie armate che si fronteggiano tra loro macchiandosi di ripetute violazioni dei diritti umani.
Dal summit di domenica non è arrivato invece l’atteso riconoscimento del Consiglio Nazionale Siriano (CNS) come unico rappresentante legittimo del governo di Damasco, anche se questa mossa giungerà con ogni probabilità nel prossimo futuro. Ciononostante, la Lega Araba si è espressa a favore “dell’apertura di canali di comunicazione con l’opposizione siriana e della fornitura di supporto politico e finanziario”.
Quest’ultima decisione sanziona, in effetti, una realtà già evidente da tempo. Il CNS e l’Esercito Libero della Siria (FSA), oltre ad essere stanziati in Turchia, godono, come già ricordato, del sostegno materiale di vari governi occidentali e arabi. Secondo recenti rivelazioni, inoltre, membri delle Forze Speciali di Gran Bretagna e Qatar starebbero addestrando combattenti dell’FSA in territorio turco, mentre personale specializzato di questi ed altri paesi sarebbero già presenti in Siria per fornire “consigli di natura tattica” all’opposizione armata impegnata contro il regime.
Forse anche grazie a questo sostegno, l’opposizione siriana nelle ultime settimane ha incrementato le proprie azioni, facendo ricorso sempre più spesso ad assassini e atti di terrorismo. Proprio sabato scorso, ad esempio, la stampa ufficiale ha diffuso la notizia dell’assassinio a Damasco del generale Issa al-Kholi, noto medico militare proveniente da una potente famiglia alauita legata ai vertici del governo siriano. Nei giorni precedenti, poi, due esplosioni nella città di Aleppo - roccaforte del regime e finora relativamente risparmiata dalle proteste - due esplosioni contro edifici governativi avevano fatto almeno 28 morti.
 Per quest’ultimo attentato terroristico, la stampa internazionale ha puntato il dito contro gruppi vicini ad Al-Qaeda provenienti dal vicino Iraq. Qualche giorno fa, infatti, il leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, aveva elogiato in un video-messaggio i ribelli siriani che si battono contro Assad. Singolarmente, come già avvenne in Libia, dove tra i ribelli c’erano molti fondamentalisti islamici legati all’organizzazione che fu di Osama bin Laden, anche in Siria l’agenda di Al-Qaeda sembra coincidere con quella degli Stati Uniti.
Per quest’ultimo attentato terroristico, la stampa internazionale ha puntato il dito contro gruppi vicini ad Al-Qaeda provenienti dal vicino Iraq. Qualche giorno fa, infatti, il leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, aveva elogiato in un video-messaggio i ribelli siriani che si battono contro Assad. Singolarmente, come già avvenne in Libia, dove tra i ribelli c’erano molti fondamentalisti islamici legati all’organizzazione che fu di Osama bin Laden, anche in Siria l’agenda di Al-Qaeda sembra coincidere con quella degli Stati Uniti.
Come ha descritto ieri un articolo del New York Times, inoltre, da qualche tempo è attivo un traffico di armi dalle province occidentali a maggioranza sunnita dell’Iraq - in particolare dalla città di Mosul, quartier generale di Al-Qaeda in Iraq - e destinato ai ribelli in Siria. L’appello alle armi e alla guerra santa da parte di ambienti estremisti è giunta anche dai Fratelli Musulmani della Giordania, secondo i quali “sostenere la popolazione siriana e l’FSA è un dovere, dal momento che essi stanno subendo le ingiustizie e l’oppressione del regime”.
Il progetto degli Stati Uniti e dei loro alleati di rovesciare Assad per sostituirlo con un regime più malleabile rientra nella strategia più ampia tesa ad estendere in maniera pressoché incontrastata l’influenza americana dalle sponde del Mediterraneo al Mar Caspio, un’area sconfinata che conserva la maggior parte delle riserve energetiche del pianeta. Questo disegno, che prevede come successiva e fondamentale tappa il cambio di regime in Iran, di cui Damasco è il principale alleato, va di pari passo con il declino degli stessi USA su scala globale e rischia di trascinare in un conflitto rovinoso potenze come Russia e Cina che vedono minacciati i propri interessi vitali.
Oltre al veto di due settimane fa all’ONU alla risoluzione sulla Siria, Mosca sta reagendo in maniera ferma alle minacce americane contro Damasco, confermando l’appoggio all’alleato Assad attraverso, tra l’altro, l’invio di proprie navi da guerra al largo delle coste del paese e la firma di nuovi accordi di fornitura di armamenti al regime.
Nonostante i rischi di alimentare nuove tensioni, l’offensiva da parte dei governi che vogliono la fine di Assad non conosce soste. Dopo il summit della Lega Araba, la palla è passata ancora alle Nazioni Unite dove ieri è iniziata un’altra trattativa per giungere ad una nuova risoluzione di condanna contro la Siria, questa volta basata su una proposta saudita. La nuova risoluzione, che non avrebbe alcuna possibilità di superare l’esame del Consiglio di Sicurezza per l’opposizione di Russia e Cina, dovrebbe essere sottoposta all’esame dell’Assemblea Generale. Per ottenerne l’approvazione sarà così sufficiente una maggioranza semplice, anche se il documento che ne potrebbe uscire non sarà comunque in nessun modo vincolante.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Le conseguenze del colpo di stato di settimana scorsa alle Maldive continuano a farsi sentire nel panorama politico dell’arcipelago nell’Oceano Indiano. Mentre il deposto presidente, Mohamed Nasheed, insiste nel chiedere elezioni anticipate e il nuovo regime sta dando vita ad un governo di unità nazionale per consolidare il potere, nella capitale Malé sono giunti in questi giorni inviati delle Nazioni Unite e delle potenze con i maggiori interessi nell’arcipelago (India e Stati Uniti) per fare chiarezza sulla situazione e negoziare un’uscita pacifica dalla crisi.
A precipitare le Maldive nel caos erano state le dimissioni forzate martedì scorso del presidente Nasheed, eletto democraticamente nel 2008 dopo 30 anni di governo autocratico di Maumoon Abdul Gayoom. Nasheed era apparso in diretta TV annunciando la sua intenzione di farsi da parte in seguito alle insistite proteste di piazza organizzate da alcune settimane dall’opposizione. Il giorno successivo, tuttavia, Nasheed ha dichiarato alla stampa internazionale di essere stato costretto alle dimissioni dalle forze di polizia fedeli a Gayoom. Lo stesso vice-presidente che ha preso il suo posto alla guida del paese, Mohamed Waheed Hassan Manik, è stato accusato di aver cospirato contro di lui assieme all’ex uomo forte maldiviano, in questi giorni impegnato in un viaggio in Malaysia.
In risposta al golpe, a Malé sono scesi in piazza centinaia di sostenitori di Nasheed e del suo Partito Democratico delle Maldive (MDP), contro i quali le forze di sicurezza hanno risposto con cariche e gas lacrimogeni. Giovedì, poi, il Tribunale Criminale delle Maldive ha emesso un ordine di arresto per Nasheed e per il suo ormai ex ministro della Difesa. Il nuovo regime non ha però manifestato l’intenzione di applicare l’ordine di arresto, così che l’ex presidente continua a rimanere in libertà nella capitale e, anzi, sempre giovedì ha guidato una nuova manifestazione di piazza.
Venerdì, inoltre, Nasheed ha puntato nuovamente il dito contro la polizia e l’esercito, accusandoli di aver picchiato e arrestato parlamentari e sostenitori del suo partito nel corso delle proteste. Negli ultimi giorni, in ogni caso, nella capitale è sembrata prevalere la calma, anche se alcuni scontri sono stati segnalati nella città meridionale di Addu.
 Già attivista per i diritti umani, Mohamed Nasheed aveva trionfato nelle prime elezioni multipartitiche della storia maldiviana nel 2008, conquistando la presidenza con quasi il 54% dei consensi ed estromettendo Maumoon Abdul Gayoom, al potere dal 1978. Durante il regime di quest’ultimo, Nasheed era stato più volte imprigionato, nonché costretto a vivere per parecchi anni in esilio in Gran Bretagna e Sri Lanka.
Già attivista per i diritti umani, Mohamed Nasheed aveva trionfato nelle prime elezioni multipartitiche della storia maldiviana nel 2008, conquistando la presidenza con quasi il 54% dei consensi ed estromettendo Maumoon Abdul Gayoom, al potere dal 1978. Durante il regime di quest’ultimo, Nasheed era stato più volte imprigionato, nonché costretto a vivere per parecchi anni in esilio in Gran Bretagna e Sri Lanka.
Le Maldive sono un arcipelago composto da quasi 1.200 isole nell’Oceano Indiano e contano poco meno di 400 mila abitanti, a larga maggioranza musulmani sunniti. Nonostante le isole siano una famosa meta per il turismo di lusso, la gran parte della popolazione vive in condizioni di povertà.
A partire dalla metà di gennaio, i principali partiti dell’opposizione maldiviana - tra cui il Partito Progressista delle Maldive (PPM) di Gayoom e il partito islamico DQP (Dhivehi Qaumee) - avevano indetto una serie di manifestazioni di protesta dopo che il presidente Nasheed aveva ordinato l’arresto del giudice Abdulla Mohamed, accusato di corruzione. Il giudice Mohamed aveva in precedenza ottenuto la scarcerazione del vice-presidente del partito DQP, Mohamed Jameel Ahmed, a sua volta accusato di diffamazione nei confronti del presidente.
Sia la Corte Suprema che il Procuratore Generale delle Maldive avevano dichiarato illegale l’arresto del giudice Mohamed, innescando di fatto una crisi costituzionale. Membri del governo di Nasheed, peraltro, hanno poi sostenuto che lo stesso giudice era più volte intervenuto nel recente passato per far naufragare procedimenti legali contro membri dell’opposizione. A novembre, ad esempio, Mohamed avrebbe fatto uscire dal carcere il figlio di Gayoom, Gassan Maumoon, arrestato per tentato omicidio.
Già a dicembre, in realtà, alcuni partiti islamici maldiviani avevano cercato di mobilitare i propri sostenitori contro Nasheed, accusato a loro dire di non aver rispettato a sufficienza i principi religiosi. Da tempo, negli ambienti religiosi si chiede un’interpretazione più rigorosa dell’Islam nel paese, una tendenza emersa con l’arrivo nell’arcipelago di predicatori fondamentalisti dal Medio Oriente. La diffusione dell’Islam nelle Maldive va fatta risalire probabilmente al dodicesimo secolo, quando i sovrani buddisti decisero di convertirsi, anche se l’applicazione dei principi religiosi è sempre stata piuttosto blanda.
Le origini del malcontento nel paese sono però da ricercare principalmente nelle mancate promesse elettorali del presidente Nasheed. Dal 2008 a oggi il livello di inflazione è salito vertiginosamente, mentre dure misure di austerity sono state implementate su richiesta del Fondo Monetario Internazionale. Le opposizioni, soprattutto islamiche, hanno così sfruttato i malumori diffusi nei confronti del presidente, cercando di mobilitare la popolazione. Quando alle proteste dell’opposizione si sono unite le forze di polizia e alcune sezioni dell’esercito, per il presidente Nasheed è stata la fine.
 Insediato alla guida del paese già martedì scorso, l’ex vice-presidente Waheed domenica ha così inaugurato un governo di unità nazionale per ristabilire l’ordine nel paese in vista delle elezioni presidenziali del 2013, mentre, su richiesta della comunità internazionale, il giorno precedente aveva annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta per fare luce sui fatti delle ultime settimane che hanno portato alla rimozione di Nasheed. Quest’ultimo, da parte sua, non solo ha respinto l’offerta di entrare nel nuovo governo ma continua a chiedere elezioni anticipate.
Insediato alla guida del paese già martedì scorso, l’ex vice-presidente Waheed domenica ha così inaugurato un governo di unità nazionale per ristabilire l’ordine nel paese in vista delle elezioni presidenziali del 2013, mentre, su richiesta della comunità internazionale, il giorno precedente aveva annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta per fare luce sui fatti delle ultime settimane che hanno portato alla rimozione di Nasheed. Quest’ultimo, da parte sua, non solo ha respinto l’offerta di entrare nel nuovo governo ma continua a chiedere elezioni anticipate.
Le Maldive sono situate in una posizione strategica nell’Oceano Indiano, al centro di rotte marittime commerciali fondamentali per gli interessi delle potenze regionali (India e Cina) e degli Stati Uniti. Soprattutto l’India ha tradizionalmente un’influenza particolare sull’arcipelago, come dimostra il fatto che Nasheed ha fatto appello proprio a Nuova Delhi quando sono iniziate le protese contro il suo esecutivo. Il governo indiano, però, si è rifiutato di fornirgli appoggio e settimana scorsa ha invece riconosciuto come legittimo il nuovo regime di Waheed. Anche da Washington era giunto l’immediato riconoscimento del golpe ma il Dipartimento di Stato ha fatto poi marcia indietro, sostenendo che andava fatta maggiore chiarezza sulla situazione nel paese.
Che le Maldive non siano un angolo di Oceano Indiano del tutto trascurabile per gli equilibri geo-strategici del continente asiatico è confermato anche dal fatto che l’amministrazione Obama ha inviato a Malé l’assistente al Segretario di Stato, Robert Blake, il quale sabato ha incontrato sia il nuovo presidente Waheed che il deposto Nasheed e altri leader politici locali. Al termine della sua vista, Blake ha confermato che gli USA non sono nella posizione di stabilire se Nasheed sia stato vittima di un golpe e, in ogni caso, ha affermato che le Maldive non sono pronte per elezioni anticipate, di fatto fornendo il proprio sostegno al neo-presidente Waheed.
Anche a Nuova Delhi sono ampiamente diffuse le preoccupazione per il caos nel paese e, soprattutto, per la radicalizzazione della società e della scena politica maldiviana. In un susseguirsi sui media indiani di editoriali che esprimono le apprensioni per l’incapacità di Nuova Delhi di risolvere una crisi politica in un paese d’importanza apparentemente secondaria, anche il governo di Manmohan Singh ha inviato un proprio rappresentante alle Maldive.
Per il loro interesse strategico, anche le Maldive sono così al centro delle rivalità delle varie potenze della regione. Nonostante il tradizionale ascendente dell’India, la Cina negli ultimi anni ha ad esempio intensificato i legami con Malé. Pechino ha infatti costruito il palazzo del Ministero degli Esteri nella capitale, così come il Museo Nazionale. I rapporti commerciali tra i due paesi sono inoltre aumentati di oltre il 50% tra il 2009 e il 2010, mentre una serie di importanti accordi di cooperazione sono stati siglati durante la presidenza dell’ormai deposto Mohamed Nasheed.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Dopo il veto congiunto di Russia e Cina al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla questione siriana, Mosca e, in misura minore, Pechino, continuano ad essere oggetto di pesanti critiche e pressioni da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. Il governo russo, da parte sua, difende la scelta fatta a favore dell’alleato Assad e, dopo la visita di martedì scorso a Damasco del ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, annuncia di voler promuovere un qualche dialogo tra il regime e le opposizioni.
Nonostante il tentativo di risolvere pacificamente la crisi in Siria, è comunque improbabile che a questo punto l’Occidente e le monarchie del Golfo possano accettare una soluzione diversa dalla sostituzione di Assad con un governo meglio disposto verso i loro interessi nella regione.
La bocciatura della risoluzione di condanna del governo siriano al Consiglio di Sicurezza è stata seguita sui media di mezzo mondo da una nuova ondata di rapporti che hanno ampiamente descritto una rinnovata offensiva delle forze di sicurezza del regime in molte località del paese. Secondo la versione sposata in maniera pressoché uniforme dai giornali occidentali, il doppio veto all’ONU avrebbe rinvigorito Assad che, incassato il sostegno dell’alleato russo, starebbe ora intensificando la repressione.
I resoconti della presunta nuova esplosione di violenze in Siria, attribuite quasi del tutto al regime, provengono tuttavia esclusivamente dalle varie organizzazioni con sede all’estero che sostengono le opposizioni, mentre risulta impossibile qualsiasi conferma da parte di fonti indipendenti. Il punto di riferimento preferito dai media è in particolare l’Osservatorio per i Diritti Umani in Siria, di stanza a Londra e legato a quei Fratelli Musulmani che fanno parte dell’opposizione armata al regime, nonché, secondo alcuni, finanziato da Qatar e Arabia Saudita.
Da Washington, Londra e Parigi, ma anche dalla Turchia e dalle monarchie del Golfo, sono così partite nuove iniziative per mettere all’angolo Assad e trovare una soluzione alla crisi al di fuori delle Nazioni Unite. Per cominciare, negli ultimi giorni molti paesi arabi ed europei hanno ritirato i propri rappresentanti diplomatici da Damasco in seguito alla chiusura dell’ambasciata americana in Siria.
Nuove sanzioni vengono poi minacciate quotidianamente, mentre rappresentanti del governo statunitense sostengono ormai apertamente di voler fornire armi e finanziamenti ai ribelli. Già da tempo, peraltro, pare siano operativi voli NATO che trasportano armi verso basi militari turche al confine con la Turchia dove trovano rifugio i disertori siriani, così come i membri dell’Esercito Libero della Siria ricevono addestramento dai servizi segreti occidentali.
Anche se recentemente è stato ipotizzato un possibile prossimo intervento diretto da parte americana o della NATO, questa eventualità appare ancora lontana, quanto meno perché estremamente impopolare sia tra l’opinione pubblica occidentale che tra la maggior parte degli oppositori di Assad.
 Più probabile è invece la creazione, verosimilmente da parte delle forze armate turche, di zone cuscinetto entro i confini della Siria, così da permettere ai combattenti dell’opposizione di organizzarsi e, con il sostegno dell’Occidente, dei paesi del Golfo e della stessa Turchia, sferrare attacchi più incisivi contro il regime. Questa ipotesi richiama alla mente la vicenda libica, con i ribelli che avevano stabilito la loro roccaforte a Bengasi.
Più probabile è invece la creazione, verosimilmente da parte delle forze armate turche, di zone cuscinetto entro i confini della Siria, così da permettere ai combattenti dell’opposizione di organizzarsi e, con il sostegno dell’Occidente, dei paesi del Golfo e della stessa Turchia, sferrare attacchi più incisivi contro il regime. Questa ipotesi richiama alla mente la vicenda libica, con i ribelli che avevano stabilito la loro roccaforte a Bengasi.
Il rapido approssimarsi di un simile scenario contrasta fortemente con quanto annunciato dal ministro degli Esteri russo Lavrov dopo aver incontrato il presidente Assad a Damasco. Per il primo diplomatico russo, il governo siriano avrebbe confermato la disponibilità a lanciare una serie di riforme, tra cui una nuova Costituzione, elezioni multipartitiche e la fine del predominio del partito Baath nel panorama politico del paese.
Qualsiasi promessa di Assad, in ogni caso, non soddisferà né le opposizioni né i loro sponsor in Occidente e nel Golfo, ben decisi ormai ad andare fino in fondo e rimuovere il regime alauita, così da infliggere un colpo mortale all’obiettivo ultimo della loro campagna di aggressione, l’Iran.
Nella strategia occidentale vero la Siria, così come accadde per la Libia, la Lega Araba ricopre un ruolo fondamentale per fornire una parvenza di legittimità alle iniziative che si prospettano nel prossimo futuro. La risoluzione bocciata la settimana scorsa all’ONU, ad esempio, era basata sulle conclusioni del summit della Lega Araba seguito all’esame del rapporto stilato dagli osservatori inviati in Siria a dicembre. Quello che i governi e la gran parte dei media occidentali hanno mancato di dire, tuttavia, è che questo stesso rapporto è stato praticamente calpestato, in particolare dalle autocrazie del Golfo che sono in prima linea nel puntare il dito contro il regime siriano.
Apparso integralmente di recente sul web in lingua inglese, il rapporto degli osservatori, guidati dal generale sudanese Muhammad Ahmad Mustafa al-Dabi, aveva infatti sottolineato il miglioramento della situazione in Siria dopo l’inizio della missione. Gli episodi di violenza erano diminuiti e il governo di Damasco stava conformandosi a poco a poco alle richieste della Lega Araba. Soprattutto, per la prima volta dall’inizio della rivolta in Siria, un organo internazionale aveva riconosciuto l’esistenza nel paese di un’opposizione armata, anch’essa responsabile di azioni sanguinose contro le forze di sicurezza del regime.
Per tutta risposta, i due principali alleati degli USA nel mondo arabo - Qatar e Arabia Saudita - avevano comunque deciso di ritirare i propri osservatori impegnati nella missione, definendola inutile e gettando così le basi per la sua definitiva sospensione pochi giorni più tardi.
Nel rapporto così distorto si legge, tra l’altro, che da molte parti sono giunti “rapporti falsi di esplosioni o violenze in varie località. Quando gli osservatori si sono recati in queste località, essi hanno riscontrato che i rapporti erano infondati. La Missione ha anche notato che i media hanno ingigantito la natura degli incidenti e il numero di persone uccise durante le proteste in alcune città”. Inoltre, le dimostrazioni pacifiche, sia di sostenitori del governo che degli oppositori, in molte località non sono mai state impedite, nonostante qualche scontro trascurabile.
Un altro punto della road map approvata dalla Lega Araba per risolvere la crisi era la liberazione dei detenuti politici. Secondo i gruppi di opposizione attivi al di fuori del paese, gli oppositori fatti prigionieri dall’inizio delle proteste sono tra i 12 e i 16 mila. Per gli osservatori questi numeri non sono però affidabili, poiché le informazioni al riguardo risultano “inaccurate e spesso i nomi dei detenuti sono ripetuti”. Ancora, il rapporto sostiene chiaramente che tutti “i mezzi militari, i carri armati e le armi pesanti sono stati ritirati dalle città e dalle aree residenziali”.
 Contro la missione della Lega Araba, inoltre, è stata quasi subito orchestrata una campagna di discredito che viene descritta dagli stessi osservatori. “Fin dall’inizio del proprio incarico”, si legge nel rapporto, “la Missione è stata presa di mira da una campagna mediatica diffamatoria. Alcuni osservatori sono venuti meno ai loro doveri, hanno preso contatti con esponenti dei loro governi ai quali hanno fornito resoconti ingigantiti degli eventi sul campo. Questi governi hanno di conseguenza dipinto un quadro più cupo e senza fondamento della situazione”.
Contro la missione della Lega Araba, inoltre, è stata quasi subito orchestrata una campagna di discredito che viene descritta dagli stessi osservatori. “Fin dall’inizio del proprio incarico”, si legge nel rapporto, “la Missione è stata presa di mira da una campagna mediatica diffamatoria. Alcuni osservatori sono venuti meno ai loro doveri, hanno preso contatti con esponenti dei loro governi ai quali hanno fornito resoconti ingigantiti degli eventi sul campo. Questi governi hanno di conseguenza dipinto un quadro più cupo e senza fondamento della situazione”.
Grazie soprattutto a questa deliberata falsificazione della realtà siriana, gli Stati Uniti e i loro alleati si stanno ora muovendo per aggirare il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e giungere ad un esito a loro favorevole della crisi. Molto attiva in questo senso è la Turchia che l’altro giorno ha annunciato la volontà di organizzare un summit internazionale per coordinare le prossime mosse.
La proposta fa seguito a quella americana di creare un gruppo di “amici della Siria democratica”, sull’esempio del gruppo di contatto per la Libia che ha portato all’assassinio di Gheddafi e alla spartizione delle ricchezze energetiche del paese nordafricano.
La Turchia, va ricordato, fino a pochi mesi fa vantava una stretta partnership, soprattutto economica, con il vicino meridionale, mentre ora è tra i critici più accesi del regime di Assad. Inoltre, Ankara ospita entro i propri confini i rappresentanti del Libero Esercito della Siria e del Consiglio Nazionale Siriano. L’inversione di rotta del governo Erdogan - che ha gettato alle ortiche la tanto propagandata politica di “zero problemi con i paesi vicini”, appiattendosi invece sulla linea di Washington - si spiega forse proprio con i fatti di Libia dello scorso anno. La Turchia, infatti, non abbracciò da subito l’aggressione militare contro Gheddafi, rischiando di rimanere emarginata dal nuovo regime libico. Un errore che ora Ankara non vuole ripetere con la Siria, un paese di gran lunga più importante per i propri interessi.
Alle Nazioni Unite, infine, dopo l’intervento del Segretario Generale, Ban Ki-moon, che ha definito “disastroso” il fallimento del Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione anti-Assad, si sta valutando la possibilità di inviare una nuova missione congiunta in Siria composta da osservatori ONU e della Lega Araba. Una missione, quest’ultima, che sarebbe inevitabilmente sottoposta alle stesse pressioni di quella da poco interrotta e che con ogni probabilità servirebbe soltanto a mettere il sigillo delle Nazioni Uniti sulle accuse e gli ultimatum che i nuovi osservatori sarebbero chiamati a lanciare contro Damasco.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Con l’ennesimo sconvolgimento degli equilibri nelle primarie in casa repubblicana, le tre competizioni andate in scena martedì per selezionare il prossimo sfidante di Barack Obama per la Casa Bianca se le è aggiudicate l’ex senatore della Pennsylvania, Rick Santorum. Vincitore di misura nei caucus dell’Iowa lo scorso 3 gennaio e per molti ormai destinato ad una rapida uscita di scena, Santorum ha invece incassato tre limpide vittorie nei caucus di Colorado e Minnesota e nelle primarie non vincolanti del Missouri, facendo nuovamente riemergere tutte le perplessità che rimangono attorno alla candidatura di quello che rimane comunque il favorito per la nomination repubblicana, il miliardario mormone Mitt Romney.
Più che risultare in una spinta decisiva alle sue possibilità di rimanere competitivo anche nelle settimane a venire, il triplo successo di Santorum sembra costituire più che altro un ostacolo alle velleità dell’ex speaker della Camera, Newt Gingrich, di diventare l’unico rivale di Romney. Le affermazioni di martedì permetteranno infatti a Santorum di continuare la sua corsa almeno nel medio periodo, impedendo così a Gingrich di attrarre la gran parte del voto anti-Romney, soprattutto tra gli elettori più conservatori del Partito Repubblicano. Una prospettiva, quest’ultima, che potrebbe finire per favorire lo stesso Romney, nonostante le conseguenze negative delle più recenti sconfitte.
Nei tre stati che hanno votato martedì, Santorum ha ampiamente beneficiato della sintonia del suo messaggio ultraconservatore con gli ambienti evangelici e gli aderenti ai Tea Party. La débacle di Romney, in ogni caso, appare per molti versi sorprendente, soprattutto perché è giunta dopo le due nette vittorie dell’ex governatore del Massachusetts in Florida e Nevada che sembravano dovergli spianare la strada verso la nomination, anche in virtù dell’enorme vantaggio nei confronti dei suoi rivali sul piano finanziario.
In Minnesota, Rick Santorum ha raccolto il 44,8% dei consensi (13 delegati), contro il 27,2% di Ron Paul, il 16,9% di Mitt Romney e il 10,7% di Newt Gingrich. Più ridotto è stato invece il margine in Colorado, dove Santorum ha fatto registrare il 40,2% (15 delegati), Romney il 34,9% (6 delegati), Gingrich il 12,8% e Paul l’11,8%. In Missouri, infine, le primarie non prevedevano l’attribuzione di alcun delegato - l’assegnazione avverrà con i caucus che inizieranno il 17 marzo - ma sono state comunque seguite con qualche attenzione poiché, ad esempio, vi hanno partecipato più elettori rispetto ai caucus conquistati sabato scorso da Romney in Nevada. Santorum ha vinto in Missouri con il 55,2% dei voti espressi, staccando nettamente Romney (25,3%) e Paul (12,2%), mentre il nome di Gingrich non è apparso sulle schede. Fino ad ora, Mitt Romney ha accumulato 91 delegati, Santorum 44, Gingrich 29 e Paul 8. Per assicurarsi la nomination repubblicana, sono necessari almeno 1.144 delegati.
 Anche questo appuntamento elettorale ha fatto segnare un evidente calo nell’affluenza. In Colorado, Santorum si è imposto con meno della metà dei voti che ottenne Romney quando vinse nel 2008. In Minnesota, invece, l’affluenza totale è stata inferiore di quasi un quarto rispetto a quattro anni fa.
Anche questo appuntamento elettorale ha fatto segnare un evidente calo nell’affluenza. In Colorado, Santorum si è imposto con meno della metà dei voti che ottenne Romney quando vinse nel 2008. In Minnesota, invece, l’affluenza totale è stata inferiore di quasi un quarto rispetto a quattro anni fa.
Per Romney, le sconfitte appaiono a tratti imbarazzanti. In Minnesota, infatti, è giunto addirittura terzo, dietro anche a Ron Paul, mentre in Colorado la battuta d’arresto di martedì contrasta con la sua vittoria nei caucus del 2008, quando s’impose con oltre 40 punti percentuali su John McCain. A testimonianza del drastico spostamento a destra del baricentro politico repubblicano - a sua volta determinato dalla svolta a destra di Obama - vale la pena ricordare, inoltre, che quattro anni fa Romney venne premiato dagli elettori in Colorado perché rappresentava un’alternativa conservatrice al moderato McCain. Oggi, invece, è proprio Romney ad essere considerato da molti nel suo partito fin troppo moderato e virtualmente indistinguibile dal presidente democratico.
Anche se sono in molti a nutrire dubbi nei suoi confronti, Romney avrà ora quasi tre settimane a disposizione per ripristinare quell’apparenza d’inevitabilità che ha avvolto finora la sua candidatura. Dopo un dibattito tra i quattro sfidanti repubblicani in programma il 22 febbraio, il calendario delle primarie di questo mese si chiuderà con gli appuntamenti in Arizona e in Michigan il giorno 28. In questi due stati Romney parte da favorito, soprattutto in Michigan, dove il padre è stato governatore negli anni Sessanta. Il 6 marzo, poi, ci sarà il tradizionale Supermartedì con dieci stati chiamati a votare, tra cui alcuni nel sud degli Stati Uniti teoricamente favorevoli a Newt Gingrich.
Le vittorie di Santorum di martedì dovrebbero consentirgli di raccogliere nuovi finanziamenti da una limitata rete di fedeli donatori. Come per tutti gli altri candidati, un ruolo di spicco nella campagna elettorale dell’ex senatore della Pennsylvania è giocato dalla Super PAC che lo sostiene (“Red, White and Blue Fund”). Buona parte dei fondi ad essa destinati provengono da un unico generoso donatore, il finanziere miliardario Foster Friess, il quale non a caso era presente sul palco di Santorum martedì sera durante il discorso di quest’ultimo dopo la diffusione dei risultati definitivi delle primarie.
L’importanza delle Super PAC - “Political Action Committee”, le quali grazie ad una sentenza della Corte Suprema del 2010 possono raccogliere denaro senza limiti da individui e corporation, purché non coordino la propria campagna elettorale direttamente con i team dei candidati che appoggiano - è sempre più evidente in questo scorcio di primarie repubblicane e lo sarà ancora di più nelle elezioni del novembre prossimo. A conferma di ciò, lunedì anche Obama ha finito per abbracciare ufficialmente questo nuovo modo di fare campagna elettorale, caratterizzato dallo strapotere di un esiguo numero di donatori super-ricchi in grado di decidere le sorti di un candidato.
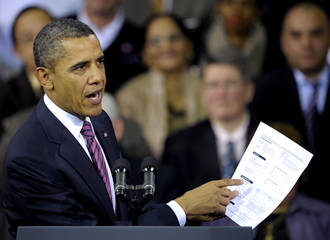 Tre giorni fa, infatti, il presidente ha annunciato di aver autorizzato alcuni membri della sua amministrazione e del suo team per la rielezione ad apparire in eventi destinati alla raccolta di fondi per la sua Super PAC (“Priorities USA Action”) e per altre due che appoggiano i candidati democratici in corsa per la Camera e il Senato. Nel recente passato, Obama aveva duramente criticato la sentenza della Corte Suprema, definendo le Super PAC una “minaccia per la democrazia” e denunciando l’eccessiva influenza dei poteri forti sulla politica americana.
Tre giorni fa, infatti, il presidente ha annunciato di aver autorizzato alcuni membri della sua amministrazione e del suo team per la rielezione ad apparire in eventi destinati alla raccolta di fondi per la sua Super PAC (“Priorities USA Action”) e per altre due che appoggiano i candidati democratici in corsa per la Camera e il Senato. Nel recente passato, Obama aveva duramente criticato la sentenza della Corte Suprema, definendo le Super PAC una “minaccia per la democrazia” e denunciando l’eccessiva influenza dei poteri forti sulla politica americana.
Il voltafaccia di Obama è dovuto alla crescente disparità di risorse finanziarie a disposizione dei due partiti, con le Super PAC democratiche che nel 2011 hanno raccolto appena un quarto del denaro finito nelle casse di quelle repubblicane. In un sistema che dipende pressoché esclusivamente dalla quantità di fondi a disposizione dei candidati, questa differenza rischiava di mettere a repentaglio le chances di successo dei democratici nelle elezioni di novembre.
Così, dopo il via libera di Obama, il suo staff ha iniziato subito a mettere in atto la propria strategia per raccogliere quanto più denaro possibile. Martedì, ad esempio, il responsabile della campagna elettorale di Obama, Jim Messina, ha incontrato a New York un gruppo di facoltosi donatori democratici - tra cui il presidente di UBS America, Robert Wolf, ed altri amministratori delegati di hedge-funds e banche di investimento di Wall Street per convincerli a staccare sostanziosi assegni a favore del presidente.
Sempre nell’ambito dei finanziamenti elettorali, infine, lo stesso Obama qualche giorno fa è stato al centro di una nuova polemica quando è emerso che due importanti finanziatori democratici sono risultati essere i fratelli di un magnate messicano del gioco d’azzardo, Juan José “Pepe” Rojas Cardona, il quale nel 1994 era fuggito dagli Stati Uniti mentre era in libertà vigilata in Iowa. “Pepe” Cardona è stato successivamente collegato ad episodi di violenza e corruzione in Messico, mentre i suoi due fratelli, residenti a Chicago, sul finire del 2010 cercavano di ottenere per lui un provvedimento di grazia da parte dell’allora governatore democratico dell’Iowa, Chet Culver.
Anche se la squadra di Obama ha negato di essere a conoscenza dei legami dei due donatori messicani, di fronte alle pressioni della stampa si è vista costretta ad annunciare la restituzione di oltre 200 mila dollari in finanziamenti elettorali che la famiglia Cardona aveva erogato per la campagna del presidente.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il primo ministro romeno, Emil Boc, lunedì ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito alle proteste di massa scoppiate nel paese contro le misure di austerity adottate dal suo governo. In diretta TV, il premier conservatore ha affermato di aver lasciato la guida dell’Esecutivo per cercare di attenuare le tensioni e, soprattutto, per salvare gli stessi provvedimenti draconiani che hanno spinto centinaia di migliaia di cittadini a scendere in piazza.
Nonostante l’addio di Boc fosse una delle principali richieste dei manifestanti, è comunque da escludere che il corso della politica in Romania possa prendere ora una strada diversa da quella seguita dal gabinetto uscente.
In seguito al crollo del governo Boc, il presidente romeno, Traian Basescu, ha immediatamente nominato nuovo premier ad interim il ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, il quale aveva avuto un ruolo di primo piano nei colloqui con Bruxelles che portarono il suo paese nell’Unione Europea nel 2007. Con ogni probabilità, Predoiu rimarrà tuttavia in carica solo per pochi giorni, fino a quando cioè il primo ministro incaricato, Mihai-Razvan Ungureanu, avrà ultimato le procedure costituzionali per formare il prossimo governo.
Il 43enne Ungureanu è un ex membro del PNL (Partito Liberale Nazionale), attualmente all’opposizione, ed è il capo dei servizi segreti esteri romeni (SIE). Già ministro degli Esteri tra il 2004 e il 2007, Ungureanu si è subito affrettato a promettere di proseguire le “riforme” lanciate dal suo predecessore, cioè la politica di rigore che ha ulteriormente aggravato le condizioni di vita di milioni di persone in Romania. A conferma della continuità del prossimo esecutivo, la testata giornalistica romena Mediafax ha ipotizzato che il premier in pectore potrebbe promuovere l’attuale vice-ministro delle Finanze, Bogdan Dragoi, a capo dello stesso dicastero e nominare la consigliera economica di Emil Boc, Andreea Paul-Vass, a ministro dell’Economia.
Per formare il nuovo governo, Ungureanu dovrà assicurarsi l’appoggio dei Liberal Democratici (PDL) dello stesso Boc che, assieme a formazioni minori, detengono la maggioranza in Parlamento. Dal momento che il sostegno appare scontato, la crisi dovrebbe risolversi in tempi rapidi. Le consultazioni per la scelta dei ministri sono già state avviate martedì. Ungureanu avrà dieci giorni di tempo per presentare il suo gabinetto e due mesi per ottenere la fiducia della Camera e del Senato. Le elezioni generali sono previste per il prossimo novembre ma, alla luce del crescente conflitto sociale, sembra tutt’altro che scontato che Ungureanu possa traghettare il paese fino a quella data.
 Come già anticipato, la caduta di Boc è dovuta principalmente alle reazioni provocate dalle durissime misure di austerity imposte alla gran parte della popolazione romena fin dalla sua ascesa al potere nel dicembre del 2008. Il suo governo, tra l’altro, ha provveduto a tagliare di circa un quarto gli stipendi dei dipendenti pubblici (in un paese dove il salario medio mensile è di appena 350 euro), ha licenziato più di 200 mila statali dal 2009 a oggi ed ha aumentato l’IVA dal 19 al 24%.
Come già anticipato, la caduta di Boc è dovuta principalmente alle reazioni provocate dalle durissime misure di austerity imposte alla gran parte della popolazione romena fin dalla sua ascesa al potere nel dicembre del 2008. Il suo governo, tra l’altro, ha provveduto a tagliare di circa un quarto gli stipendi dei dipendenti pubblici (in un paese dove il salario medio mensile è di appena 350 euro), ha licenziato più di 200 mila statali dal 2009 a oggi ed ha aumentato l’IVA dal 19 al 24%.
Queste ed altre iniziative sono state chieste dal Fondo Monetario Internazionale come condizioni per un prestito da 20 miliardi di euro che è stato erogato nel 2009 per proteggere la Romania dalla crisi finanziaria internazionale.
Più recentemente l’FMI ha concesso un nuovo prestito precauzionale da 5 miliardi di euro alla Romania, in cambio del quale il governo di Bucarest si è impegnato a svendere alcune quote di svariate aziende pubbliche in settori nevralgici, a cominciare da quello energetico.
Dopo le dimissioni di Boc, lo stesso FMI ha tenuto a precisare che l’accordo siglato con il governo romeno non verrà messo in discussione dal nuovo governo. La fiducia del Fondo Monetario Internazionale deriva dal fatto che, nonostante le critiche rivolte dai partiti dell’opposizione alla maggioranza e la richiesta di elezioni anticipate, tutte le forze politiche romene condividono la necessità di continuare a far pagare gli effetti della crisi alle classi più disagiate. Quello che sta avvenendo in Romania, ha detto significativamente un’economista di Volksbank alla Reuters, “è solo un cambio di persone e non determinerà nessun mutamento radicale dell’agenda di governo”.
Partiti come il PNL o il PSD - Partito Social Democratico, alla guida della coalizione USL (Unione Sociale Liberale), di cui fanno parte altre due formazioni conservatrici - hanno d’altra parte già governato a più riprese negli ultimi due decenni, contribuendo dapprima alle privatizzazioni selvagge in seguito alla caduta del regime stalinista e successivamente abbracciando le direttive UE per liberalizzare ulteriormente l’economia romena.
 Questo scenario fa sì che in Romania sia diffusa una generale avversione nei confronti di tutte le formazioni politiche. Le proteste delle ultime settimane, senza precedenti nel paese negli ultimi vent’anni, sono perciò esplose in maniera del tutto spontanea.
Questo scenario fa sì che in Romania sia diffusa una generale avversione nei confronti di tutte le formazioni politiche. Le proteste delle ultime settimane, senza precedenti nel paese negli ultimi vent’anni, sono perciò esplose in maniera del tutto spontanea.
A fare da detonatore alla rabbia popolare erano state a gennaio le dimissioni del vice-ministro della Sanità, Raed Arafat, vittima di una campagna diffamatoria orchestrata dal presidente Basescu.
Arafat, medico di origine palestinese trasferitosi in Romania all’inizio degli anni Ottanta, si era infatti permesso di esprimere pubblicamente la propria contrarietà alla privatizzazione del sistema sanitario voluta dal governo. Le manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti sono poi rapidamente sfociate in un movimento di protesta contro le misure di austerity implementate negli ultimi anni.
Alle proteste, le forze di sicurezza hanno risposto con il pugno di ferro, causando un innalzamento delle tensioni nel paese. Per placare gli animi a nulla era servito il reinsediamento dello stesso Arafat, né il licenziamento lo scorso 23 gennaio del ministro degli Esteri, Teodor Baconschi, il quale aveva apostrofato con parole gravemente offensive i manifestanti scesi nelle piazze.
Sull’onda delle pressioni popolari, il governo di Emil Boc è così inevitabilmente crollato, anche se al profondo malcontento diffuso nel paese non potrà in nessun modo far fronte il nuovo esecutivo romeno che si appresta a nascere nei prossimi giorni a Bucarest.
