- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Mentre le forze “ribelli” si apprestano all’assalto finale contro la roccaforte della resistenza di Gheddafi a Sirte, ìeri a Parigi è andata in scena la conferenza dei cosiddetti “Amici della Libia”, fortemente voluta dal presidente francese Nicolas Sarkozy e dal primo ministro britannico David Cameron. Alla presenza di 60 delegazioni tra governi e organizzazioni internazionali, i leader dei paesi NATO protagonisti dell’aggressione militare hanno discusso il futuro del paese nordafricano con il Consiglio Nazionale di Transizione, rappresentato dal segretario Mustafa Abdel Jalil e dal primo ministro Mahmoud Jibril.
Alla conferenza parigina - organizzata significativamente nello stesso giorno in cui 42 anni fa Gheddafi saliva al potere rovesciando la monarchia di re Idris - hanno partecipato anche i rappresentanti di Germania, Cina e Russia. Tutti e tre questi paesi si erano astenuti nel voto al Consiglio di Sicurezza ONU del 17 marzo scorso con cui venne approvata la risoluzione 1973 che ha fornito il pretesto per aprire le ostilità contro il regime di Gheddafi e, in particolare Cina e Russia, avevano successivamente criticato la NATO per essere andata al di là del mandato ONU per proteggere la popolazione civile.
Ora, tuttavia, nessuno di questi governi intende rimanere indietro nella corsa alla spartizione delle risorse libiche che si sta per scatenare. Allo stesso modo, a motivare la loro condotta è il tentativo di salvare quanto possibile i contratti nei settori energetico ed edilizio che avevano stipulato con il governo di Tripoli prima del conflitto. A conferma dell’atteggiamento pragmatico adottato da questi governi di fronte alla cambiata realtà sul campo, proprio giovedì Mosca ha annunciato il riconoscimento ufficiale del CNT come rappresentante legittimo della Libia.
Assente dal vertice di Parigi è stato invece il Sud Africa, il quale, pur avendo votato a favore della risoluzione ONU come membro provvisorio del Consiglio di Sicurezza, rimane critico verso il comportamento dei paesi NATO, accusati tra l’altro di aver boicottato i ripetuti sforzi del governo del presidente Jacob Zuma per trovare una soluzione pacifica alla crisi libica.
Le discussioni, in ogni caso, hanno riguardato principalmente le azioni da intraprendere al termine della campagna militare e l’instaurazione di un governo docile che sia in grado di superare le divisioni che già stano emergendo in tutta la loro gravità tra i “ribelli” a poco più di una settimana dalla presa di Tripoli.
“Il lavoro non termina con la fine di un regime oppressivo”, ha avvertito il Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, ai convenuti a Parigi. “Vincere una guerra non offre garanzie di pace. Quello che accadrà nei prossimi giorni sarà d’importanza cruciale”. Come hanno sottolineato ampiamente i media in questi giorni, la preoccupazione dei governi occidentali è quella di evitare una deriva settaria e violenta come quella dell’Iraq all’indomani dell’invasione americana del 2003.
 Anche se esclusa ufficialmente dall’ordine del giorno, la spartizione delle ricchezze energetiche libiche e l’assegnazione degli appalti per la ricostruzione hanno verosimilmente rappresentato due dei punti centrali nei colloqui tra le potenze NATO e il CNT. In questo senso sarà da verificare quanto terreno dovrà cedere l’ENI in Libia, dove con Gheddafi aveva goduto di una posizione di assoluto privilegio.
Anche se esclusa ufficialmente dall’ordine del giorno, la spartizione delle ricchezze energetiche libiche e l’assegnazione degli appalti per la ricostruzione hanno verosimilmente rappresentato due dei punti centrali nei colloqui tra le potenze NATO e il CNT. In questo senso sarà da verificare quanto terreno dovrà cedere l’ENI in Libia, dove con Gheddafi aveva goduto di una posizione di assoluto privilegio.
Nonostante la salvaguardia degli interessi energetici italiani sia stato il motivo principale per il quale il governo Berlusconi si è accodato a Parigi e a Londra nella guerra alla Libia, è probabile che soprattutto l’intraprendenza transalpina determinerà un cambiamento degli equilibri nel paese. I francesi, infatti, oltre ad aver orchestrato la ribellione contro il regime di Gheddafi, si sono mossi in fretta per stabilire rapporti con il governo provvisorio. Almeno a partire da giugno, ad esempio, i dirigenti di alcune grandi aziende come Total hanno iniziato a frequentare Bengasi per gettare le basi di futuri contratti.
Sempre a Parigi, inoltre, nel mese di settembre è in programma un incontro tra i vertici del CNT e le compagnie francesi operanti in Libia per discutere di nuovi possibili progetti. “Dobbiamo fare un passo per volta”, ha detto chiaramente il numero uno della Camera di Commercio franco-libica, Michel Casals, alla Reuters, “ma dobbiamo trarre vantaggio da questo clima favorevole per le compagnie francesi, anche se i nostri concorrenti - turchi, cinesi o europei - sono molto agguerriti”.
Da parte sua, il segretario del CNT Jalil ha presentato la roadmap per la nuova costituzione, da sottoporre a referendum, e per le elezioni, da tenere entro 18 mesi. Per il CNT la questione più pressante è però quella dello sblocco dei beni libici congelati sui conti esteri di numerosi paesi occidentali. I vari governi partecipanti alla conferenza hanno già ottenuto di recente il via libera per qualche miliardo di dollari ma, soprattutto, stanno studiando nuove soluzioni per aggirare gli ostacoli legali che bloccano la gran parte dei fondi e chiedendo alla commissione ONU per le sanzioni di approvare apposite misure per poterli sbloccare definitivamente e trasferirli nelle casse del nuovo regime.
Sul fronte militare, intanto, i “ribelli” si sono posizionati alle porte di Sirte, città natale di Gheddafi e centro principale della tribù di cui il colonnello fa parte (Gaddafa). Il CNT ha lanciato un ultimatum - puntualmente rifiutato - alla resistenza del rais per arrendersi pacificamente entro sabato così da evitare un assalto militare. L’ultimatum è stato poi posticipato di una settimana, per consentire il proseguimento dei colloqui in corso tra il CNT e i capi tribù di Sirte. Nel frattempo, le forze “ribelli”, appoggiate da reparti speciali britannici e del Qatar, hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale di tre giorni, in occasione della festa per la fine del Ramadan (Id al-fitr).
 Quello che si prospetta per Sirte e Bani Walid - una città di 50 mila abitanti nel deserto a sud-est di Tripoli dove secondo alcuni membri del CNT potrebbe trovare rifugio Gheddafi - se non si troverà una soluzione concordata è un bagno di sangue, preannunciato dai bombardamenti NATO degli ultimi giorni. Secondo il resoconto, peraltro senza riscontri indipendenti, del portavoce di Gheddafi, Moussa Ibrahim, in queste due località le bombe occidentali avrebbe già fatto oltre mille vittime.
Quello che si prospetta per Sirte e Bani Walid - una città di 50 mila abitanti nel deserto a sud-est di Tripoli dove secondo alcuni membri del CNT potrebbe trovare rifugio Gheddafi - se non si troverà una soluzione concordata è un bagno di sangue, preannunciato dai bombardamenti NATO degli ultimi giorni. Secondo il resoconto, peraltro senza riscontri indipendenti, del portavoce di Gheddafi, Moussa Ibrahim, in queste due località le bombe occidentali avrebbe già fatto oltre mille vittime.
L’imminente assedio di Sirte rischia di trasformarsi così in quell’evento (l’assedio di Gheddafi contro Bengasi, appunto) che la NATO pretende di aver evitato con l’intervento militare seguito alla risoluzione ONU di marzo. Lo scrupolo per la sorte dei civili da parte dei “ribelli” è apparsa d’altra parte evidente dalla dichiarazione fatta durante una recente conferenza stampa da Ali Tarhouni, numero due del CNT. Per quest’ultimo, infatti, “qualche volta per evitare una carneficina è necessario che ci sia comunque uno spargimento di sangue”.
Il massacro di civili che si prospetta andrebbe ad aggiungersi al già lungo elenco di crimini ascritti alle forze “ribelli” e alla NATO stessa in questi mesi, nonostante i media occidentali abbiano raccontato quasi unicamente la repressione del regime, come i bombardamenti indiscriminati su Tripoli ed altre città controllate da Gheddafi o l’uccisione e il linciaggio dei fedeli di quest’ultimo e degli immigrati africani di colore accusati di essere mercenari al suo servizio.
Mentre a Parigi si festeggia la buona riuscita dell’impresa libica, è proprio il CNT da Bengasi a dare un’idea più accurata del risultato dell’operazione. Secondo un portavoce, il bilancio provvisorio di quasi sei mesi di combattimenti per rovesciare il regime è di qualcosa come 50 mila morti tra civili e combattenti. Una cifra ben più pesante di qualsiasi repressione che si intendeva evitare e che la dice lunga sugli scopi “umanitari” dell’intervento NATO.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il ministro delle Finanze giapponese, Yoshihiko Noda, questa settimana è diventato il sesto primo ministro del paese negli ultimi cinque anni. Il neo-premier ha sconfitto l’agguerrita concorrenza interna al partito di maggioranza - Partito Democratico (DPJ) - tuttora scosso dalle conseguenze del disastroso terremoto del marzo scorso e profondamente diviso sugli orientamenti strategici ed economici del Giappone.
Dopo aver conquistato la leadership del partito lunedì scorso, Noda ha incassato il voto di fiducia della Camera bassa del Parlamento nipponico (Dieta), succedendo al premier uscente, Naoto Kan, alla guida del governo. Le dimissioni di quest’ultimo erano nell’aria da parecchie settimane, dopo che i suoi indici di gradimento erano crollati a causa della cattiva gestione del disastro nucleare seguito al terremoto.
Yoshihiko Noda è il terzo premier Democratico - dopo Yukio Hatoyama e lo stesso Kan - dalla vittoria del suo partito nel settembre 2009 che ha posto fine a un monopolio pressoché ininterrotto di mezzo secolo del Partito Liberal Democratico (LDP) alla guida del paese. Nella sfida interna al partito, Noda ha sconfitto al secondo turno il candidato proposto dal leader non ufficiale, nonché fondatore, del Partito Democratico, Ichiro Ozawa, il quale aveva puntato le sue carte sul ministro del Commercio, Banri Kaieda.
Escluso dal ballottaggio dopo il terzo posto del primo turno è stato invece l’ex ministro degli Esteri, Seiji Maehara, considerato il favorito della vigilia assieme a Kaieda. Maehara fa parte della stessa corrente di Noda, ma la sua candidatura è stata verosimilmente compromessa dall’accusa di aver ricevuto un contributo elettorale da un cittadino straniero residente in Giappone, pratica illegale per il codice nipponico e che aveva portato alle sue dimissioni già nel mese di marzo.
 Il duro confronto tra le due fazioni del partito di governo riflette non solo le divisioni prodotte dalla controversa figura dello stesso Ozawa, estromesso dal partito per uno scandalo legato a finanziamenti illeciti, ma soprattutto i veri e propri dilemmi che travagliano l’élite politica ed economica del Giappone.
Il duro confronto tra le due fazioni del partito di governo riflette non solo le divisioni prodotte dalla controversa figura dello stesso Ozawa, estromesso dal partito per uno scandalo legato a finanziamenti illeciti, ma soprattutto i veri e propri dilemmi che travagliano l’élite politica ed economica del Giappone.
Profonde differenze esistono infatti nella classe dirigente sia sul percorso da intraprendere per resuscitare un paese che da tempo attraversa un grave declino economico, sia sull’atteggiamento da tenere nei confronti di quello che è diventato ormai il maggiore partner commerciale - la Cina - e del tradizionale alleato - gli Stati Uniti - in un clima di crescente tensione tra le due superpotenze.
I differenti punti di vista su entrambe le questioni hanno così segnato gli scontri nel Partito Democratico in questi due anni per la selezione degli uomini destinati a guidare il paese. Da un lato, la fazione vicina a Ozawa appoggia rapporti più stretti con la Cina - a scapito della relazione con Washington - e dimostra una certa propensione ad adottare misure di stimolo all’economia basate sull’aumento della spesa pubblica. Dall’altro, la fazione rivale auspica il mantenimento di solidi legami con gli USA e un allineamento alla politica di contenimento della spesa perseguita dai paesi occidentali.
Su questi due punti nel 2009 aveva condotto la campagna elettorale l’allora candidato premier alleato di Ozawa, Yukio Hatoyama, per ritrovarsi poi sotto pressione e costretto alle dimissioni pochi mesi dopo aver assunto la guida del governo. Le misure promesse per aumentare i programmi sociali provocarono la reazione dei mercati internazionali, preoccupati per la solvibilità di un paese che già registra il più alto livello d’indebitamento del pianeta, così come la volontà di intensificare i rapporti con Pechino e di chiudere la base americana sull’isola di Okinawa si scontrarono con la ferma opposizione degli Stati Uniti.
Il cambio della guardia al vertice del governo nel giugno 2010 segnò contestualmente il declino della fazione facente capo a Ichiro Ozawa nel Partito Democratico. L’ascesa di Naoto Kan e il cambiato clima internazionale riproposero così anche in Giappone l’adozione di misure di austerity per far fronte al dilagante debito pubblico. Misure che risultarono tuttavia impopolari e che influirono in maniera decisiva nella sconfitta dello stesso Partito Democratico nelle elezioni per la Camera alta, ora dominata dal Partito Liberal Democratico. Al cambiamento di rotta sul fronte interno fece così seguito la riproposizione della partnership strategica con gli USA e un irrigidimento nei confronti della Cina, sfociato successivamente in alcuni incidenti diplomatici fra i due paesi vicini.
 Fedele a questa linea, subito dopo la nomina a primo ministro, Yoshihiko Noda ha prospettato ulteriori provvedimenti tesi a ridurre la spesa pubblica del Giappone. “Il messaggio che intendo inviare sia al Giappone che all’estero, è che la nostra disciplina fiscale non è compromessa”, è stata la prima dichiarazione da capo del governo del 54enne Noda.
Fedele a questa linea, subito dopo la nomina a primo ministro, Yoshihiko Noda ha prospettato ulteriori provvedimenti tesi a ridurre la spesa pubblica del Giappone. “Il messaggio che intendo inviare sia al Giappone che all’estero, è che la nostra disciplina fiscale non è compromessa”, è stata la prima dichiarazione da capo del governo del 54enne Noda.
Già alla vigilia del voto in Parlamento, quest’ultimo aveva d’altra parte fatto capire che nuove tasse, tagli alla spesa e privatizzazioni di beni pubblici sarebbero stati presto all’ordine del giorno per far fronte al costo della ricostruzione del paese dopo il terremoto e lo tsunami di marzo.
Le divisioni all’interno del partito, l’impopolarità delle misure che s’intravedono all’orizzonte e l’oggettiva complessità dei problemi che affliggono il paese asiatico renderanno con ogni probabilità ben presto estremamente precaria anche la posizione del nuovo primo ministro.
A ricordare la precarietà della situazione in Giappone, la settimana scorsa l’agenzia di rating Moody’s ha declassato il debito giapponese da AA2 a AA3, mentre un altro nodo delicato riguarderà l’eventuale liquidazione del nucleare, promessa dopo il disastro di Fukushima dall’ormai ex premier Naoto Kan e verso la quale il suo successore si è mostrato invece decisamente più prudente.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Mentre i “ribelli” libici settimana scorsa facevano il loro ingresso a Tripoli grazie ai massicci bombardamenti NATO contro le forze fedeli a Muammar Gheddafi, una nuova serie di documenti riservati veniva pubblicata da Wikileaks, molti dei quali riguardanti proprio i rapporti tra gli Stati Uniti e il regime del rais. Un rapporto quello tra Washington e Tripoli fondato fino a pochi mesi fa su una stretta collaborazione tra i rispettivi governi, nonostante i dubbi di fondo mai completamente dissipati circa l’affidabilità del colonnello.
Tra i più accesi sostenitori dell’aggressione contro la Libia negli Stati Uniti spicca il senatore dell’Arizona John McCain, già sfidante repubblicano di Barack Obama durante le presidenziali del 2008. Il veterano della guerra in Vietnam, nel corso di varie interviste ai media d’oltreoceano in questi mesi, ha descritto Gheddafi come “uno dei più sanguinari dittatori sulla terra”, mentre ha più volte criticato l’amministrazione Obama per non essere intervenuta in maniera ancora più aggressiva, così da rovesciare rapidamente il regime libico.
Lo stesso McCain, in realtà, poco più di due anni fa sedeva in una tenda a Tripoli discutendo della partnership tra USA e Libia con lo stesso Gheddafi e il figlio Muatassim, promettendo di adoperarsi per far giungere all’allora alleato nordafricano gli armamenti desiderati.
Il suddetto incontro ad alto livello nella capitale libica - andato in scena il 14 agosto 2009 - è descritto in un cablo confidenziale redatto dall’ambasciata americana a Tripoli cinque giorni più tardi. Oltre a John McCain, facevano parte della trasferta in Libia, tra gli altri, anche i senatori repubblicani Lindsey Graham (Sud Carolina) e Susan Collins (Maine) e l’indipendente ex democratico Joe Lieberman (Connecticut).
In un’atmosfera estremamente cordiale, McCain ribadiva l’eccellente stato delle relazioni tra i due paesi, sottolineando il “drastico cambiamento nei rapporti avvenuto negli ultimi cinque anni”. Da parte sua, il senatore Lieberman elogiava il mantenimento della promessa fatta da Gheddafi di abbandonare il programma per la produzione di armi di distruzione di massa e di rinunciare all’appoggio al terrorismo internazionale. Lo stesso candidato alla vice-presidenza USA nel 2000 descriveva la Libia come un importante alleato nella lotta al terrore, affermando che i “nemici comuni rendono un’amicizia più solida”.
 I “nemici comuni” di cui parlava Lieberman altro non sono che i gruppi integralisti islamici tenuti a bada dal regime di Gheddafi e i cui affiliati fanno parte oggi delle forze “ribelli” sostenute dall’Occidente. La presenza nel governo di transizione di militanti libici è testimoniata dalla riluttanza di alcuni paesi a riconoscerlo come rappresentante legittimo della Libia, come ad esempio l’Algeria. In una recente intervista alla Reuters, una fonte interna al governo algerino ha infatti rivelato che alcuni militanti islamici consegnati da Algeri a Gheddafi sarebbero fuggiti per unirsi ai “ribelli”. A detta dello stesso anonimo funzionario algerino, uno di questi islamici sarebbe addirittura apparso su Al Jazeera mentre “parlava in nome del governo di transizione” di Bengasi.
I “nemici comuni” di cui parlava Lieberman altro non sono che i gruppi integralisti islamici tenuti a bada dal regime di Gheddafi e i cui affiliati fanno parte oggi delle forze “ribelli” sostenute dall’Occidente. La presenza nel governo di transizione di militanti libici è testimoniata dalla riluttanza di alcuni paesi a riconoscerlo come rappresentante legittimo della Libia, come ad esempio l’Algeria. In una recente intervista alla Reuters, una fonte interna al governo algerino ha infatti rivelato che alcuni militanti islamici consegnati da Algeri a Gheddafi sarebbero fuggiti per unirsi ai “ribelli”. A detta dello stesso anonimo funzionario algerino, uno di questi islamici sarebbe addirittura apparso su Al Jazeera mentre “parlava in nome del governo di transizione” di Bengasi.
Sempre nel corso dello stesso meeting, Muatassim Gheddafi, allora consigliere del padre per la sicurezza nazionale, esprimeva a sua volta soddisfazione per la visita degli autorevoli politici americani, pur lamentando la mancanza di “garanzie relative alla sicurezza” del suo paese da parte degli Stati Uniti. La richiesta, già fatta il precedente mese di aprile al Segretario di Stato, Hillary Clinton, riguardava principalmente la fornitura di armamenti americani “letali e non letali”, per i quali McCain affermava di volersi impegnare in prima persona per accelerare i tempi di consegna, sia presso il Congresso che con il numero uno del Pentagono, Robert Gates.
La collaborazione tra i due paesi comprendeva anche l’addestramento di personale libico nelle accademie militari americane. La formazione garantita da Washington agli ufficiali di Gheddafi s’inseriva nella partnership costruita con la Libia in funzione anti-terroristica dopo lo sdoganamento del regime da parte dell’amministrazione Bush. Il ruolo di Tripoli in nord Africa, senza scrupolo alcuno per i metodi repressivi del rais, era appunto quello di soffocare le cellule legate ad Al-Qaeda, come conferma un altro cablo del febbraio 2009, nel quale l’ambasciata americana elogiava Gheddafi per aver “smantellato una rete in Libia orientale che inviava volontari a combattere in Algeria e in Iraq” e stava progettando attacchi terroristici in Libia.
In un cablo dell’aprile 2009 si parla poi dei preparativi per una imminente visita a Washington di Muatassim Gheddafi che sarebbe stata l’occasione per “incontrare il potenziale futuro leader della Libia”. Il ruolo del quinto figlio del rais all’interno dell’apparato della sicurezza del regime risultava di importanza cruciale e il suo appoggio veniva perciò valutato indispensabile dal governo americano per promuovere a Tripoli i propri interessi.
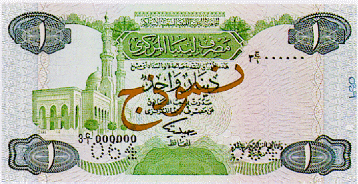 L’apprezzamento del governo americano per il regime di Gheddafi riguardava anche le aperture fatte negli ultimi anni al capitale straniero. Un documento del 10 febbraio 2009 ricorda come la “Libia ha approvato numerose leggi e regolamentazioni tese a migliorare l’ambiente degli affari e per attrarre investimenti esteri”. Gli sforzi, tuttavia, sembravano avere solo un “modesto successo”, anche se le compagnie internazionali stavano tornando a fare affari in Libia, soprattutto dopo la soppressione delle sanzioni ONU nel 2003.
L’apprezzamento del governo americano per il regime di Gheddafi riguardava anche le aperture fatte negli ultimi anni al capitale straniero. Un documento del 10 febbraio 2009 ricorda come la “Libia ha approvato numerose leggi e regolamentazioni tese a migliorare l’ambiente degli affari e per attrarre investimenti esteri”. Gli sforzi, tuttavia, sembravano avere solo un “modesto successo”, anche se le compagnie internazionali stavano tornando a fare affari in Libia, soprattutto dopo la soppressione delle sanzioni ONU nel 2003.
Le opportunità a disposizione delle compagnie energetiche e di costruzioni in Libia sono al centro di molti altri cablogrammi trasmessi al Dipartimento di Stato dall’ambasciata USA a Tripoli. In alcuni di essi emerge però anche una certa persistente diffidenza nei confronti di Gheddafi, mai visto fino in fondo come un serio partner per l’Occidente.
A suscitare preoccupazioni non sono mai state in ogni caso le violazioni dei diritti umani o il soffocamento del dissenso, bensì la minaccia di estrarre condizioni meno favorevoli alle compagnie occidentali operanti nel paese nordafricano - come quelle, descritte in un cablo del 26 ottobre 2007, imposte all’ENI in occasione dell’estensione delle concessioni per l’estrazione di gas e petrolio che stavano per scadere - o i rapporti sempre più stretti che Gheddafi stava coltivando con Russia e Cina.
Questi ed altri documenti già pubblicati nei mesi scorsi da Wikileaks contribuiscono dunque a smascherare le pretese dei governi coinvolti nel rovesciamento del regime di Tripoli di agire per la promozione della democrazia e per proteggere i civili. Da Washington a Londra, da Parigi a Roma, fino a pochi mesi fa si faceva a gara per corteggiare il dittatore Gheddafi e il suo entourage, nel tentativo di garantire alle proprie corporation lucrosi affari e l’accesso a quelle ingenti risorse petrolifere libiche che queste ultime si apprestano ora a spartirsi sotto la supervisione di un regime più docile verso gli interessi occidentali.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Nel Neghev occidentale il cessate il fuoco unilaterale annunciato nella notte di giovedì dai jihadisti della Striscia di Gaza non è durato che poche ore: ad interropere la fragile tregua è stato un missile Grad BM21 esploso alle prime ore dell’alba in un’area disabitata a sud di Ashkelon, la città portuale situata lungo la costa mediterranea di Israele; altri sei Grad sono poi caduti nelle vicinanze di Ofakim e Sderot e sulla periferia di Be’er Sheva dove l’esplosione ha causato la morte di un civile di trent'anni e il ferimento di altri otto, due dei quali in modo grave.
Tra mercoledì e giovedì sera le fazioni combattenti palestinesi avevano forzato la mano colpendo con almeno 38 razzi Qassam e proiettili di mortaio pestato le zone agricole dei consigli regionali di Eshkol e Sha’ar HaNegev, attacchi nei quali era rimasta ferimento una bambina di nove mesi e che avevano prodotto ingenti danni alle strutture del valico di frontiera di Erez. Durante la successiva azione israeliana gli F15 dell’IAF(Israel Air Forces) avrebbero poi bombardato le rampe di lancio di Al-Maghazi e Beit Lehiya ed ucciso due membri delle Brigate Al-Quds, braccio armato del Movimento per la Jihad islamica in Palestina.
Dallo scorso week-end sarebbero almeno 26 le vittime palestinesi delle operazioni aeree israeliane: tra loro Abu Awad An-Nayrab, personaggio di spicco delle Brigate Al-Quds; Moataz Qouriqa, responsabile del braccio armato della Jihad islamica, colpito a morte nel campo profughi di Al-Bureij insieme al fratello Munzer e al figlio di 5 anni; Samed Muti Abed, esponente dei Comitati di Resistenza popolare e tra i principali organizzatori del blitz a nord di Eilat. Dal 18 agosto scorso, giorno del triplice attentato, sul sud dello Stato ebraico sarebbero caduti più di 150 razzi, un’offensiva alla quale Israele ha risposto con un massiccio utilizzo del sistema di difesa antimissile Iron Dome e con non meno di 60 sortite aeree.
Giorno dopo giorno la Striscia di Gaza ha subito i bombardamenti dei caccia e dei droni israeliani: colpiti i centri abitati di Khan Younis, Beit Lahiya, Beit Hanoun e Rafah; centrati il campo profughi di Al-Maghazi, Al-Bureij e Al-Nuseirat e i quartieri centrali della stessa Gaza City. Secondo il Centro palestinese per i diritti umani (PCHR), tra gli abitanti di Gaza ci sarebbero anche otto persone rimaste vittime dal così detto “fuoco amico”: tre uomini, tre donne e due bambini feriti dai razzi jihadisti caduti per errore sui villaggi di Deir Al-Balah e al-Shouka e sui nei quartieri orientali di Al-Shuja'ya e Al-Toffah a Gaza City.
 Concordato domenica 21 agosto dai rappresentanti di Hamas e Israele, il primo cessate il fuoco era stato subito disatteso dal lancio di sedici razzi sparati dai miliziani delle Brigate Al-Quds sulle zone periferiche di Eshkol, Sderot, Ashkelon e Be’er Sheba. La seconda tregua, alla quale avrebbero dovuto aderire tutti i gruppi armati della Striscia di Gaza, era stata invece il risultato di un’iniziativa unilaterale della Jihad islamica, lo stesso gruppo che a meno di 48 ore dall’ultima violazione ha deciso di riproporre un nuovo cessate il fuoco. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Ma’an il leader del movimento jihadista a Gaza ha dichiarato che l’escalation del conflitto non potrebbe che danneggiare la popolazione della Striscia e mettere a rischio la vita dei stessi leader delle fazioni armate.
Concordato domenica 21 agosto dai rappresentanti di Hamas e Israele, il primo cessate il fuoco era stato subito disatteso dal lancio di sedici razzi sparati dai miliziani delle Brigate Al-Quds sulle zone periferiche di Eshkol, Sderot, Ashkelon e Be’er Sheba. La seconda tregua, alla quale avrebbero dovuto aderire tutti i gruppi armati della Striscia di Gaza, era stata invece il risultato di un’iniziativa unilaterale della Jihad islamica, lo stesso gruppo che a meno di 48 ore dall’ultima violazione ha deciso di riproporre un nuovo cessate il fuoco. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Ma’an il leader del movimento jihadista a Gaza ha dichiarato che l’escalation del conflitto non potrebbe che danneggiare la popolazione della Striscia e mettere a rischio la vita dei stessi leader delle fazioni armate.
Dawood Shibab è infatti convinto che tra gli obbiettivi israeliani c’è quello di decapitare i vertici delle organizzazioni combattenti; ipotesi avvalorata da un reportage pubblicato dal quotidiano Al-Ahram nel quale si parla di un piano che sarebbe dovuto scattare in seguito agli attentati del 18 agosto scorso e di una mediazione egiziana per impedire l’assassinio dello stesso primo ministro Ismayl Haniyeh.
A poco più di una settimana dagli attacchi a nord di Eilat, il Cairo e Tel Aviv hanno concordato un aumento della presenza militare egiziana nel deserto del Sinai. Diventata la sponda logistica delle formazioni armate che operano a Gaza, la penisola è in gran parte controllata dai trafficanti e dalle bande armate, cresciute soprattutto grazie alla presenza di decine di jihadisti scappati dalle prigioni egiziane durante la rivolta contro Mubarak. Le frange più dure avrebbero dato vita al movimento Al-Shabab Al-Islam, gruppo salafita vicino alle posizioni di Al-Quaeda, ma nel Sinai si parla della presenza di personaggi storici del terrorismo internazionale come Rafa’i Ahmed Taha, Alì Abu Faris e Ramzi Mahmoud Al Munafi, ex dottore di Bin Laden.
Per combattere il contrabbando di armi e la nebulosa collaborazione che lega questi gruppi alle formazioni palestinesi, l’esercito egiziano starebbe addirittura negoziando con i capi delle tredici tribù beduine che abitano la penisola. In cambio di un accordo che prevede la protezione del confine con Israele il Cairo sarebbe pronto ad offrire armi, addestramento e il pagamento di un assegno mensile. Due le tribù che avrebbero già aderito: la Sawarkas, che ha il controllo dell’area che dalla Philadelphi Route arriva fino alle coste mediterranee del Sinai, e la Tiyaha, che dal posto di confine di Nitzana si addentra fino alla zona centrale della penisola.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Come annunciato da settimane, l’accusa di stupro nei confronti dell’ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, è stata archiviata definitivamente martedì dietro richiesta della stessa procura di Manhattan che aveva istruito il caso. Il crollo dell’impianto accusatorio ha messo in luce le carenze di un’indagine condotta in maniera affrettata e, soprattutto, ha rivelato le distorsioni del sistema giudiziario americano in un caso con profonde implicazioni politiche.
L’ex ministro delle Finanze francese, come è noto, era stato arrestato il 14 maggio scorso mentre era a bordo di un aereo dell’Air France in partenza dall’aeroporto Kennedy di New York. La polizia della metropoli americana si era attivata prontamente in seguito alla denuncia di una dipendente di un lussuoso hotel appartenente alla catena francese Sofitel. La donna, la 33enne immigrata dalla Guinea Nafissatou Diallo, aveva sostenuto che, dopo essere entrata nella suite dell’importante economista e uomo politico transalpino per effettuare le pulizie che le erano state assegnate, era stata costretta ad un rapporto sessuale contro la sua volontà.
L’indagine sulla condotta di Strauss-Kahn era stata affidata all’intraprendente procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance jr., il quale aveva puntato tutte le sue carte unicamente sulla testimonianza dell’accusatrice. Su queste basi, l’allora numero uno del FMI era stato sottoposto all’umiliazione della cosiddetta “perp walk” – ovvero l’apparizione pubblica dell’arrestato in manette a beneficio dei media – per essere poi incarcerato e, almeno in un primo momento, vedersi negata la libertà su cauzione.
La clamorosa sventura giudiziaria dell’esponente di spicco del Partito Socialista francese era stata immediatamente sfruttata dalla maggior parte dei media americani, a cominciare dal New York Times, per orchestrare una vergognosa campagna diffamatoria nei suoi confronti. Senza alcun riguardo per la presunzione di innocenza e il diritto dell’accusato ad un trattamento equo ed imparziale, Strauss-Kahn è stato dichiarato sommariamente colpevole dalla stampa e dalle televisioni d’oltreoceano, nonostante non vi fossero testimoni a supportare la tesi della presunta vittima e la ricostruzione della vicenda avesse da subito suscitato più di una perplessità. Sul fronte politico, la grave accusa era stata subito utilizzata per esercitare enormi pressioni su Strauss-Kahn affinché lasciasse la guida del Fondo Monetario Internazionale. Allo stesso tempo, il polverone suscitato dal caso fece sfumare ogni sua possibilità di continuare a perseguire la candidatura alla presidenza francese, per la quale appariva favorito su Nicolas Sarkozy.
Sul fronte politico, la grave accusa era stata subito utilizzata per esercitare enormi pressioni su Strauss-Kahn affinché lasciasse la guida del Fondo Monetario Internazionale. Allo stesso tempo, il polverone suscitato dal caso fece sfumare ogni sua possibilità di continuare a perseguire la candidatura alla presidenza francese, per la quale appariva favorito su Nicolas Sarkozy.
Pur essendo al vertice di un’istituzione responsabile dell’applicazione forzata delle ricette neo-liberali ai paesi in difficoltà finanziarie, Strauss-Kahn appariva attestato su posizioni relativamente meno radicali rispetto a Washington e all’oligarchia finanziaria americana. Non a caso, infatti, dopo il suo arresto le richieste più insistenti di dimissioni furono proprio quelle provenienti dalla Casa Bianca, da dove sarebbe più tardi arrivato il pieno sostegno alla candidatura per la direzione del FMI di un’altra personalità di primo piano del panorama politico francese, la più gradita Christine Lagarde, ex ministro delle Finanze di Sarkozy.
Al di là delle responsabilità di Dominique Strauss-Kahn nei fatti avvenuti nella stanza del Sofitel di New York, l’intero caso ha assunto i contorni di una vera e propria esecuzione politica, portata a termine, come fin troppo spesso è accaduto negli ultimi anni negli Stati Uniti e altrove, grazie alla manipolazione di vere o presunte accuse legate al comportamento sessuale del personaggio pubblico di turno.
Di fronte al giudice della Corte Suprema dello stato di New York, Michael J. Obus, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, pur confermando l’avvenuto rapporto sessuale tra Strauss-Kahn e la sua accusatrice, ha dovuto ammettere la totale assenza di prove di un possibile stupro, al di là della sola testimonianza della donna stessa. Già a partire dal mese di giugno, la credibilità di quest’ultima era stata messa seriamente in discussione da una serie di circostanze. Tuttavia, per svariate settimane la procura aveva cercato di salvare in qualche modo il caso e la faccia di fronte all’opinione pubblica, dopo che le accuse della donna guineana erano state ritenute della massima solidità.
Dagli stessi documenti del procedimento con cui è stata chiesta l’archiviazione emerge la condotta discutibile della procura. All’iniziale completa fiducia nella testimonianza di Nafissatou Diallo ha fatto seguito l’inevitabile ammissione di ritrovarsi in una “situazione nella quale… la credibilità dell’accusatrice non avrebbe potuto sostenere il più semplice dei riscontri”. Infatti, prosegue il documento ufficiale, durante gli interrogatori con gli uomini della procura, “[l’accusatrice] non ha detto la verità, sia sulle questioni di rilievo che su quelle di minore importanza, sia su quelle riguardanti il suo passato che su quelle relative alle circostanze della vicenda”. L’ammissione di responsabilità della procura di Manhattan non spiega in ogni caso i motivi per cui l’attendibilità dell’accusatrice e unica testimone del presunto stupro non sia stata verificata da subito con maggiore scrupolo. La donna, ad esempio, diede ben tre versioni differenti del suo comportamento dopo l’incontro nella suite di Strauss-Kahn, giungendo successivamente addirittura a negare di aver fornito una delle tre ricostruzioni dei fatti. Secondo i procuratori incaricati del caso è risultato perciò “difficile accertare quello che accadde realmente in quel periodo di tempo così critico [dopo il presunto stupro]”, tanto che essi stessi finirono per non avere più “alcuna fiducia circa la volontà dell’accusatrice di dire la verità nel caso fosse stata chiamata a testimoniare durante il processo”.
L’ammissione di responsabilità della procura di Manhattan non spiega in ogni caso i motivi per cui l’attendibilità dell’accusatrice e unica testimone del presunto stupro non sia stata verificata da subito con maggiore scrupolo. La donna, ad esempio, diede ben tre versioni differenti del suo comportamento dopo l’incontro nella suite di Strauss-Kahn, giungendo successivamente addirittura a negare di aver fornito una delle tre ricostruzioni dei fatti. Secondo i procuratori incaricati del caso è risultato perciò “difficile accertare quello che accadde realmente in quel periodo di tempo così critico [dopo il presunto stupro]”, tanto che essi stessi finirono per non avere più “alcuna fiducia circa la volontà dell’accusatrice di dire la verità nel caso fosse stata chiamata a testimoniare durante il processo”.
Ugualmente determinante per le sorti del procedimento è stato poi il racconto contraddittorio fatto dall’accusatrice sullo stupro di gruppo a cui sarebbe stata sottoposta in Guinea. Sotto pressione, la donna ha alla fine ammesso di aver mentito e di essersi inventata questo episodio in occasione della sua richiesta di asilo per entrare negli Stati Uniti. Per la procura è sembrato di “estrema rilevanza” il fatto che, “in un caso di stupro, l’accusatrice abbia fornito una testimonianza falsa su un differente caso di violenza sessuale”.
La donna, inoltre, avrebbe fornito numerose altre false dichiarazioni, tra cui la spiegazione di alcuni versamenti bancari pari a decine di migliaia di dollari fatti a suo beneficio da persone non meglio identificate in quattro stati diversi. Con il suo fidanzato, detenuto in Arizona per possesso di stupefacenti, infine, avrebbe discusso telefonicamente dei possibili benefici economici che le sarebbero derivati dalla vicenda del Sofitel, screditando definitivamente la sua posizione e facendo svanire la possibilità di istruire un processo fondato su solide basi.
Con l’archiviazione del caso, Dominique Strauss-Kahn ha ottenuto così la libertà di far ritorno in Francia, dove sarà chiamato a prendere una decisione su un eventuale ritorno sulla scena politica a poche settimane dalle primarie del Partito Socialista per le elezioni presidenziali del 2012. A New York, tuttavia, rimane aperto un procedimento civile nei suoi confronti avviato dalla stessa immigrata dalla Guinea, mentre proprio nel suo paese d’origine dovrà far fronte ad una nuova causa intentata dalla scrittrice Tristan Banon, la quale accusa DSK di tentato stupro nel corso di un’intervista – anche allora senza testimoni – concessa nel 2003.
