- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Con una comunicazione apparsa martedì sul sito web della Commmissione Centrale per le Ispezioni Disciplinari del Partito Comunista Cinese (PCC), il governo di Pechino ha annunciato in maniera ufficiale l’apertura di un’inchiesta ai danni del potente ex membro del Comitato Permanente del Politburo, Zhou Yongkang, sospettato di “gravi violazioni della disciplina”. Mai nei 65 anni di storia della Cina “comunista” un esponente così autorevole della classe dirigente era stato messo sotto accusa per reati di corruzione.
72 anni ancora da compiere, Zhou si era ritirato dalla politica attiva nel novembre del 2012 dopo una carriera che lo aveva visto raggiungere i vertici del governo. Tra il 1988 e il 1998 era stato vice-presidente e poi presidente del colosso pubblico petrolifero China National Petroleum Corporation (CNPC), per poi assumere incarichi prettamente politici in qualità di ministro delle Terre e delle Risorse e segretario del PCC nella provincia di Sichuan.
Nel 2002 Zhou era entrato per la prima volta nel Politburo del partito e nel 2007 nel Comitato Permanente di quest’ultimo, di fatto il più alto organo decisionale della Repubblica Popolare Cinese. Tra il 2007 e il 2012, Zhou aveva assunto infine la guida dell’intero apparato della sicurezza, con competenza sulle forze di polizia, i tribunali e i servizi segreti civili.
Secondo quanto riportato a dicembre dalla Reuters, Zhou era stato messo agli arresti domiciliari già sul finire dello scorso anno, a conferma delle voci che circolavano sul suo conto e dopo che dal 1° ottobre precedente non era più stato visto in pubblico.
La decisione presa con ogni probabilità direttamente dal presidente cinese, Xi Jinping, era seguita alla creazione di una speciale task force con l’incarico di indagare sulle accuse di corruzione nei suoi confronti. Sempre secondo la Reuters, poi, nel marzo di quest’anno le autorità avevano sequestrato beni per il valore di quasi 15 miliardi di dollari a vari membri della famiglia e della cerchia di potere di Zhou Yongkang.
Agli arresti sono finiti anche il figlio di quest’ultimo, Zhou Bin, nonché la moglie, Jia Xiaoye, e il fratello, Zhou Yuanqing. Il figlio, in particolare, svolgerebbe un ruolo centrale nell’indagine interna al partito e, secondo il New York Times, avrebbe recentemente testimoniato contro il padre.
Complessivamente, più di 300 persone vicine a Zhou negli ultimi mesi sono state arrestate o interrogate nell’ambito delle indagini. In un’escalation di incriminazioni e condanne che hanno fatto terra bruciata attorno a Zhou, numerose personalità di spicco vicine a quest’ultimo sono state vittime di vere e proprie purghe negli ultimi due anni.
Nel dicembre del 2012, ad esempio, il vice-segretario del partito nella provincia di Sichuan, Li Chuncheng, era stato il primo importante politico alleato di Zhou a essere oggetto di un’indagine nell’ambito della crociata anti-corruzione della leadership da poco installata. Il numero uno della commissione incaricata di amministrare e supervisionare le aziende pubbliche, Jiang Jiemin, finì invece sotto inchiesta nel settembre del 2013. Tre mesi più tardi sarebbe poi toccato a Li Dongsheng, vice-ministro per la pubblica sicurezza.
Il numero uno della commissione incaricata di amministrare e supervisionare le aziende pubbliche, Jiang Jiemin, finì invece sotto inchiesta nel settembre del 2013. Tre mesi più tardi sarebbe poi toccato a Li Dongsheng, vice-ministro per la pubblica sicurezza.
Fonti cinesi citate dalla stampa occidentale riferiscono che Xi intenderebbe punire Zhou per avere cercato di installare propri uomini ai vertici dello stato alla vigilia del 18esimo congresso del PCC nel novembre del 2012, in occasione del quale avvenne il decennale cambio della leadership cinese che portò al potere lo steso Xi.
In particolare, per mantenere la propria influenza all’interno dei supremi organi di governo e proteggere le ricchezze accumulate dal suo entourage, Zhou puntava tutto sul carismatico Bo Xilai, l’ex segretario del partito di Chongqing attualmente in carcere. Entrambi considerati fedelissimi dell’ex presidente Jiang Zemin, Zhou Yongkang e Bo Xilai hanno rappresentato o rappresentano uno dei principali ostacoli al consolidamento del potere di Xi Jinping e del primo ministro Li Keqiang.
Zhou e Bo, infatti, fanno parte di una fazione all’interno della classe dirigente cinese legata alle grandi compagnie pubbliche, in particolare del settore petrolifero, e che si oppone al processo di ulteriore ristrutturazione del sistema economico del paese in senso capitalistico.
L’agenda di libero mercato di Xi e Li, dietro indicazione degli ambienti finanziari internazionali, trova resistenze molto forti negli ambienti delle aziende di stato che potrebbero essere penalizzate dall’apertura di alcuni settori strategici. La condanna di Bo Xilai lo scorso anno per corruzione e abuso di potere e l’incriminazione - peraltro non ancora annunciata ufficialmente - di Zhou Yongkang rappresentano perciò il tentativo più clamoroso di rimuovere questi ostacoli.
Gli attacchi ai leader rivali del partito vengono portati con la scusa della lotta alla corruzione che ha rappresentato un altro dei capisaldi del programma di Xi Jinping al momento della sua ascesa alla guida del partito e del paese. Dal momento che la corruzione pervade praticamente tutti gli ingranaggi della Repubblica Popolare e che gli appartenenti all’élite “comunista” si sono arricchiti enormemente negli ultimi decenni con sistemi a dir poco discutibili, indagini o incriminazioni a causa di “violazioni” delle regole posso essere pilotate a piacere da chi controlla un sistema giudiziario tutt’altro che indipendente. L’annuncio dell’indagine aperta ai danni di Zhou indica dunque un certo progresso da parte del presidente Xi nel superamento delle resistenze e delle divisioni all’interno della leadership cinese circa la strada da percorrere nel prossimo futuro. Non a caso, infatti, sempre martedì è stato indetto per il mese di ottobre il quarto Plenum del Comitato Centrale del PCC, durante il quale verranno ad esempio avanzate proposte volte a “migliorare il clima per gli investimenti” e a “liberalizzare i settori industriali ancora dominati dai monopoli statali”.
L’annuncio dell’indagine aperta ai danni di Zhou indica dunque un certo progresso da parte del presidente Xi nel superamento delle resistenze e delle divisioni all’interno della leadership cinese circa la strada da percorrere nel prossimo futuro. Non a caso, infatti, sempre martedì è stato indetto per il mese di ottobre il quarto Plenum del Comitato Centrale del PCC, durante il quale verranno ad esempio avanzate proposte volte a “migliorare il clima per gli investimenti” e a “liberalizzare i settori industriali ancora dominati dai monopoli statali”.
Molti commentatori si sono chiesti fino a che punto arriveranno le purghe ordinate dal presidente Xi, visto che appare evidente il rischio di inasprire le rivalità all’interno di un sistema di potere basato sul consenso e tradizionalmente caratterizzato da fazioni che fanno capo, tra gli altri, ai leader che hanno abbandonato le loro cariche ufficiali nel partito e nel governo.
Secondo una rivelazione pubblicata mercoledì dalla Reuters e basata su fonti cinesi, tuttavia, Xi Jinping avrebbe ottenuto il consenso dei due suoi predecessori - Hu Jintao e Jiang Zemin - prima di ordinare l’apertura di un’indagine formale per corruzione contro Zhou Yongkang. Per la stessa agenzia di stampa, ciò suggerirebbe che l’indagine a un livello così alto “non provocherà spaccature nel Partito Comunista”, anche se è possibile che “l’élite inizi a innervosirsi per l’allargamento della campagna anti-corruzione del presidente”.
Xi, d’altra parte, con l’indagine ai danni di Zhou avrebbe violato una regola non scritta della classe dirigente cinese che prevedeva una sorta di immunità per i membri e gli ex membri del Comitato Permamente del Politburo, cioè la casta intoccabile della Repubblica Popolare.
In un commento alla notizia di martedì, il Quotidiano del Popolo ha comunque prospettato nuove incriminazioni, sostenendo che la lotta alla corruzione “non si fermerà” e che “la caduta di Zhou Yongkang… è solo un passo del processo in corso” inaugurato dal presidente Xi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
I toni della campagna di aggressione orchestrata dai governi occidentali nei confronti della Russia con la giustificazione della crisi ucraina sono aumentati sensibilmente questa settimana in seguito ad una serie di eventi appositamente studiati per mettere ancora maggiore pressione su Mosca. Oltre alle nuove sanzioni economiche decise dall’Unione Europea, sono giunte infatti un’aperta accusa da parte americana circa la violazione di un trattato missilistico risalente al periodo della Guerra Fredda e una sentenza di un tribunale internazionale sfavorevole al Cremlino nella vicenda dell’ex gigante petrolifero Yukos.
Martedì sono state quindi finalizzate le più dure sanzioni economiche contro Mosca finora approvate dai paesi europei. Mentre in precedenza erano stati colpiti solo singoli individui con misure relativamente modeste, il pacchetto appena deciso dovrebbe penalizzare interi settori dell’economia russa, in particolare quelli finanziario, militare ed energetico.
La decisione è stata presa nel corso di una videoconferenza tra il presidente americano Obama e i leader dei governi tedesco, francese, britannico e italiano. Una volta superate le resistenze della cancelliera Merkel a un’azione più incisiva contro la Russia, gli altri capi di governo hanno pateticamente acconsentito a una serie di iniziative che finiranno per pesare in maniera più o meno grave sulle economie dei loro stessi paesi.
Ben consapevoli dei danni che le nuove sanzioni potrebbero provocare, i governi UE hanno fissato alcune eccezioni. Tra di esse spicca l’esclusione dalle sanzioni delle importazioni di gas dalla Russia, così come dei contratti in essere per le forniture militari. Quest’ultima eccezione è stata richiesta in particolare dalla Francia, da mesi al centro delle pressioni di Washington e Londra per annullare la vendita a Mosca di due gigantesche navi da guerra Mistral commissionate da tempo.
La vastità delle nuove sanzioni europee, secondo i media, è tale che gli stessi Stati Uniti dovranno a loro volta inasprire le misure già adottate per stare al passo con quelle di Bruxelles.
Il livello di ipocrisia al limite dell’inverosimile dei governi occidentali nell’adottare le misure punitive contro la Russia è apparso evidente dalle parole del primo ministro britannico, David Cameron, il quale, dopo avere ammesso che le sanzioni avranno conseguenze negative anche sulle attività finanziarie della City di Londra, ha affermato che l’accelerazione è dovuta all’abbattimento quasi due settimane fa del volo Malaysia Airlines MH17 sui cieli dell’Ucraina orientale.
Individui come Cameron non hanno nemmeno la decenza di ricordare che le responsabilità di questo atto criminale sono ancora ben lontane dall’essere assegnate e che, anzi, vari indizi emersi in questi giorni indicano piuttosto un possibile coinvolgimento delle forze del regime golpista di Kiev nell’abbattimento del velivolo civile malese che ha fatto 298 vittime.
Dietro istruzione di Washington, d’altra parte, i lacchè europei degli americani continuano a ignorare le informazioni fornite sull’incidente aereo dalla Russia, da dove si continua anche a chiedere inutilmente di consentire un’indagine internazionale imparziale sulla sorte del volo MH17.
I governi occidentali continuano inoltre ad assicurare il pieno appoggo alla repressione messa in atto dall’Ucraina contro i ribelli filo-russi e la popolazione civile nelle provincie orientali del paese, costretta a fare i conti con un’aggressione guidata da forze neo-fasciste che questa settimana si è intensificata in maniera sensibile. Gli Stati Uniti e i loro alleati possono così vantare il sostegno contemporaneo a due operazioni belliche condotte da governi di estrema destra - come quelli di Ucraina e Israele - le cui vittime sono in larghissima misura civili. Il regime di Kiev continua poi a trasgredire a una recente risoluzione ONU che chiedeva l’accesso senza impedimenti al luogo del disastro aereo da parte degli investigatori internazionali, visto che in quest’area sta conducendo operazioni militari contro i ribelli e la popolazione.
Gli Stati Uniti e i loro alleati possono così vantare il sostegno contemporaneo a due operazioni belliche condotte da governi di estrema destra - come quelli di Ucraina e Israele - le cui vittime sono in larghissima misura civili. Il regime di Kiev continua poi a trasgredire a una recente risoluzione ONU che chiedeva l’accesso senza impedimenti al luogo del disastro aereo da parte degli investigatori internazionali, visto che in quest’area sta conducendo operazioni militari contro i ribelli e la popolazione.
Le nuove sanzioni, in ogni caso, dovrebbero servire per far cessare il presunto sostegno militare della Russia ai ribelli e prevenire un’improbabile invasione dell’Ucraina orientale sul modello dell’operazione in Crimea, anche se l’aggressione occidentale proseguirà indifferentemente dalle mosse del presidente Putin.
A sostegno delle proprie tesi, il Dipartimento di Stato americano domenica scorsa aveva mostrato alcune immagini satellitari di bassa qualità che avrebbero dovuto provare come le forze armate russe avessero colpito bersagli in territorio ucraino. Il Cremlino, da parte sua, ha respinto le accuse, citando piuttosto i numerosi sconfinamenti in territorio russo del fuoco ucraino nelle ultime settimane con conseguenze anche molto gravi, come conferma una vittima registrata nella città di Donetsk, in Russia.
Il cambio di marcia sulle sanzioni è comunque di grande rilievo, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento della Germania. Con il contributo di molti commentatori sui principali media, che da mesi vomitano retorica bellicista e puntano il dito contro le attitudini pacifiste della popolazione, il governo di Berlino ha valutato l’affermazione dei propri interessi strategici in un’area tradizionalmente di influenza russa di importanza superiore anche agli interessi economici immediati del capitale tedesco, fortemente legato al mercato russo.
Allo stesso modo, il rischio di compromettere le ingenti forniture di gas russo non ha alla fine impedito al governo della CDU/CSU e della SPD di allinearsi alle richieste degli Stati Uniti, per i quali la crisi ucraina - creata a tavolino dalle proprie ONG e dalle forze politiche filo-occidentali a Kiev - e ancora più l’abbattimento di un aereo civile rappresentano l’occasione per ostacolare il processo di integrazione economica euro-asiatica in cui la Germana svolge appunto un ruolo fondamentale.
La fissazione di Washington sulla Russia è determinata anche da altri fattori, dall’asilo concesso a Edward Snowden agli impedimenti posti da Mosca ad un intervento militare in Siria, ma soprattutto dalla nascita inevitabile di un blocco economico alternativo fatto di paesi “emergenti” che minaccia seriamente la declinante leadership americana nel pianeta.
In questa prospettiva, è significativo che l’intensificarsi delle pressioni sulla Russia - così come sulla Cina in Estremo Oriente - siano giunte in parallelo ad alcune importanti iniziative su scala globale indipendenti dagli Stati Uniti.
Tra quelle che devono avere occupato i pensieri degli strateghi di Washington impegnati a progettare la rivolta ucraina contro l’ex presidente Yanukovich e l’aggressione contro la Russia ci sono, ad esempio, la firma nel mese di maggio di un colossale accordo per la fornitura di gas tra Mosca e Pechino e il più recente summit dei cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) in Brasile. Durante quest’ultimo evento, è stata sancita la nascita di due istituzioni finanziarie globali potenzialmente in grado, sia pure nel lungo periodo, di mettere in discussione il dominio di quelle nate a Bretton Woods sotto l’egida americana.
La campagna occidentale contro la Russia è dunque ormai a tutto campo e non sembra più limitata alla sola questione ucraina. A conferma di ciò, all’inizio di questa settimana si sono registrati due veri e propri attacchi contro Mosca, curiosamente avvenuti nel momento di maggiore tensione tra la Russia e l’Occidente negli ultimi due decenni.
Come già anticipato, nel primo caso l’amministrazione Obama ha notificato lunedì al Cremlino quella che viene definita una violazione del Trattato sulle Forze Nucleari a Medio Raggio (I.N.F.) in seguito ad un test russo, avvenuto nel 2008, di un missile Cruise lanciato da terra che rientra in questa categoria.
I sospetti americani risalgono al 2011 e già nella primavera del 2013 il Dipartimento di Stato USA aveva avanzato l’ipotesi di dichiarare la Russia in violazione del trattato siglato da Reagan e Gorbachev nel 1987, dando seguito però alla minaccia solo ora nel pieno dello scontro sull’Ucraina.
Alla denuncia si è accompagnata la consueta retorica guerrafondaia dei vertici militari USA. Il comandante delle forze NATO, generale Philip Breedlove, ha infatti affermato che “la violazione [del trattato I.N.F.], se non risolta, richiederà una qualche risposta”. Tra le ipotesi già avanzate per reagire alla “violazione” russa c’è il dispiegamento di missili Cruise lanciabili da nave e da aereo, permessi dal trattato a differenza di quelli lanciabili da terra.
In maniera poco soprendente, anche in questo caso le accuse americane grondano ipocrisia, visto che lo scorso anno la Russia aveva puntato il dito contro gli Stati Uniti in seguito al progetto di installare in Romania il sistema missilistico Aegis, teoricamente utilizzabile per il lancio di missili Cruise proibiti dal trattato. Il secondo affondo di questa settimana contro la Russia è giunto infine da una sentenza della Corte Permanente di Arbitrato dell’Aia, in Olanda, sulla vicenda Yukos. Il verdetto del tribunale internazionale apparentemente indipendente ha imposto al governo russo di pagare circa 50 miliardi di dollari agli azionisti della defunta compagnia che fu dell’oligarca decaduto Mikhail Khodorkovsky.
Il secondo affondo di questa settimana contro la Russia è giunto infine da una sentenza della Corte Permanente di Arbitrato dell’Aia, in Olanda, sulla vicenda Yukos. Il verdetto del tribunale internazionale apparentemente indipendente ha imposto al governo russo di pagare circa 50 miliardi di dollari agli azionisti della defunta compagnia che fu dell’oligarca decaduto Mikhail Khodorkovsky.
La decisione, tutta politica, rappresenta uno schiaffo al presidente Putin, il quale nel 2003 sarebbe stato dietro all’arresto di Khodorkovsky - del quale temeva forse le ambizioni politiche - con le accuse di evasione fiscale e appropriazione indebita, confiscando la sua azienda petrolifera, successivamente acquistata dalla compagnia pubblica Rosneft a condizioni di favore durante il procedimento di bancarotta.
La dichiarazione da parte della Corte de L’Aia dell’illegalità dello smantellamento di Yukos è stata subito sfruttata dai media occidentali per mettere in imbarazzo un Cremlino già sotto assedio per l’Ucraina e in seguito all’accusa di avere violato il trattato sui missili.
La sentenza che assegna una qualche vittoria all’ex detenuto Khodorkovsky oscura tuttavia il fatto che quest’ultimo e molti altri oligarchi in Russia e nei paesi dell’ex blocco comunista erano entrati in possesso delle aziende pubbliche dell’URSS svendute - come appunto Yukos - con sistemi criminali e grazie a legami mafiosi con i vertici dei governi seguiti alla fine dell’impero sovietico.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La contesa in corso negli Stati Uniti attorno alla pubblicazione di un rapporto del Congresso sugli interrogatori con metodi di tortura condotti dalla CIA dopo l’11 settembre 2001 ha fatto registrare un nuovo capitolo qualche giorno fa, in seguito ad una significativa rivelazione pubblicata dal New York Times. Secondo quanto riportato dal giornale americano, cioè, ai creatori stessi del programma illegale di torture somministrate ai presunti responsabili di terrorismo è stata garantita dall’amministrazione Obama la possibilità di rivedere e censurare parti di un rapporto che vede essi stessi al centro delle indagini.
La vicenda descritta dal Times era iniziata nel mese di aprile, all’indomani del voto da parte della commissione del Senato per i Servizi Segreti che aveva ordinato la declassificazione di centinaia di pagine di un rapporto molto critico sulle detenzioni e gli interrogatori segreti della CIA, realizzato dalla stessa commissione. In quell’occasione, il direttore della CIA, John Brennan, aveva indetto una riunione nella sede di Langley, in Virginia, con alcuni dei massimi responsabili dei programmi illegali dell’agenzia in modo da organizzare una sorta di strategia difensiva.
Tra “le spie, tuttora in attività o in pensione, radunate attorno al tavolo”, secondo il Times, c’erano “J. Cofer Black, capo del centro per l’antiterrorismo ai tempi dell’11 settembre, l’agente sotto copertura che ricopre attualmente questo incarico e svariati altri ex agenti del servizio clandestino della CIA”. Soprattutto, collegato telefonicamente con la riunione, c’era anche il direttore dell’agenzia fino al 2004, George J. Tenet.
Quest’ultimo negli ultimi mesi è stato l’artefice di una strategia di relazioni pubbliche a favore della CIA, volta a rispondere alle accuse di molti senatori americani basate appunto sul rapporto di oltre seimila pagine sugli interrogatori e che dovrebbe essere in parte pubblicato a breve.
Rimandata in varie occasioni, la diffusione almeno della sintesi del contenuto del rapporto potrebbe avvenire ai primi di agosto e, secondo fonti che ne hanno avuto accesso, esso conterrebbe pesanti accuse contro la CIA sia per avere cercato di depistare le indagini del Senato sia in merito ai metodi di tortura utilizzati nel corso degli interrogatori e alla loro presunta efficacia.
Il ruolo avuto dall’ex direttore Tenet nei fatti che hanno portato alla prossima pubblicazione del documento rivela ulteriormente l’inquietante intreccio esistente tra il governo e l’apparato della sicurezza nazionale negli Stati Uniti, tanto più che il tutto è avvenuto con l’approvazione della Casa Bianca.
Come spiega il Times, i programmi di detenzione (rendition) e quelli relativi agli interrogatori sono stati infatti concepiti sotto la supervisione di Tenet e messi in atto da uomini e donne che egli stesso aveva installato ai vertici dell’agenzia. Ciononostante, oltre a coordinare i tentativi di screditare il rapporto del Senato, Tenet sarebbe stato costantemente informato dall’attuale direttore Brennan sul faticoso processo di declassificazione in corso. Brennan, d’altra parte, deve essere molto riconoscente al suo ex superiore, dal momento che grazie a Tenet aveva ottenuto il “prestigioso” incarico di capo della CIA in Arabia Saudita sul finire degli anni Novanta nonostante fosse un analista e non un agente clandestino sul campo. Brennan, inoltre, dopo il lavoro svolto a Riyadh sarebbe rientrato in patria per diventare capo di gabinetto di Tenet e in seguito vice-direttore esecutivo dell’agenzia.
Brennan, d’altra parte, deve essere molto riconoscente al suo ex superiore, dal momento che grazie a Tenet aveva ottenuto il “prestigioso” incarico di capo della CIA in Arabia Saudita sul finire degli anni Novanta nonostante fosse un analista e non un agente clandestino sul campo. Brennan, inoltre, dopo il lavoro svolto a Riyadh sarebbe rientrato in patria per diventare capo di gabinetto di Tenet e in seguito vice-direttore esecutivo dell’agenzia.
Tenet, in ogni caso, ha alla fine imbarcato altri due ex direttori della CIA - Porter Goss e Michael Hayden - e assieme hanno indirizzato una lettera a Brennan chiedendo ufficialmente di leggere il rapporto del Senato prima della sua pubblicazione, perché le “persone coinvolte nelle operazioni [di arresti illegali e torture] hanno il diritto di sapere ciò che viene affermato su di loro”.
L’iniziativa, chiaramente coordinata con lo stesso Brennan e con ogni probabilità con la Casa Bianca, è stata poi inoltrata all’organo nominalmente incaricato di controllare la CIA, vale a dire la commissione del Senato per i Servizi Segreti nella persona del suo presidente, la democratica Dianne Feinstein.
La senatrice della California ha allora acconsentito a mostrare il rapporto a Tenet e ai suoi compari a condizione però che il documento fosse letto nell’ufficio della commissione al Senato. Di fronte alle resistenze della CIA, il capo di gabinetto del presidente Obama, Denis McDonough, è intervenuto per mediare un accordo, ottenendo che gli ex direttori dell’agenzia e altri loro sottoposti avessero accesso ad una versione integrale del rapporto all’interno di una stanza negli uffici del direttore dell’Intelligence Nazionale.
In totale, una decina di ex agenti di altissimo livello della CIA avrebbero dovuto leggere il materiale relativo ai loro crimini ma, secondo quanto riportato dalla Associated Press, venerdì scorso ad alcuni di loro è stato revocato il permesso, tra cui John Rizzo, ex primo consulente legale dell’agenzia. La parziale marcia indietro sarebbe dovuta alle proteste della Feinstein e di altri senatori, i quali hanno accettato che soltanto agli ex direttori e vice-direttori della CIA fosse permesso di consultare la copia del rapporto.
La già imbarazzante concessione è aggravata dal fatto che da qualche tempo la Casa Bianca starebbe lavorando con i vertici della CIA al rapporto del Senato in vista della sua parziale pubblicazione. Una volta approvata la declassificazione della sintesi infatti, la commissione del Senato aveva inviato il rapporto al presidente Obama, il quale sta ora decidendo assieme ai responsabili dei crimini in esso descritti che cosa debba essere rivelato o tenuto nascosto agli americani.
La legittimità di un simile processo di revisione si deduce da un commento del New York Times, secondo il quale nella CIA operano ancora oggi numerosi agenti “che parteciparono al programma di detenzioni e agli interrogatori”, terminati ufficialmente dal presidente Obama all’inizio del 2009 appena dopo il suo ingresso alla Casa Bianca.
Nel corso della già citata riunione di aprile, l’attuale capo del centro per l’antiterrorismo della CIA informò il direttore Brennan che sotto la sua autorità ci sono ancora “circa 200 persone che hanno in qualche modo partecipato agli interrogatori”, torturando i detenuti.
Questa realtà la dice lunga sul ruolo svolto dall’amministrazione Obama nel proteggere torturatori e assassini all’interno dell’apparato dell’intelligence, poiché essi non solo non sono stati sottoposti a processo ma, in molti casi, non sono stati nemmeno rimossi dai loro incarichi. Coloro che hanno lasciato la CIA, anzi, hanno spesso trovato lucrosi impieghi nel settore privato, come lo stesso Tenet, diventato tra l’altro consulente di varie compagnie appaltatrici del governo. In questo quadro si inserisce anche la recente decisione del Dipartimento di Giustizia di non incriminare i vertici della CIA per avere messo sotto controllo i senatori della commissione per i Servizi Segreti e i membri dei loro staff. Ciò era accaduto dopo che questi ultimi erano entrati in possesso di un rapporto segreto della stessa CIA, commissionato dall’ex direttore Leon Panetta, nel quale venivano sostanzialmente riconosciute le durissime critiche nei confronti dell’agenzia espresse nelle conclusioni preliminari dell’indagine condotta dalla commissione del Senato. Pubblicamente, invece, i vertici della CIA avevano respinto seccamente le accuse del Congresso, sostenendo di avere agito nel pieno rispetto della legge.
In questo quadro si inserisce anche la recente decisione del Dipartimento di Giustizia di non incriminare i vertici della CIA per avere messo sotto controllo i senatori della commissione per i Servizi Segreti e i membri dei loro staff. Ciò era accaduto dopo che questi ultimi erano entrati in possesso di un rapporto segreto della stessa CIA, commissionato dall’ex direttore Leon Panetta, nel quale venivano sostanzialmente riconosciute le durissime critiche nei confronti dell’agenzia espresse nelle conclusioni preliminari dell’indagine condotta dalla commissione del Senato. Pubblicamente, invece, i vertici della CIA avevano respinto seccamente le accuse del Congresso, sostenendo di avere agito nel pieno rispetto della legge.
Questo episodio aveva provocato un attacco verbale contro la CIA con pochi precedenti da parte della senatrice Feinstein, la quale lo scorso marzo aveva accusato l’agenzia di avere violato il principio della separazione dei poteri, così come di avere contravvenuto al dettato del Quarto Emendamento della Costituzione - che proibisce perquisizioni e confische senza il mandato di un giudice - e dell’ordine esecutivo 12333 firmato da Reagan nel 1981 che, tra l’altro, proibisce alla CIA di condurre attività spionistiche e di sorveglianza sul territorio americano.
Succesivamente, i toni si sono però abbassati in maniera sensibile, soprattutto in seguito all’intervento della Casa Bianca che ha sostanzialmente difeso l’operato della CIA, fino a permettere ai responsabili delle torture di visionare e censurare documenti che dovrebbero rappresentare le prove dei loro stessi crimini.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
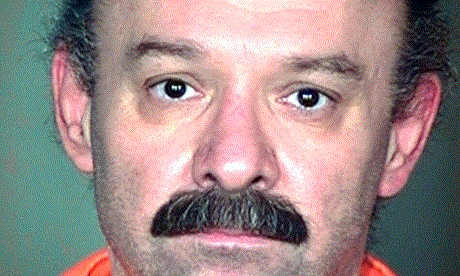 di Michele Paris
di Michele Paris
Il sistema penale statunitense responsabile delle esecuzioni capitali, continua a far registrare raccapriccianti episodi di condanne a morte che si risolvono in sofferenze atroci per i condannati, nonostante siano ormai ben noti i rischi che comportano le attuali modalità di somministrazione dell’iniezione letale. L’ultimo detenuto nel braccio della morte a essere giustiziato al termine di un angosciante procedimento di tortura è stato Joseph Rudolph Wood, condannato ventitré anni fa per gli omicidi della fidanzata e del padre di quest’ultima, avvenuti nel 1989 a Tucson, in Arizona.
Presso il penitenziario statale dell’Arizona a Florence, lo stesso Wood è stato ucciso nel primo pomeriggio di mercoledì dopo una serie di inutili appelli legali e al termine di una lunga agonia nella “camera della morte”.
Secondo il racconto dei fatti di un reporter della Associated Press che ha assistito all’esecuzione, il personale del carcere ha iniziato la procedura inserendo come di consueto un ago in entrambe le braccia del condannato. Dopo una decina di minuti dalla somministrazione delle sostanze letali, Wood ha iniziato a respirare affannosamente “con una frequenza di 5 / 12 secondi” e “per centinaia di volte”.
Le condizioni del condannato sono state controllate ripetutamente dal personale incaricato e uno degli addetti ha ad un certo punto aperto il microfono per comunicare agli spettatori nella stanza di fronte che Wood era ancora sedato, consentendo però ai presenti di sentire il suo ansimare.
La procedura è durata alla fine 117 minuti, durante i quali i legali di Wood hanno addirittura avuto il tempo di presentare (inutilmente) un appello di emergenza a un tribunale federale e alla Corte Suprema statale dell’Arizona per cercare di fermare l’esecuzione.
Dai documenti allegati alla richiesta risulta che il detenuto aveva mosso la bocca circa 6 minuti dopo essere stato dichiarato sedato dallo staff del carcere e che a 70 minuti dalla somministrazione dell’iniezione letale continuava a respirare in maniera pesante con ampi movimenti del torace.
Per una portavoce del procuratore generale dell’Arizona, Wood avrebbe soltanto “russato” durante l’esecuzione, a dimostrazione che era in uno stato di sonno profondo. L’avvocato di Wood, Dale Baich, ha tuttavia espresso più di un dubbio sul fatto che il suo assistito fosse incosciente, per poi sottolineare come una procedura durata quasi due ore, contro i pochi minuti solitamente necessari per giustiziare in questo modo i condannati, sia in ogni caso tutt’altro che normale.
Al termine dell’esecuzione, la Corte Suprema statale ha ordinato il sequestro delle quantità residue dei farmaci utilizzati, mentre l’ufficio del governatore ha chiesto al Dipartimento delle Carceri dell’Arizona di condurre un’indagine sull’accaduto. La governatrice, la repubblicana ultra-reazionaria Jan Brewer, ha però già chiarito quale sia la posizione dei vertici dello stato del sud-ovest degli Stati Unit, dichiarando che “di certo, il detenuto Wood è morto in maniera legale e, secondo i testimoni e lo staff medico, non ha sofferto”. La responsabilità di quanto è accaduto mercoledì nel carcere di Florence è da attribuire anche alla stessa governatrice dell’Arizona, ai tribunali dello Stato e alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Pur essendoci stati vari precedenti negli scorsi mesi di esecuzioni condotte in maniera disastrosa, le autorità legali e politiche con il potere quanto meno di sospendere la condanna hanno infatti deciso di lasciare procedere la macchina della morte.
La responsabilità di quanto è accaduto mercoledì nel carcere di Florence è da attribuire anche alla stessa governatrice dell’Arizona, ai tribunali dello Stato e alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Pur essendoci stati vari precedenti negli scorsi mesi di esecuzioni condotte in maniera disastrosa, le autorità legali e politiche con il potere quanto meno di sospendere la condanna hanno infatti deciso di lasciare procedere la macchina della morte.
Nel caso di Wood, sabato scorso la Corte d’Appello federale per il Nono Circuito con competenza sull’Arizona aveva accolto la richiesta dei legali del detenuto, emettendo un’ingiunzione per fermare il boia. Martedì, però, con un parere fatto appena di tre frasi, la Corte Suprema di Washington ha cancellato la sospensione dell’esecuzione, portata così a termine il giorno successivo.
L’appello di Wood era motivato dal rifiuto delle autorità penitenziarie dell’Arizona di rendere nota la provenienza delle sostanze utilizzate nella somministrazione dell’iniezione letale. Questo stato, prevede l’impiego di due farmaci - Midazolam e Idromorfone - simili a quelli utilizzati nell’esecuzione a gennaio in Ohio di Dennis McGuire, il quale prima di morire aveva evidenziato sintomi di soffocamento.
Ribaltando una sentenza di primo grado e prima dell’intervento decisivo della Corte Suprema USA, tre giudici della Corte d’Appello federale con una maggioranza di 2 a 1 avevano sospeso l’esecuzione di Joseph Wood fino a quando lo stato dell’Arizona, nel rispetto del Primo Emendamento della Costituzione americana, non avesse fornito informazioni sul reperimento delle sostanze letali.
Molti degli stati americani che ancora prevedono la pena di morte da qualche tempo hanno visto esaurirsi le scorte dei medicinali tradizionalmente usati nelle iniezioni letali e che avevano garantito una certa affidabilità delle procedure di morte. Ciò è dovuto allo stop delle forniture dai produttori europei proprio a causa dell’utilizzo delle sostanze in questione nelle esecuzioni capitali.
Le autorità statali hanno allora ripiegato su soluzioni alternative, impiegando mix di farmaci mai testati in precedenza, spesso reperiti presso fornitori non certificati, con il rischio concreto di infliggere sofferenze equiparabili a torture ai condannati a morte, in violazione dell’Ottavo Emendamento della Costituzione che proibisce punizioni “crudeli e inusuali”.
Per evitare fastidi e prevenire proteste o boicottaggi contro i nuovi fornitori, gli stessi stati hanno approvato svariate leggi volte a tenere segreta la provenienza dei nuovi farmaci, innescando però una valanga di cause legali.
In un sistema legale brutale e vendicativo come quello degli Stati Uniti, i rischi di infliggere vere e proprie torture ai detenuti nell’esecuzione della più barbara delle punizioni non hanno minimamente toccato la gran parte dei politici e dei giudici. Tanto è vero che nel solo 2014 gli episodi raccapriccianti sono stati numerosi.
Il caso più grave finora registrato è stato forse quello di Clayton Lockett, morto in aprile in un carcere dell’Oklahoma in seguito ad arresto cardiaco dopo 43 minuti trascorsi nel tragico tentativo di somministrargli sostanze di più che dubbia efficacia. Negli ultimi sette anni vari stati americani hanno abolito la pena di morte (New Jersey e New York nel 2007; New Mexico nel 2009; Illinois nel 2011; Connecticut nel 2012; Maryland nel 2013), mentre la percentuale della popolazione favorevole alle esecuzioni capitali è in continua discesa, se non altro per i costi legali che comporta e la percentuale non trascurabile di errori giudiziari. Inoltre, settimana scorsa un tribunale federale aveva giudicato incostituzionale il sistema della pena di morte nello stato della California a causa delle sue evidenti inefficienze.
Negli ultimi sette anni vari stati americani hanno abolito la pena di morte (New Jersey e New York nel 2007; New Mexico nel 2009; Illinois nel 2011; Connecticut nel 2012; Maryland nel 2013), mentre la percentuale della popolazione favorevole alle esecuzioni capitali è in continua discesa, se non altro per i costi legali che comporta e la percentuale non trascurabile di errori giudiziari. Inoltre, settimana scorsa un tribunale federale aveva giudicato incostituzionale il sistema della pena di morte nello stato della California a causa delle sue evidenti inefficienze.
Ciononostante, la classe dirigente americana continua in buona parte a promuovere la pena capitale, coerentemente con la realtà di un sistema giudiziario repressivo e violento nella cui rete cadono in grandissima parte gli appartenenti alle classi sociali più svantaggiate.
Gli esempi della spietatezza del sistema penale d’oltreoceano sono evidenti quasi ogni giorno, come confermano le recenti rivelazioni sui maltrattamenti e le violenze somministrate regolarmente dai secondini ai detenuti, spesso malati mentali, nel famigerato carcere di Rikers Island a New York oppure l’esecuzione senza pietà in Missouri di John Middleton. Quest’ultimo è stato giustiziato la settimana scorsa senza tenere conto delle evidenti prove del suo ritardo mentale che, secondo la stessa Corte Suprema degli Stati Uniti, dovrebbe escludere categoricamente l’emissione di una sentenza capitale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La commissione elettorale dell’Indonesia ha finalmente messo fine a settimane di incertezze e scambi di accuse reciproche tra i due candidati alla guida del paese, assegnando la vittoria nelle elezioni presidenziali del 9 luglio scorso all’ex governatore di Jakarta, Joko “Jokowi” Widodo. Il nuovo leader del più popoloso paese musulmano del pianeta ha superato l’ex generale durante la dittatura di Suharto, Prabowo Subianto, facendo trarre un sospiro di sollievo agli Stati Uniti e alla comunità internazionale degli affari.
Al termine di un laborioso spoglio di oltre 133 milioni di schede provenienti da quasi mezzo milione di seggi elettorali, “Jokowi” ha ottenuto poco più del 53% dei consensi contro quasi il 47% del suo unico rivale. A scegliere il primo sono stati quasi 71 milioni di elettori, mentre al secondo sono andati 62,5 milioni di suffragi. Considerevole è stato il livello di astensionismo, stimato attorno al 30%.
Di fronte agli elettori indonesiani si sono presentati solo due candidati per la carica di presidente a causa dell’anti-democratica legge elettorale che consente solo ai partiti o alle coalizioni che detengono almeno il 20% dei seggi o hanno raccolto il 25% del voto popolare nelle elezioni legislative di presentare un proprio candidato. Nel voto per il rinnovo del parlamento nel mese di aprile, nessun partito aveva superato questa soglia, così che “Jokowi” e Prabowo sono stati candidati solo dopo la formazione di due nuove alleanze ad hoc.
Joko Widodo succederà così nel mese di ottobre al presidente uscente Susilo Bambang Yudhoyono, il quale ha esaurito il limite massimo di due mandati previsto dalla Costituzione indonesiana. “Jokowi” è anche il primo dei cinque presidenti dell’era democratica in Indonesia a non avere ricoperto un qualche incarico ufficiale durante la dittatura di Suharto (1967-1998).
Pressoché sconosciuto alla gran parte degli indonesiani fino a pochi anni fa, il 53enne “Jokowi” aveva iniziato la sua carriera pubblica come sindaco della piccola città di Solo, nella provincia di Java centrale, ed è stato proiettato ai vertici della politica del suo paese grazie ai legami con i pezzi grossi del Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDI-P) della ex presidente Megawati Sukarnoputri, i quali hanno accuratamente promosso la sua immagine di politico pragmatico e di “uomo del popolo”.
L’annuncio dei risultati ufficiali non ha comunque chiuso l’accesa disputa in corso tra i due candidati, iniziata all’indomani del voto con la pubblicazione degli exit poll che avevano in gran parte indicato la vittoria di “Jokowi”. Prabowo aveva a sua volta citato un paio di istituti di ricerca che assegnavano invece a egli stesso la maggioranza dei consensi e si era perciò lanciato in pesanti accuse di brogli.
A poche ore dalla comunicazione dei risultati da parte della commissione elettorale nella giornata di martedì, Prabowo aveva addirittura minacciato di ritirare la propria candidatura per impedire l’annuncio del successo del suo avversario. Poco più tardi, l’ex generale diventato imprenditore ha fatto rientrare la minaccia ma ha comunque ritirato i suoi osservatori al conteggio e il suo staff ha fatto sapere di volere presentare un appello alla Corte Costituzionale sulla base di irregolarità riguardanti fino a 21 milioni di voti espressi in 52 mila seggi elettorali. La Corte avrà tempo fino alla metà di agosto per pronunciarsi ma la denuncia, secondo gli esperti, ha ben poche possibilità di andare a buon fine. Dietro alla candidatura di Prabowo ci sono in particolare quelle sezioni delle élite indonesiane che si sono arricchite durante la dittatura e continuano a mantenere posizioni di rilievo nel paese del sud-est asiatico. Lo stesso Prabowo, il quale era il genero di Suharto, e il fratello, Hasim Djojohadikusumo, sono alla guida di gruppi imprenditoriali che operano in svariati settori con giri d’affari miliardari.
Dietro alla candidatura di Prabowo ci sono in particolare quelle sezioni delle élite indonesiane che si sono arricchite durante la dittatura e continuano a mantenere posizioni di rilievo nel paese del sud-est asiatico. Lo stesso Prabowo, il quale era il genero di Suharto, e il fratello, Hasim Djojohadikusumo, sono alla guida di gruppi imprenditoriali che operano in svariati settori con giri d’affari miliardari.
La combattività mostrata da Prabowo fin dalle elezioni di inizio luglio è dovuta anche all’assottigliarsi del vantaggio di “Jokowi” nelle settimane che avevano preceduto il voto. Fino al mese di maggio, infatti, i sondaggi indicavano per quest’ultimo un vantaggio superiore ai 12 punti percentuali ma, grazie anche alle maggiori risorse finanziarie di Prabowo e all’appoggio di molte importanti personalità politiche ottenuto dall’ex generale, tra cui quello del presidente uscente Yudhoyono, la corsa aveva finito per diventare una sorta di testa a testa.
A favore della candidatura di “Jokowi” era intervenuto anche il governo americano nonostante la neutralità ufficiale dichiarata dall’amministrazione Obama. Proprio in concomitanza con la pubblicazione di sondaggi preoccupanti per “Jokowi”, l’ambasciatore USA a Jakarta, Robert Blake, in un articolo del Wall Street Journal a fine giugno aveva invitato l’establishment indonesiano a indagare sulle sospette violazioni dei diritti umani commesse in passato da Prabowo.
L’insolito intervento americano era scaturito dall’apparizione, tramite lo staff di “Jokowi”, di documenti relativi ai presunti crimini di Prabowo, da tempo peraltro accusato di essere responsabile di rapimenti e torture di studenti e oppositori di Suharto in qualità di capo delle famigerate forze speciali Kopassus.
La denuncia sui generis degli Stati Uniti era giunta non tanto per ragioni di giustizia o per scrupoli particolari per i diritti umani della popolazione indonesiana ma per motivi esclusivamente di natura strategica. D’altra parte, anche nella squadra di “Jokowi” ci sono molte figure compromesse col vecchio regime, tra cui l’ex generale ed ex candidato alla presidenza Wiranto, incriminato formalmente per crimini contro l’umanità nell’ambito delle atrocità commesse dall’esercito durante il ritiro da Timor Est nel 1999.
Washington, inoltre, ha alle spalle una lunga storia di interventi in Indonesia, a cominciare proprio dall’appoggio al colpo di stato militare di Suharto che portò alla dittatura e a una durissima repressione con centinaia di migliaia di morti.
In particolare, l’amministrazione Obama temeva una presidenza Prabowo per via del marcato nazionalismo dell’ex generale, considerato con ogni probabilità non sufficientemente propenso ad aprire ulteriormente il proprio paese al capitale internazionale, né ad adottare le “riforme” economiche ritenute necessarie e soprattutto, vista l’importanza strategica di questo paese, ad allineare senza riserve l’Indonesia alla “svolta” asiatica statunitense per contrastare l’avanzata della Cina.
Il programma elettorale di Prabowo includeva infatti alcune proposte di stampo populista, come la creazione di un sistema scolastico gratuito fino all’università e un aumento sensibile del salario minimo. Lo stesso Prabowo, poi, in una recente intervista sempre al Wall Street Journal, oltre a condannare l’aggressione di Israele contro Gaza, aveva messo in guardia i suoi connazionali dalla “minaccia imperialista” che graverebbe sull’Indonesia.
Al contrario, Joko Widodo, viene ritenuto un partner più affidabile sia dagli Stati Uniti che dagli ambienti finanziari internazionali e dalle grandi multinazionali del settore estrattivo che fanno profitti in Indonesia. Come ha rivelato in un’intervista realizzata per la Reuters prima della diffusione dei risultati finali del voto ma pubblicata solo dopo l’ufficialità della sua vittoria, il neo-presidente indonesiano si concentrerà da subito su una serie di questioni che difficilmente possono essere collegate all’immagine di “uomo comune” coltivata in campagna elettorale o alla promessa di alleviare gli esorbitanti livelli di povertà del suo paese. Per cominciare, “Jokowi” si è detto disposto a negoziare con le compagnie estrattive per porre fine allo stallo seguito al divieto, deciso dall’amministrazione Yudhoyono a gennaio, di esportare minerali non processati nel tentativo di stimolare la creazione di impianti di trasformazione in Indonesia.
Per cominciare, “Jokowi” si è detto disposto a negoziare con le compagnie estrattive per porre fine allo stallo seguito al divieto, deciso dall’amministrazione Yudhoyono a gennaio, di esportare minerali non processati nel tentativo di stimolare la creazione di impianti di trasformazione in Indonesia.
L’Indonesia è uno dei maggiori esportatori del pianeta di nickel, rame, bauxite e minerali ferrosi che producono profitti enormi per una manciata di multinazionali, soprattuto americane. Una di queste, la Newmont Mining, ha recentemente fatto appello all’arbitrato internazionale contro il governo di Jakarta a causa del divieto di esportazione, licenziando migliaia di dipendenti e mantenendo chiusa una miniera di cui detiene i diritti di sfruttamento.
Gli altri due punti all’ordine del giorno del prossimo governo saranno poi la riduzione dei sussidi pubblici ai prezzi dei carburanti e, come indicato nell’elenco delle “sfide immediate” stilato mercoledì dal Financial Times, il “miglioramento del clima per gli investitori”.
La fine dei sussidi che alleggeriscono parzialmente i conti delle famiglie più povere nei paesi “emergenti” sono ormai da tempo nel mirino delle rispettive classi dirigenti e degli organi finanziari internazionali come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale. In Indonesia, questa voce di spesa ammonta a un quinto del bilancio dello stato e viene considerata uno spreco inutile di denaro dalle élite economiche e finanziarie. Sia Yudhoyono che Megawati, presidente dal 2001 al 2004, avevano in passato provato a tagliare i sussidi, scatenando però proteste popolari tra le classi più disagiate.
La creazione di un ambiente più favorevole all’afflusso di capitale straniero, infine, non rappresenta altro che una liquidazione delle regolamentazioni e dei vincoli che limitano l’ingresso degli investitori in Indonesia.
Queste e altre decisioni “difficili” metteranno subito alla prova il nuovo presidente, almeno secondo i commenti dei media ufficiali, visto che la crescita economica indonesiana continua ad essere aggiustata al ribasso e le compagnie internazionali alla ricerca di manodopera a bassissimo costo da sfruttare liberamente mostrano di preferire altre destinazioni in Asia sud-orientale.
Inevitabilmente, politiche simili provocheranno però un intensificarsi delle tensioni sociali e dovranno inoltre essere implementate in un panorama politico frammentato e senza una chiara maggioranza. Il PDI-P di “Jokowi”, infatti, fa parte di una coalizione con altri tre partiti che in parlamento controlla complessivamente appena il 37% dei seggi.
Joko Widodo, tuttavia, potrebbe presto mettere assieme una maggioranza per il suo governo, visto che all’interno del partito Golkar - già strumento politico della dittatura di Suharto e, singolarmente, partito del neo-vicepresidente Jusuf Kalla - in molti stanno manifestando il desiderio di saltare sul carro del vincitore dopo avere appoggiato in campagna elettorale la candidatura di Prabowo Subianto.
