- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Con una vittoria a valanga nelle elezioni di domenica scorsa, il principale partito di opposizione in Thailandia ha conquistato la maggioranza assoluta nel Parlamento di Bangkok. Il voto anticipato chiude una tormentatissima fase politica nel paese del sud-est asiatico e conferma l’ampiezza di consensi su cui può tuttora contare il popolare ex-premier in esilio Thaksin Shinawatra, la cui sorella minore, Yingluck, sarà chiamata a guidare il nuovo governo in un prossimo futuro che si annuncia pieno di incertezze.
Secondo i dati ufficiali, il partito di opposizione Pheu Thai si è assicurato 265 dei 500 seggi che compongono la Camera bassa del Parlamento thailandese. Nonostante la possibilità di formare un nuovo gabinetto in tutta autonomia, il primo ministro in pectore ha annunciato lunedì la sua intenzione di dar vita ad una coalizione di governo assieme ad altri quattro partiti minori.
Oltre a rafforzare una compagine governativa che dovrà affrontare sfide e resistenze durissime, la mossa di Yingluck Shinawatra è stata suggerita probabilmente dalla dichiarazione ufficiale della commissione elettorale tailandese poche ore dopo il voto. La commissione, infatti, ha rivelato di aver avviato indagini su possibili brogli che potrebbero portare all’esclusione di alcuni candidati del partito uscito vincitore dalle urne e ridurne così i seggi conquistati. I risultati definitivi saranno comunque resi noti tra non meno di un mese.
Il grande sconfitto dell’elezione di domenica è invece il Partito Democratico del premier in carica, Abhisit Vejjajiva, capace di ottenere appena 159 seggi. In seguito alla batosta elettorale, Abhisit ha presentato le proprie dimissioni da leader di un partito tradizionalmente espressione dell’establishment militare, della casa reale e della borghesia urbana.
A installare la 44enne imprenditrice senza precedenti esperienze politiche - Yingluck Shinawatra - al vertice del partito Pheu Thai, era stato il fratello ex premier, che da qualche anno vive a Dubai per sfuggire ai procedimenti legali intentati nei suoi confronti in Tailandia. Thaksin Shinawatra era stato rimosso dal potere con un colpo di stato militare, approvato tacitamente da Washington, nel settembre del 2006, in seguito al quale è stato appunto messo sotto accusa per abuso di potere e corruzione.
Leader populista e businessman miliardario nel settore delle telecomunicazioni, Thaksin aveva trionfato nelle elezioni del 2001 e del 2005. Il suo successo era dovuto principalmente alla promessa di ribaltare le politiche di rigore imposte dalle istituzioni finanziarie internazionali dopo la crisi che aveva colpito l’Asia sud-orientale tra il 1997 e il 1998.
 Grazie a programmi sociali relativamente generosi, sussidi ai contadini e la garanzia di un’assistenza sanitaria gratuita, Thaksin si era assicurato il sostegno dei ceti più poveri nelle città e nelle regioni rurali tailandesi. La sua azione politica - condotta in maniera sempre più autoritaria - aveva suscitato la dura reazione dei tradizionali centri di potere del paese, costituiti dall’apparato militare, dalla casa regnante e dalle classi più agiate della capitale.
Grazie a programmi sociali relativamente generosi, sussidi ai contadini e la garanzia di un’assistenza sanitaria gratuita, Thaksin si era assicurato il sostegno dei ceti più poveri nelle città e nelle regioni rurali tailandesi. La sua azione politica - condotta in maniera sempre più autoritaria - aveva suscitato la dura reazione dei tradizionali centri di potere del paese, costituiti dall’apparato militare, dalla casa regnante e dalle classi più agiate della capitale.
Dopo il golpe, dunque, le nuove elezioni del 2007 avevano ancora una volta consegnato la maggioranza ai sostenitori di Thaksin. I due successivi primi ministri furono però deposti da altrettante sentenze giudiziarie politicizzate, così come due decisioni della Corte Costituzionale tailandese dissolsero per frode elettorale i partiti facenti capo all’ex premier - Thai Rak Thai (TRT) e Partito del Potere Popolare (PPP) - rispettivamente nel maggio del 2007 e nel dicembre dell’anno successivo.
Sempre nel 2008, in seguito alle manovre dei poteri forti del paese, venne così installato alla guida del governo Abhisit Vejjajiva del Partito Democratico. La sua ascesa fu resa possibile solo dal sostegno ottenuto in Parlamento di un certo numero di deputati usciti dal partito di Thaksin, oggetto delle pressioni dei militari e degli ambienti reali.
I metodi profondamente anti-democratici con cui venne manipolato il quadro politico della Thailandia fu alla base dell’esplosione delle proteste di piazza delle cosiddette “camicie rosse”, raggruppate nel “Fronte Unito per la Democrazia contro la Dittatura” (UDD). Nella primavera del 2010, i manifesti, provenienti in gran parte dalle aree rurali del nord del paese, bloccarono per settimane il centro di Bangkok, chiedendo le dimissioni del governo e le elezioni anticipate. La risposta del premier e delle forze di sicurezza fu però molto dura e si risolse in una repressione che causò oltre novanta morti.
Le persistenti richieste delle “camicie rosse”, come ha confermato il voto dell’altro giorno, riflettono i cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio all’interno della società tailandese, dove ampi strati della popolazione non sono ormai più disposti a rimanere esclusi da un sistema di potere fondato su una ristretta élite. Un’evoluzione, questa, favorita dalle politiche implementate dallo stesso Thaksin Shinawatra durante gli anni di governo e che la sorella Yingluck, prossimo primo premier donna nella storia del paese, sarà chiamata ad incanalare tra mille difficoltà verso un futuro privo di conflitti.
La sfida per la neo-premier sarà la riconciliazione con le forze armate, così da evitare un nuovo colpo di stato. Le voci di un possibile ribaltamento dell’esito del voto da parte dei militari si erano inseguite alla vigilia delle elezioni, anche se la chiarissima vittoria del partito Pheu Thai e la maggioranza assoluta conquistata in Parlamento renderanno ora più difficile un colpo di mano dell’esercito. Per smorzare i toni, in ogni caso, Yingluck Shinawatra aveva già provveduto ad escludere dal proprio programma qualsiasi provvedimento di amnistia per il fratello in caso di successo.
 Secondo la testata on-line Asia Times, inoltre, rappresentanti della casa reale e delle forze armate avevano già trovato un accordo con gli emissari di Thaksin per un’evoluzione pacifica del dopo voto. Fiutando una sconfitta del Partito Democratico del premier Abhisit, i militari avrebbero offerto a Yingluck Shinawatra la possibilità di formare il governo senza ostacoli, in cambio della rinuncia a perseguire i responsabili della repressione delle proteste dello scorso anno.
Secondo la testata on-line Asia Times, inoltre, rappresentanti della casa reale e delle forze armate avevano già trovato un accordo con gli emissari di Thaksin per un’evoluzione pacifica del dopo voto. Fiutando una sconfitta del Partito Democratico del premier Abhisit, i militari avrebbero offerto a Yingluck Shinawatra la possibilità di formare il governo senza ostacoli, in cambio della rinuncia a perseguire i responsabili della repressione delle proteste dello scorso anno.
Thaksin, secondo l’ipotetico patto, dovrebbe impegnarsi anche a non intervenire nell’annuale rimpasto dei vertici dell’esercito e a tenere sotto controllo l’agguerrita fazione anti-monarchica delle “camicie rosse”. Forse proprio a conferma dell’intesa raggiunta, il ministro della Difesa uscente ha confermato pubblicamente lunedì che l’esercito non interverrà per modificare il risultato delle elezioni.
Al di là degli immediati sviluppi, appare difficile che il voto di domenica possa risolvere a breve le contraddizioni della società tailandese e i profondi conflitti che la attraversano. Thaksin, oltretutto, rimane una figura molto controversa nel Paese e le sue dichiarazioni appassionate dall’esilio subito dopo il successo del partito Pheu Thai confermano che sarà in sostanza la sua mano a manovrare l’azione di governo della sorella premier.
A complicare le cose c’è infine la possibile destabilizzazione causata dalla crescente rivalità sino-americana in Asia sud-orientale, soprattutto alla luce del rinnovato interventismo dell’amministrazione Obama in questa parte del globo. La Thailandia è uno storico alleato degli Stati Uniti ma, come altri paesi in quest’area, negli ultimi anni ha intensificato le relazioni con Pechino, in particolare in ambito commerciale.
Lo stesso ex premier Thaksin aveva cercato di bilanciare i rapporti tra le due potenze, appoggiando, da un lato, la guerra al terrore post-11 settembre dell’amministrazione Bush e, dall’altro, favorendo gli investimenti cinesi in Thailandia e allargando la cooperazione militare con il potente vicino settentrionale. Un equilibrismo interrotto dal colpo di stato che lo depose cinque anni fa ma che ha continuato a caratterizzare i governi che si sono succeduti da allora e con cui anche il nuovo esecutivo dovrà ben presto fare i conti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Nel cuore dell'Europa unita, quello che una volta era un grande Paese sta scivolando verso l'autoritarismo. A Bruxelles si coprono gli occhi con entrambe le mani pur di non vedere. Ma siccome a volte la storia ha il senso dell'umorismo, il destino ha voluto che questo momento nero per l'Ungheria coincidesse con il suo turno di presidenza dell'Unione europea. Risultato: a presiedere il Parlamento comunitario (fortunatamente ancora per poco) c'è un losco figuro che ha esplicitamente dichiarato di fronte all'assemblea continentale di "non credere nell'Unione, ma soltanto nell'Ungheria".
Il suo nome è Viktor Orban, primo ministro di Budapest. Un anno fa il suo partito (Fidesz) ha stravinto le elezioni, riuscendo ad occupare i due terzi del Parlamento. Da allora la presa di potere è stata inesorabile e priva di qualsiasi senso del pudore.
L'ultima trovata di Viktor ha a che fare con una retriva campagna contro l'aborto. Le strade ungheresi sono tappezzate di cartelloni con l'immagine di un feto che implora pietà alla donna che lo porta in grembo: "Posso anche capire che non sei pronta per me, ma pensaci due volte, fammi adottare, fammi vivere".
L'aspetto vergognoso è che questo scempio è stato realizzato in parte con fondi comunitari. Di fronte a questo "abuso incompatibile con i valore dell'Ue", il commissario europeo alla Giustizia, Viviane Reding, è stata costretta ad aprir bocca e a chiedere l'immediato ritiro dei cartelli. Se gli ungheresi non dovessero obbedire, potrebbero scattare sanzioni pari a quelle che si usano in casi di guerra o di crimini contro l'umanità.
 Peccato che l'indignazione di Bruxelles arrivi con colpevole ritardo, per di più legata a quella che è forse la meno grave (ma sicuramente la più mediatica) delle aberrazioni ungheresi.
Peccato che l'indignazione di Bruxelles arrivi con colpevole ritardo, per di più legata a quella che è forse la meno grave (ma sicuramente la più mediatica) delle aberrazioni ungheresi.
Nei mesi precedenti l'Esecutivo di Budapest aveva già fatto abbastanza guai da meritarsi le sanzioni più pesanti che l'Ue possa infliggere a uno stato membro. Su tutti la riscrittura completa della Costituzione da parte del solo partito di maggioranza. Il nuovo testo - che entrerà in vigore dal 2012 - è l'apoteosi del trionfalismo nazionalista, xenofobo e totalitario: il vago sapore nazistoide è decisamente intercettabile, volendo vedere e ascoltare.
Lo Stato non è più definito nei termini di una repubblica, ma di una nazione politica con radici etniche e cristiane. Dio e l'appartenenza alla razza magiara sono i valori fondamentali, mentre i diritti delle minoranze non vengono nemmeno presi in considerazione. In alcuni passaggi s’intravede perfino la rivendicazione dei territori sottratti al Paese dopo la prima guerra mondiale, oggi divisi fra Serbia, Romania, Croazia e Slovacchia.
Come se non bastasse, il principio della separazione dei poteri è spazzato via: l'Esecutivo allarga le sue competenze in materia sociale e fiscale, mentre l'elezione di una serie di cariche istituzionali finora indipendenti (i membri della Corte Costituzionale, il presidente della Corte di Cassazione, il procuratore capo, etc.) viene subordinata alla nomina governativa. Le cariche, per di più, hanno una durata molto più lunga che in passato, in modo da permettere agli uomini di Orban di occupare il potere anche in caso di sconfitta alle prossime elezioni.
 Ma nessun autoritarismo può dirsi tale finché non controlla l'informazione. Viktor lo sa. Per questo ha nazionalizzato una sfilza di testate e ha istituito una commissione speciale (nemmeno a dirlo, di nomina politica) per controllare e punire con multe fino a 89mila euro gli articoli "politicamente non equilibrati". I giornalisti, inoltre, sono obbligati a rivelare le proprie fonti se non vogliono essere perseguiti a livello penale.
Ma nessun autoritarismo può dirsi tale finché non controlla l'informazione. Viktor lo sa. Per questo ha nazionalizzato una sfilza di testate e ha istituito una commissione speciale (nemmeno a dirlo, di nomina politica) per controllare e punire con multe fino a 89mila euro gli articoli "politicamente non equilibrati". I giornalisti, inoltre, sono obbligati a rivelare le proprie fonti se non vogliono essere perseguiti a livello penale.
La ciliegina sulla torta è la Mti, una nuova agenzia stampa finanziata dallo Stato che prenderà il posto di tutte le vecchie agenzie private, costrette a chiudere i battenti. Questi per sommi capi i principi di quella che da noi è conosciuta come "la legge bavaglio ungherese". Votata lo scorso dicembre, dal primo luglio è entrata in vigore.
Purtroppo nulla di tutto questo sembra sufficiente a smuovere Bruxelles dal suo torpore. Le uniche parole pronunciate negli ultimi mesi non hanno fatto altro che esprimere una blanda, ipocrita "preoccupazione". Nel frattempo, l'Ungheria continua a violare sistematicamente i principi cardine su cui l'Ue è stata fondata perché sa di poterlo fare. In questo momento nessuno ha interesse a inimicarsi Budapest.
Nonostante tutto, il Paese magiaro resta una piazza economica su cui indirizzare quote interessanti di esportazioni e le stesse banche, Unicredit in particolare, sono seriamente esposte in Ungheria. In un momento del genere, devono aver pensato a Bruxelles, non ci si può rinunciare, nemmeno in nome della democrazia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Se il Congresso di Washington non riuscirà a trovare un accordo entro il prossimo 2 agosto per alzare il tetto massimo del debito americano, per la prima volta nella sua storia il governo federale potrebbe ritrovarsi senza denaro per far fronte alle proprie scadenze. Le negoziazioni tra il Partito Democratico e quello Repubblicano stanno tuttavia procedendo tra molte difficoltà, con il presidente Obama che questa settimana assumerà in prima persona il comando delle trattative per giungere ad un accordo che, con ogni probabilità, finirà per far pagare le conseguenze del gigantesco debito statunitense alle classi più disagiate.
Il governo americano non è più in grado di raccogliere denaro già dallo scorso mese di maggio, quando è stato toccato il tetto massimo per il deficit federale di 14 mila e 300 miliardi di dollari. Come ha avvertito il Segretario al Tesoro, Tim Geithner, senza un intervento legislativo per innalzare tale limite, a breve gli Stati Uniti potrebbero addirittura rischiare il default, scatenando una nuova crisi finanziaria su scala planetaria.
Già all’attacco da tempo per la situazione insostenibile del debito pubblico americano - causato peraltro in gran parte da due costosissime guerre e da onerosi tagli alle tasse per i ricchi messi in atto durante l’amministrazione Bush - i repubblicani al Congresso hanno preso la palla al balzo per proseguire la loro campagna di drastica riduzione della spesa federale. Il Partito Repubblicano acconsentirà così ad un nuovo innalzamento del debito solo ottenendo in cambio dai democratici ulteriori nuovi tagli alla spesa pubblica.
Per trovare un punto d’incontro tra i due partiti, da qualche settimana sono in corso discussioni sotto la guida del vicepresidente, Joe Biden. Qualche giorno fa, però, le trattative sono saltate in seguito all’abbandono del tavolo da parte dei due delegati repubblicani, il deputato della Virginia Eric Cantor, leader di maggioranza alla Camera, e il senatore dell’Arizona Jon Kyl. Il motivo che ha portato a questa conclusione sarebbe l’ostinazione dei democratici di voler includere nel compromesso per ridurre il deficit un qualche amento delle tasse per le corporation e i redditi più elevati.
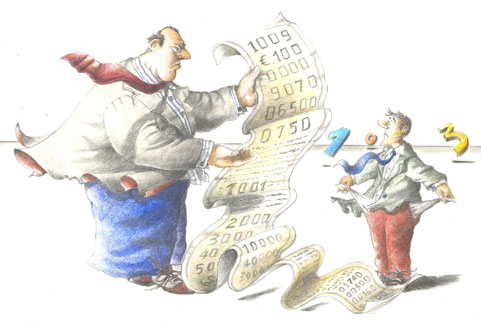 Nel corso dei colloqui, il Partito Democratico ha già ceduto a svariate richieste dei repubblicani, ben decisi a tagliare più di due mila miliardi di dollari di spese nei prossimi anni. Tra le concessioni più dolorose che verranno verosimilmente estratte dai repubblicani c’è quella di ristrutturare pesantemente i popolari programmi di assistenza pubblica Medicare e Medicaid.
Nel corso dei colloqui, il Partito Democratico ha già ceduto a svariate richieste dei repubblicani, ben decisi a tagliare più di due mila miliardi di dollari di spese nei prossimi anni. Tra le concessioni più dolorose che verranno verosimilmente estratte dai repubblicani c’è quella di ristrutturare pesantemente i popolari programmi di assistenza pubblica Medicare e Medicaid.
Nonostante la scarsa resistenza democratica, il Partito Repubblicano ha deciso infine di portare alle estreme conseguenze la propria linea, rifiutandosi di prendere in considerazione qualsiasi nuova imposizione fiscale per i grandi interessi economici e finanziari.
Lo scontro tra i due partiti era stato comunicato in anticipo al presidente Obama dallo speaker della Camera, John Boehner, nel corso di una visita alla Casa Bianca che ha gettato le basi per gli sviluppi futuri della vicenda. La messinscena a Washington ha poi seguito un copione consolidato.
Dopo la rottura delle trattative da parte dei repubblicani Cantor e Kyl, il presidente ha annunciato il suo imminente impegno diretto per ristabilire i colloqui tra le parti, mentre la leadership democratica al Congresso non si è lasciata sfuggire l’occasione per presentare il proprio partito come il difensore dei lavoratori e della classe media americana.
La pretesa dei democratici di costituire un baluardo contro i poteri forti non ha in ogni caso alcun fondamento. Le stesse proposte del partito di Obama di aumentare le tasse per i ricchi sono piuttosto modeste, come la soppressione degli incentivi per le compagnie petrolifere o la riduzione dei rimborsi fiscali per i redditi più alti e per le corporation.
Queste iniziative avrebbero fatto risparmiare alle casse federali non più di qualche decina di miliardi di dollari ma, pur essendo a beneficio di pochi americani, non hanno pressoché nessuna possibilità di essere approvate dal Congresso. Al contrario, programmi pubblici che riguardano più di cento milioni di americani sono quotidianamente il bersaglio dei falchi del deficit e verranno quasi certamente smantellati o ridotti sensibilmente nel prossimo futuro con l’accordo di entrambi i partiti.
 Lo stesso gruppo di lavoro sotto la supervisione di Biden, prima della rottura delle trattative, aveva identificato oltre mille miliardi di tagli alla spesa pubblica. Ad annunciarlo pubblicamente era stato lo stesso vice di Obama, il quale si era allo stesso tempo premurato di ricordare come a sacrificarsi per risanare il bilancio non deve essere soltanto la “middle-class” americana.
Lo stesso gruppo di lavoro sotto la supervisione di Biden, prima della rottura delle trattative, aveva identificato oltre mille miliardi di tagli alla spesa pubblica. Ad annunciarlo pubblicamente era stato lo stesso vice di Obama, il quale si era allo stesso tempo premurato di ricordare come a sacrificarsi per risanare il bilancio non deve essere soltanto la “middle-class” americana.
Che i democratici non abbiano alcuna intenzione di urtare quei grandi interessi che essi stessi difendono strenuamente era risultato d’altra parte evidente sul finire dello scorso anno proprio su un’altra questione legata alle tasse. Quando ancora deteneva la maggioranza in entrambi i rami del Congresso, il Partito Democratico era stato infatti incapace di cancellare i tagli alle tasse per i più ricchi in scadenza il 31 dicembre 2010, accettando invece il loro prolungamento, come voluto dai repubblicani.
Come il Partito Repubblicano, anche quello Democratico sta promuovendo inoltre tagli alla spesa sociale, compressione dei diritti sindacali, licenziamenti e riduzioni di stipendi, benefit, pensioni e copertura sanitaria per i dipendenti pubblici in molti stati dove i suoi rappresentati detengono la maggioranza nei parlamenti locali. Il caso più recente è quello del New Jersey, dove l’assemblea statale ha appena approvato un pacchetto di tagli voluto dal governatore repubblicano Chris Christie.
In questo scenario, appare sempre più evidente come non vi siano differenze sostanziali tra i due partiti che dominano la scena politica di Washington. Entrambi gli schieramenti difendono gli interessi dei privilegiati: ma, mentre i repubblicani lo fanno apertamente, i democratici cercano di apparire attenti ai bisogni dei lavoratori e della classe media. Un atteggiamento in realtà solo esteriore, dettato da necessità elettorali e dal timore di veder esplodere un conflitto sociale che cova sotto le ceneri di un sistema che continua a produrre disuguaglianze colossali.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Dopo un processo durato dieci anni, il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (Ictr) ha condannato all’ergastolo Pauline Nyiramasuhuko, ex ministro delle Politiche Femminili del Rwanda ritenuta colpevole di aver preso parte al genocidio e di aver ordinato i massacri e gli stupri avvenuti nel distretto di Butare nel 1994. Condannati al carcere a vita anche il figlio Arsene Shalom Ntahobali, allora studente, e il borgomastro di Muganza, Élie Ndayambaje, entrambe ritenuti colpevoli dei reati di genocidio e crimini contro l'umanità, incitamento diretto e pubblico allo sterminio, di stupro e persecuzione, di violenze e di oltraggio alla dignità della persona.
Con pene che vanno da 25 a 35 anni di reclusione sono stati inoltre condannati l’ex tenente colonnello dell’esercito ruandese, Alphonse Nteziryayo, il borgomastro di Ngoma, Joseph Kanyabashi, e il prefetto di Butare, Sylvain Nsabimana. Riconosciuta colpevole per sette degli 11 capi di imputazione, Pauline Nyiramasuhuko ha ascoltato la sentenza emessa dal giudice William H. Sekule senza mostrare emozioni.
Il genocidio in Rwanda è stato uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo: dal 7 aprile 1994, in circa 100 giorni, vengono massacrate più di 800 mila persone, in massima parte Tutsi e Hutu moderati; i principali responsabili dell’eccidio sono le milizie Interahamwe e le milizie Impuzamugambi, gruppi paramilitari addestrati ed equipaggiati dalle stesse forze governative fedeli al defunto presidente Juvénal Habyarimana.
Il genocidio s’inserisce in un contesto di rivalità etnica che prende il via con la divisione a sfondo razziale decisa da quello che sarà definito il peggior regime coloniale africano (e mondiale): quello belga.
 Rilasciando le “patenti di identità etnica”, i belgi hanno amministrano il potere appoggiandosi alla minoranza Tutsi, ma dopo quasi mezzo secolo di discriminazioni gli Hutu si ribellano e con la rivolta del 1959 riescono a cacciare la monarchia Tutsi e gli schiavisti europei; il 1 luglio 1962 il Rwanda ottiene l’indipendenza da Bruxelles.
Rilasciando le “patenti di identità etnica”, i belgi hanno amministrano il potere appoggiandosi alla minoranza Tutsi, ma dopo quasi mezzo secolo di discriminazioni gli Hutu si ribellano e con la rivolta del 1959 riescono a cacciare la monarchia Tutsi e gli schiavisti europei; il 1 luglio 1962 il Rwanda ottiene l’indipendenza da Bruxelles.
Per vendicarsi delle angherie subite gli Hutu organizzano feroci rappresaglie che causano migliaia di morti e portano alla fuga di 150.000 Tutsi. Le violenze non risolvono però la questione e a distanza di trent’anni i gruppi più estremisti decidono mettere fine alla presenza Tutsi nel paese. Il 6 aprile 1994 l’aereo su cui viaggia il presidente del Rwanda, Juvénal Habyarimana, e quello del Burundi, Cyprien Ntaryamira, viene abbattuto.
Gli Hutu ritengono responsabili dell’attentato il Fronte patriottico ruandese (Rpf), il movimento fondato dai Tutsi in esilio che dai primi anni novanta ha dato il via alla lotta armata contro il regime Hutu di Kigali; il 7 aprile, sotto gli occhi dell’UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda), comincia il genocidio. Nell’arco di pochi giorni il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riduce il contingente da 1705 a 270 unità; rimangono in Rwanda le sole forze canadesi del generale Roméo Dallaire, che si rifiuta di abbandonare il paese.
Oltre ad aver organizzato ed armato le milizie Hutu del distretto di Butare, aver eliminato ogni forma di resistenza interna ed aver pianificato e coordinato i massacri, Pauline Nyiramasuhuko è anche stata condannata per aver ordinato i sequestri e gli stupri di donne e ragazze appartenenti all’etnia Tutsi: comportamenti che la Corte ha definito tipici di una persona depravata e sadica. Fuggita dal Rwanda a causa dell’avanzata del Fronte patriottico ruandese, per alcuni anni la Nyiramasuhuko si è nascosta nella vicina Repubblica Democratica del Congo. Entrata in Kenya, il 18 luglio 1997 è stata arrestata e quindi tradotta nel carcere di Arusha, in Tanzania; il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda l’ha giudicata come caso n. ICTR-98-42-T.
 Durante il processo l’accusa ha dimostrato come tra il 9 Aprile e il 14 Luglio 1994 gli imputati siano stati parte rilevante nel progetto di annientamento della popolazione ruandese di etnia Tutsi: avvalendosi della testimonianza di alcune vittime sfuggite alla morte, il pubblico ministero ha ricostruito il ruolo determinate della Nyiramasuhuko e di Arsene Shalom Ntahobali nei massacri consumati tra il 20 e il 23 aprile presso la chiesa di Mugombwa e sulla collina di Kabuye e nel sequestro e nella morte migliaia di Tutsi; le responsabilità del borgomastro di Muganza e degli altri imputati nella strage commessa alla scuola Evangelista e nell’attaccato alla collina di Kabakobwa, così come nelle stragi avvenute allo stadio di Mutunda e presso la clinica di Matyazo.
Durante il processo l’accusa ha dimostrato come tra il 9 Aprile e il 14 Luglio 1994 gli imputati siano stati parte rilevante nel progetto di annientamento della popolazione ruandese di etnia Tutsi: avvalendosi della testimonianza di alcune vittime sfuggite alla morte, il pubblico ministero ha ricostruito il ruolo determinate della Nyiramasuhuko e di Arsene Shalom Ntahobali nei massacri consumati tra il 20 e il 23 aprile presso la chiesa di Mugombwa e sulla collina di Kabuye e nel sequestro e nella morte migliaia di Tutsi; le responsabilità del borgomastro di Muganza e degli altri imputati nella strage commessa alla scuola Evangelista e nell’attaccato alla collina di Kabakobwa, così come nelle stragi avvenute allo stadio di Mutunda e presso la clinica di Matyazo.
Lo scorso maggio il Tribunale penale internazionale per il Rwanda aveva condannato a 30 anni di reclusione Augustin Bizimungu, ex capo di stato maggiore delle forze armate ruandesi, arrestato in Angola nell'agosto del 2002 mentre combatteva a fianco dei ribelli dell'UNITA; insieme a Bizimungu erano stati condannati a 20 anni di carcere altri due ex alti ufficiali e l’allora capo di stato maggiore della gendarmeria, il generale Augustin Ndindiliyimana, rilasciato perché la pena a cui era stato sottoposto era equivalente al tempo passato in prigione dal momento del suo arresto.
Fino ad ora la Corte di Arusha ha portato a termine 65 processi, 38 le condanne, 19 i ricorsi in appello, 8 le assoluzioni; 10 i processi ancora in corso, 2 le persone in attesa di giudizio, 9 i ricercati. Pauline Nyiramasuhuko è la prima donna che l’Ictr ha condannato per il reato di genocidio; molte altre donne sono state direttamente giudicate dai tribunali ruandesi.
Recentemente le vittime del Rwanda hanno ottenuto giustizia anche in Belgio: a Bruxelles la Corte ha condannato due suore, un professore e un ex ministro perché ritenuti complici dei massacri avvenuti a Sovu. Insieme ad Alphonse Higaniro, ex ministro dei Trasporti in Rwanda, e a Vincent Ntezimana, ex professore universitario, Maria Visito Mukabutera e Gertrude Mukangango consegnarono alle milizie Hutu i 500 cittadini Tutsi che si erano rifugiati nel loro convento, fornendo agli assassini il carburante necessario a bruciare il garage dove si erano nascosti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Per quanto faccia male, una gamba in cancrena va amputata. Altrimenti si muore. Lo hanno capito anche i parlamentari di Atene, rassegnandosi ad approvare il nuovo piano lacrime e sangue che spezzerà la schiena alla Grecia nei prossimi anni, ma le consentirà di sopravvivere. Con 155 voti favorevoli, 138 contrari e cinque astenuti, è passata la manovra da 28 miliardi: 14 di tagli, altri 14 di nuove tasse da riscuotere nel prossimo quinquennio.
Misure dolorose ma indispensabili per intascare il prestito da 110 miliardi concordato con Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Non solo: l'approvazione del piano farà scattare anche il via libera per definire i dettagli di un secondo prestito da 120 miliardi. Con tutti questi soldi il Paese dovrebbe evitare la bancarotta e ripianare entro il 2014 il suo debito pubblico. Al momento la voragine è da 340 miliardi. Il che vuol dire 30mila euro che pendono sulla testa di ogni greco, neonati compresi.
La manovra e gli aiuti però non bastano. Per allontanare l'incubo del default la Grecia ha bisogno di un'altra iniezione. La vera anima del piano di risanamento annunciato dal primo ministro Geroge Papandreou è un programma di privatizzazioni del valore di 50 miliardi da realizzare entro il 2015. Ma anche su questo fronte i problemi non mancano. Al momento, il Governo di Atene può contare su 15 partecipazioni in società quotate in Borsa, più altre 70 partecipazioni in aziende non quotate. Peccato che, secondo i dati forniti dal Privatisation Barometer, una banca dati che contiene informazioni su ogni singola transazione di questo tipo, anche vendendo tutte queste quote la Grecia non riuscirebbe a ricavare più di 13,6 miliardi.
 Facendo una rapida sottrazione, il risultato è abbastanza preoccupante: per arrivare alla cifra prefissata mancano poco più di 36 miliardi. Secondo Bernardo Bortolotti, economista e fondatore del Privatisation Barometer, questo significa che l'Esecutivo dovrà iniziare a vendere praticamente qualsiasi cosa: terreni, immobili, concessioni, infrastrutture e altro ancora.
Facendo una rapida sottrazione, il risultato è abbastanza preoccupante: per arrivare alla cifra prefissata mancano poco più di 36 miliardi. Secondo Bernardo Bortolotti, economista e fondatore del Privatisation Barometer, questo significa che l'Esecutivo dovrà iniziare a vendere praticamente qualsiasi cosa: terreni, immobili, concessioni, infrastrutture e altro ancora.
Forse il disastroso quadro generale sfugge a buona parte del popolo greco, giustamente accecato dalla rabbia nei confronti di chi avrebbe dovuto evitare che si arrivasse a tanto. Può essere comprensibile perfino la violenza con cui molti manifestanti hanno cercato di impedire ai politici di entrare in Parlamento per votare la manovra. La polizia in assetto antisommossa si è scontrata con circa 400 dimostranti che cercavano di sfondare i blocchi per accedere alla piazza Syntagma di Atene, dove ha sede il Governo. Almeno tre persone sono finite in ospedale.
Il rifiuto è una reazione normale quando si è posti di fronte alla certezza di non aver alcun futuro nel proprio Paese. Ma la verità è che in questo caso il Governo doveva prendere una decisione semplice. Se non altro per la totale mancanza di alternative. Nemmeno il suicidio era un'opzione calcolabile, perché il fallimento della Grecia avrebbe effetti sistemici più o meno in tutto il pianeta. Come se un depresso, sparandosi in testa, uccidesse tutta la città.
Da questo punto di vista, parlare di potenziale effetto domino non vuol dire essere fanatici della catastrofe. L'ipotesi è fondata. Una ricostruzione di quello che potrebbe avvenire in caso di default greco è stata fatta da Business Insider. Innanzitutto, nelle banche di Francia e Germania sono stipati buoni del tesoro ellenici per un valore di 46 miliardi. Di qui l'apprensione di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, più che ansiosi di soccorrere i fratelli di Atene. La società di rating Moody's ha già messo in guardia i tre maggiori istituti di credito transalpini (Crédit Agricole, BNP Paribas, e Société Générale) sulla possibilità di un declassamento.
 Fin qui i big, ma c'è molto più. Ad essere esposta in modo preoccupante sul debito greco è praticamente tutta l'area euro. Sono sotto pressione soprattutto i sistemi bancari di Austria e Portogallo. Perfino la finanza privata bulgara e romena in questi giorni non fa che mangiarsi le unghie. Al vertice della piramide c'è naturalmente la Banca Centrale Europea, che è esposta addirittura per 120 miliardi di euro. Non è totalmente da escludere che un'eventuale insolvenza di Atene porti con sé rischi analoghi anche per la Bce, che in ogni caso uscirebbe dalla vicenda con le ossa rotte. A quel punto, sentendo puzza di morte, gli avvoltoi della speculazione inizierebbero a fare i loro giri in cielo, avventandosi sui Paesi col debito più insostenibile, Italia e Belgio.
Fin qui i big, ma c'è molto più. Ad essere esposta in modo preoccupante sul debito greco è praticamente tutta l'area euro. Sono sotto pressione soprattutto i sistemi bancari di Austria e Portogallo. Perfino la finanza privata bulgara e romena in questi giorni non fa che mangiarsi le unghie. Al vertice della piramide c'è naturalmente la Banca Centrale Europea, che è esposta addirittura per 120 miliardi di euro. Non è totalmente da escludere che un'eventuale insolvenza di Atene porti con sé rischi analoghi anche per la Bce, che in ogni caso uscirebbe dalla vicenda con le ossa rotte. A quel punto, sentendo puzza di morte, gli avvoltoi della speculazione inizierebbero a fare i loro giri in cielo, avventandosi sui Paesi col debito più insostenibile, Italia e Belgio.
Alcuni economisti si sono spinti perfino più in là con le previsioni. Se Parigi e Berlino si ritrovassero improvvisamente con l'acqua alla gola, potrebbero mettere in atto una qualche forma di neo-protezionismo. A sua volta l'implosione dei mercati europei farebbe sentire i suoi effetti sulle esportazioni americane e asiatiche, portando a una progressiva contrazione dei consumi. Nel frattempo la Cina finirebbe schiacciata sotto il peso dell'inflazione, che già oggi rappresenta il primo guaio economico di Pechino.
Di fronte a uno scenario simile, il crollo innescato da Lehman Brothers sembrerebbe poco più di una simpatica merenda. Che paura. Bisogna fare qualcosa per evitare che la prima tesserina del domino perda il suo precario equilibrio. E allora via libera ai prestiti da centinaia di miliardi alla Grecia. Quello che ancora non è chiaro è come farà un Paese in ginocchio a restituire tutti quei soldi.
