- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di mazzetta
di mazzetta
Mentre il “mondo libero” correva alla liberazione dei poveri libici dal tallone di Gheddafi con la benedizione della Lega Araba, in Bahrein si spegneva la luce per l'opposizione e per il movimento non-violento che aveva chiesto una monarchia costituzionale e il licenziamento dello zio del re, primo ministro da quarant'anni. In Bahrein c'è una monarchia assoluta e molto business-friendly, una società fino a ieri abbastanza aperta e cosmopolita, composta di circa mezzo milione di locali e altrettanti lavoratori stranieri.
Come altri emirati, il Bahrein funge da valvola di sfogo per i cittadini sauditi e gli espatriati nel regno dei Saud, che ne alimentano l'economia in cerca di svaghi severamente proibiti e repressi a pochi chilometri di distanza. A rafforzare il legame tra i due paesi c'è il fatto che la dinastia regnante, di origini saudite e imparentata con altre dinastie del Golfo, comanda su una popolazione prevalentemente sciita. E i sauditi considerano gli sciiti una minaccia a prescindere.
I manifestanti però non ne facevano una questione religiosa o settaria e hanno anche respinto con decisione la solidarietà imbarazzante dell'Iran o degli Hezbollah libanesi. Volevano solo maggiori libertà e una monarchia parlamentare. Hanno visto cosa è successo in Egitto e in Tunisia e d erano fermamente convinti di avere buone possibilità di ottenere una riforma del regno.
Ancor di più si sono convinti dopo che gli Stati Uniti hanno fermato la mano assassina degli al Khalifa, che aveva sgomberato l'ormai famosa Rotonda della Perla sparando di notte sui manifestanti inermi, accampati e addormentati. Promesse di riforme, i carri armati rientrati nelle caserme, la Rotonda della Perla occupata in permanenza in una riedizione non solo simbolica della piazza Tahrir al Cairo.
Poi gli Stati Uniti si sono venduti i manifestanti ai sauditi in cambio dell'appoggio della Lega Araba (che ha espresso però solo 9 voti a favore su 22 membri) all'attacco alla Libia. Dalla sera alla mattina il regno è stato invaso da truppe saudite e altre forze provenienti dagli emirati vicini. Come se un corpo di spedizione di duecentoquarantamila uomini entrasse in Italia.
Le monarchie del Golfo non possono permettere che l'autorità reale sia messa in discussione. A parte il Qatar, che ha avviato da tempo riforme abbastanza credibili e un vero trasferimento dei poteri o l'Oman, dove il sovrano sembra aver per ora ceduto alla piazza, la monarchia assoluta di stampo medioevale è il modello comune e non può essere messo in discussione, pena il rischio di un vero e proprio effetto-domino in tutta la penisola. I sauditi sono in prima fila nell'organizzare questa resistenza e non hanno esitato a ricorrere a misure draconiane per prevenire qualsiasi assembramento di scontenti.
 Rincuorato dalla presenza delle armate inviate dai parenti e dal via libera di Washington, al Khalifa ha gettato la maschera e ha rivelato una natura spietata, con spiccati tratti isterici, più degna di un Kim nordcoreano che dell'affabile anfitrione che accoglieva nel lusso e nella cordialità il gran mondo della Formula Uno e della finanza. Decine di uccisi, centinaia di feriti, un migliaio d’incarcerati.
Rincuorato dalla presenza delle armate inviate dai parenti e dal via libera di Washington, al Khalifa ha gettato la maschera e ha rivelato una natura spietata, con spiccati tratti isterici, più degna di un Kim nordcoreano che dell'affabile anfitrione che accoglieva nel lusso e nella cordialità il gran mondo della Formula Uno e della finanza. Decine di uccisi, centinaia di feriti, un migliaio d’incarcerati.
Una retata generale cominciata dai villaggi e poi proseguita nella capitale Manama. L'unico giornale d'opposizione chiuso d'imperio e risorto a distanza di due giorni con un editore diverso. Sulla Rotonda della Perla, al Khalifa si è accanito con la stizza di un bimbo indispettito. Ha dichiarato “profanato” il monumento che la decorava e l’ha fatto abbattere d'urgenza, con tale foga che uno dei suoi bracci in cemento armato è caduto su una macchina impegnata nella demolizione e ha ucciso un lavoratore pachistano, ennesima vittima della rivoluzione. Ma ad al Khalifa non è bastato; l'immagine del monumento appare anche sulla moneta da 500 Fils e allora ne ha disposto il ritiro.
Ora al posto dell'enorme monumento, fatto costruire dagli al Khalifa negli anni '80 per celebrare proprio il Consiglio di Cooperazione del Golfo, c'è una distesa di terra brulla e presto la sua immagine sparirà anche dalle tasche dei sudditi; una vera e propria condanna all'oblio, una rimozione della memoria tipica delle peggiori dittature.
Tale è la brutalità della reazione che il panorama si arricchito di posti di controllo, durante i quali gli sciiti passano brutti momenti e anche la tradizionale rilassatezza negli aeroporti è diventata un ricordo. Gli stranieri in arrivo sono sospettati di essere giornalisti in cerca di scandalo, fotografie e riprese nei punti caldi della rivolta sono assolutamente proibite e punite.
A nche i cittadini libanesi, che al regno hanno fornito esperienza e impulso imprenditoriale, sono finiti nella hit parade dei sospettati dopo la solidarietà di Hamas. Un livello di paranoia tipico dei regimi più sanguinari e una serie d'azioni che dovrebbero iscrivere di diritto al Khalifa tra i peggiori dittatori del pianeta. Ma poi qualcuno potrebbe chiedere di bombardare anche lui e questo non si può.
nche i cittadini libanesi, che al regno hanno fornito esperienza e impulso imprenditoriale, sono finiti nella hit parade dei sospettati dopo la solidarietà di Hamas. Un livello di paranoia tipico dei regimi più sanguinari e una serie d'azioni che dovrebbero iscrivere di diritto al Khalifa tra i peggiori dittatori del pianeta. Ma poi qualcuno potrebbe chiedere di bombardare anche lui e questo non si può.
Oggi, mentre la repressione continua e si teme che la polizia metta le mani sulle comunicazioni in rete dei giorni della rivolta per colpirla ancora più a fondo, del Bahrein non parla nessuno. Tace al Jazeera, emanazione del sovrano del Qatar che si è unito ai volenterosi liberatori di libici e che ovviamente sarebbe molto disturbato da servizi che mostrassero le condizioni dei poveri manifestanti massacrati in Bahrein.
Ma soprattutto tacciono tutti, i media come i politici, in Occidente. Nessuno offre solidarietà alle vittime della repressione, nessuno intima al sovrano di rispettare le vite e i diritti dei suoi sudditi, le grandi democrazie le hanno vendute in cambio dell'intervento in Libia e ora appartengono ai sovrani del Golfo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Saleh deve cadere. Finalmente anche gli Stati Uniti sono arrivati a questa conclusione, dopo aver colpevolmente temporeggiato per settimane. Domenica hanno per la prima volta definito "inaccettabili" le violenze del regime. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal New York Times, la posizione di Washington nei confronti del dittatore yemenita si è modificata negli ultimi quindici giorni. Da quando, cioè, sono iniziati i veri negoziati per una soluzione politica della crisi.
L'ultima proposta dell'opposizione, arrivata sabato scorso, prevede che Saleh lasci il potere al suo vicepresidente, Abdrabuh Mansur Hadi, che dovrebbe costituire un governo di transizione. Non sono d'accordo gli studenti yemeniti, che hanno dato origine alla protesta e ora rifiutano qualsiasi passaggio di potere a uomini compromessi col dittatore. Gli Stati Uniti, invece, stanno facendo pressioni proprio perché si arrivi a una soluzione di questo tipo. Sembra che stiano trattando anche per trasferire in sicurezza Saleh e la sua famiglia in un altro paese. Un esilio dorato in cambio della stabilità. Ma la posizione di Washington non è così semplice.
Dal gennaio scorso, quando sono scoppiate le rivolte popolari contro Ali Abdullah Saleh, alla guida dello Yemen dal 1978, l'amministrazione Obama ha continuato a sostenerlo per opportunismo prima, per doppiogiochismo poi. Mai una sola critica è stata rivolta direttamente contro di lui, nemmeno dopo le stragi di manifestanti disarmati. Un atteggiamento ben diverso da quello tenuto contro i regimi magrebini. Si capisce: Saleh è sempre stato un alleato fondamentale contro Al Qaeda, che nello Yemen ha uno dei suoi rami più attivi e pericolosi. Ma ormai le cose sono cambiate.
Le rivolte contro il dittatore hanno causato l'interruzione delle operazioni di controterrorismo. In queste condizioni gli uomini di Bin Laden hanno troppa libertà di manovra e potrebbero rafforzare i piani per possibili attacchi in Europa e in America. L'allarme è stato lanciato da diplomatici americani e da analisti dell'intelligence intervistati dal Nyt.
 Da metà gennaio le truppe yemenite si sono concentrate a Sana'a, la capitale, per far fronte alle continue manifestazioni anti-Saleh. Così facendo hanno lasciato indifesi i territori di molte province periferiche, dove Al Qaeda non ha tardato a riempire il vuoto di potere. Nelle ultime settimane gli attacchi dei terroristi a postazioni militari strategiche si sono moltiplicati.
Da metà gennaio le truppe yemenite si sono concentrate a Sana'a, la capitale, per far fronte alle continue manifestazioni anti-Saleh. Così facendo hanno lasciato indifesi i territori di molte province periferiche, dove Al Qaeda non ha tardato a riempire il vuoto di potere. Nelle ultime settimane gli attacchi dei terroristi a postazioni militari strategiche si sono moltiplicati.
Sembra inoltre che nuovi miliziani stiano arrivando nello Yemen da diverse parti del mondo, compreso il Pakistan. Secondo alcuni analisti, Saleh avrebbe ritirato l'esercito dai territori meridionali e sudorientali proprio perché Al Qaeda se ne impadronisse. Lo scopo del dittatore sarebbe di far precipitare la crisi in modo da convincere gli americani a sostenerlo.
In effetti Washington si trova di fronte a un bel dilemma: deve rimuovere Saleh e al tempo stesso garantire la ripresa delle operazioni contro Al Qaeda. Una prospettiva non semplice, considerando che il figlio del dittatore e tre dei suoi nipoti sono a capo delle quattro maggiori agenzie di sicurezza e controterrorismo del Paese. Fra queste, anche la Guardia Repubblicana e le Forze di Sicurezza Centrali, addestrate ed equipaggiate dagli Stati Uniti. Un improvviso cambiamento ai vertici di tutte le organizzazioni sarebbe una mossa più che rischiosa. Per questo gli americani stanno disperatamente cercando degli ufficiali del posto preparati e leali da usare come rimpiazzo.
 Intanto continuano le violenze nel Paese. L'appello di Saleh ad interrompere le proteste, come prevedibile, non è stato ascoltato. Gli scontri più violenti sono avvenuti domenica e lunedì nella cittadina meridionale di Taiz. Decine di migliaia di manifestanti stavano marciando verso la sede del governo quando i militari hanno iniziato a sparare.
Intanto continuano le violenze nel Paese. L'appello di Saleh ad interrompere le proteste, come prevedibile, non è stato ascoltato. Gli scontri più violenti sono avvenuti domenica e lunedì nella cittadina meridionale di Taiz. Decine di migliaia di manifestanti stavano marciando verso la sede del governo quando i militari hanno iniziato a sparare.
Pare che abbiano aperto il fuoco anche alcuni poliziotti in abiti civili, infiltrati nel corteo. Sono state uccise 17 persone, oltre 400 i feriti. Lunedì nel porto occidentale di Al Hudaydah, affacciato sul Mar Rosso, ci sono stati altri due morti. Nel frattempo a Sana'a gli uomini di Ali Mohsen al Ahmar, il generale passato dalla parte dei ribelli, impediscono alla polizia di sgomberare i manifestanti in piazza del Cambiamento. Venerdì si sono registrati altri scontri a Taiz, dove la polizia ha ucciso tre persone. I feriti da arma da fuoco sono stati 25, 200 gli intossicati dai gas lacrimogeni. Nuove manifestazioni anche ad Aden e a Hudaida, dove decine di migliaia di persone sono scese in piazza.
Non bisogna però dimenticare che le proteste degli ultimi mesi non sono l'unica causa della crisi yemenita. Continuano ad essere attive anche altre ribellioni, come quella degli Houthi, gruppo insediato nel nord del Paese, e quella del movimento secessionista meridionale. La già fragile economia yemenita, intanto, è praticamente implosa. A darle il colpo di grazia è stato proprio Saleh, che ultimamente ha speso un mucchio di soldi per pagare persone che fingessero di manifestare in suo favore e comprare la fedeltà dei capi tribù.
Per risolvere almeno il problema della successione di Saleh, martedì il Consiglio di Cooperazione del Golfo (composto da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti) ha invitato i rappresentanti del governo e dell'opposizione yemenita a Riyadh, dove i negoziati potrebbero finalmente sbloccarsi. Saleh inizialmente aveva accettato, ma mercoledì è tornato sui suoi passi, rifiutando ogni intromissione internazionale. Ma il progetto delle monarchie arabe del Golfo va avanti. Se dovesse realizzarsi trasformerebbe l'Arabia Saudita nell'alleato che toglie le castagne dal fuoco a Washington.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Martina Iannizzotto
di Martina Iannizzotto
DAMASCO. Da più di un mese l’aria é cambiata in Siria e non solo perché é scoppiata prepotentemente la primavera metereologica. Del resto sarebbe stato difficile credere che la primavera araba non avrebbe toccato un paese così importante e significativo per la regione come la Siria. Un mese fa la paura di parlare di politica, di esprimere dissenso era totale, nei caffè ci si guardava continuamente intorno per vedere se agenti della polizia segreta, il temuto mohabarat, stessero ascoltando e osservando. Ora la paura é ancora presente, gli agenti dal mohabarat ancora attivi, si avverte tensione e preoccupazione, ma non si può fare finta che non sia accaduto niente.
Dal quindici marzo in un’ondata di proteste senza precedenti migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Daraa, Latakia, Homs, Hama ed altre località del paese per chiedere riforme, libertà, la fine dello stato d’emergenza, la liberazione dei prigionieri politici. Non si sono viste le folle oceaniche come in Piazza Tahrir a il Cairo, ma questi eventi erano impensabili fino ad alcune settimane prima nel sistema siriano, dove dal 1963 é in vigore lo stato d’emergenza che proibisce ogni dissenso e la popolazione vive sotto il controllo della polizia segreta.
Il primo episodio si é registrato già il 18 Febbraio nel mercato centrale (suq) di Damasco, quando due poliziotti hanno picchiato il figlio di un negoziante - un genere di incontro con l’aurorità che vivono spesso i cittadini dei paesi arabi - e nel giro di qualche ora si é radunata una folla di mille persone che urlava “il popolo siriano non può essere umiliato”. E’ intervenuto personalmente il Ministro degli Interni assicurando un’indagine sull’episodio. Il video della scena ha avuto un’enorme diffusione su youtube, il cui accesso, insieme a facebook, era stato liberalizzato ad inizio febbraio. Una scena senza precedenti in Siria, indicativa di come la popolazione sia soprattutto stanca di subire una burocrazia autoritaria e corrotta.
 La rivolta é partita da Daraa, cittadina rurale conservatrice al confine con la Giordania, anche in questo caso legata ad episodio specifico: la liberazione di 15 teenagers arrestati per aver scritto dei graffiti contro il regime galvanizzati dai moti tunisini ed egiziani. Venerdì 18 marzo, chiamato giorno della dignità, la prima manifestazione repressa dalla polizia ha provocato quattro vittime. Il giorno seguente, i funerali delle vittime, considerate martiri, a cui hanno partecipato migliaia di persone, si sono trasformate in nuove proteste, con nuove repressioni e nuove vittime.
La rivolta é partita da Daraa, cittadina rurale conservatrice al confine con la Giordania, anche in questo caso legata ad episodio specifico: la liberazione di 15 teenagers arrestati per aver scritto dei graffiti contro il regime galvanizzati dai moti tunisini ed egiziani. Venerdì 18 marzo, chiamato giorno della dignità, la prima manifestazione repressa dalla polizia ha provocato quattro vittime. Il giorno seguente, i funerali delle vittime, considerate martiri, a cui hanno partecipato migliaia di persone, si sono trasformate in nuove proteste, con nuove repressioni e nuove vittime.
Si va a Daraa con un bus di linea, perché la città é circondata da soldati e non é permesso l’ingresso ai giornalisti; la sensazione è che tutta la città, non solo le espressioni più religiose, sia compatta dietro la rivolta, si senta ferita nella propria dignità: “karama” è un concetto fondamentale per capire la natura delle rivolte nei paesi arabi. Questa spirale manifestazioni-repressione-vittime ha allargato la protesta a villaggi vicini a Daraa e ad altre città. A Latakia, città portuale multi religiosa, da cui proviene la famiglia Assad, cecchini hanno sparato dai tetti contro manifestanti causando dodici vittime.
Secondo l’agenzia ufficiale Sana si tratta di bande armate che tentano di terrorizzare la popolazione e di alimentare uno scontro interreligioso, secondo gli attivisti si tratta delle stesse forze di sicurezza speciali e di milizie para-governative. Venerdì primo Aprile, il terzo venerdì di manifestazioni, definito “giorno dei martiri”, con chiamata alla mobilitazione fuori dalle moschee dopo la preghiera, uno degli slogan era “il sangue dei martiri non é invano”, “con i nostri corpi e le nostre anime ci sacrifichiamo per te Daraa”. Le forze di sicurezza hanno provocato dieci vittime a Duma, sobborgo vicino Damasco.
Lo spettro di un conflitto settario e confessionale é particolarmente avvertito dalla popolazione siriana, che ha ben presenti i casi dei vicini Iraq e Libano. La Siria é un paese multi religioso e multietnico: oltre ad una maggioranza sunnita (circa 75%), sono presenti alauiti, una setta sciita cui appartiene la famiglia Assad e da cui provengono i vertici dell’apparato militare e politico (12%), cristiani di vari riti (circa 8%), druzi, ismailiti. Una significativa porzione della popolazione (circa il 15%) é di etnia curda, concentrata soprattutto nel nord-est del paese.
Secondo organizzazioni dei diritti umani circa 300.000 curdi non hanno cittadinanza siriana e sono privi di diritti. Il regime secolare nazionalista del partito Baath e la concentrazione del potere nelle mani della minoranza alauita ha garantito stabilità ed equilibrio interno tra le varie comunità.
Le proteste in Siria sono variegate come la composizione comunitaria e geografica del paese: é sicuramente forte la componente dell’islam politico che rivendica maggior potere così come ci sono i ragazzi della generazione facebook, del tutto simili ai loro coetanei egiziani, che utilizzano twitter ed il gruppo facebook “Syrian revolution 2011”, ma sembra che tutti convergono nella richiesta fondamentale: hurryat, libertà. Che praticamente significa via lo stato d’emergenza e l’apparato del mohabarat, elezioni libere e multipartitiche, media indipendenti, liberazione dei prigionieri politici.
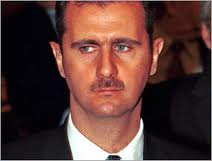 Il regime ha risposto con il bastone e la carota: repressione violenta che ha causato trenta vittime secondo fonti governative ed oltre cento secondo attivisti e difensori dei diritti umani, ma anche alcune concessioni (nuovo Esecutivo, sostituzione del governatore di Daraa e Homs, concessione della cittadinanza ai curdi apolidi) e promesse di riforme.
Il regime ha risposto con il bastone e la carota: repressione violenta che ha causato trenta vittime secondo fonti governative ed oltre cento secondo attivisti e difensori dei diritti umani, ma anche alcune concessioni (nuovo Esecutivo, sostituzione del governatore di Daraa e Homs, concessione della cittadinanza ai curdi apolidi) e promesse di riforme.
Il presidente Bashar Al Assad, dopo aver tenuto il paese in sospeso per giorni, ha pronunciato un attesissimo discorso in cui ha accusato una cospirazione internazionale di voler destabilizzare la Siria e ha reiterato vaghe promesse di riforme, senza alcun impegno concreto come la cancellazione dello stato d’emergenza che molti si aspettavano. Larga parte della popolazione é rimasta delusa, anche se la popolarità del presidente rimane alta.
Nei raduni organizzati a sostegno di Assad si vedeva autentico supporto. E anche nelle manifestazioni di protesta non si sentono (ancora) urlare slogan come “il popolo vuole abbattere il sistema”. Ma ormai nessuno, neanche la televisione ufficiale, può far finta che non esistano manifestazioni di protesta e dissenso. Gli scenari futuri sono difficili da prevedere. Il presidente ha promesso riforme politiche e democratiche, ma erano attese gia’ dieci anni fa quando Bashar e’ subentrato al padre Hafez, e sono arrivate solo le liberalizzazioni economiche che hanno aumentato la disparita’ tra ricchi e poveri. In tanti diffidano che l’elite al potere implementi quelle riforme da cui sarebbe penalizzata.
Allo stesso tempo la popolarita’ del presidente Bashar Al Assad, dovuta in larga parte alla sua immagine personale e alla politica estera siriana non accomodante verso gli Stati Uniti ed Israele, la paura dell’instabilita’ e del conflitto interconfessionale che potrebbe scoppiare con la caduta del regime, il pervicace sistema di repressione del dissenso, un’opposizione debole e divisa fanno si’ che al momento questi fuochi di rivolta divampati in varie localita’ del paese non rappresentino una vera minaccia per il regime siriano. Ma sono abbastanza seri da provocare delle reazioni da parte del governo e da preoccupare la popolazione sul futuro del paese.
Come negli altri paesi arabi, anche in Siria un’intera generazione chiede liberta’, dignita’, la fine della pura, un sistema di autorita’ non corrotto e nepototistico, migliori condizioni economiche. Domande a cui e’ difficile dare una risposta, ma e’ impossibile negarla.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Con un messaggio video indirizzato ai propri sostenitori, Barack Obama qualche giorno fa ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per la sua rielezione alla presidenza degli Stati Uniti nel 2012. Il comunicato dell’attuale inquilino della Casa Bianca è stato accompagnato - sia pure in maniera più discreta - dall’inevitabile supplica nei confronti dei soliti facoltosi finanziatori del Partito Democratico e dal consueto appello alla classe media americana, come sempre rispolverato all’approssimarsi dell’appuntamento con le urne.
L’avvio ufficiale delle operazioni per il team di Obama è stato possibile dopo la presentazione lunedì scorso della documentazione necessaria alla Commissione Elettorale Federale, una procedura che ha permesso al Presidente in carica di iniziare a raccogliere fondi e mettere assieme uno staff per il coordinamento della campagna.
Come ampiamente sottolineato dalla stampa statunitense, l’obiettivo di Obama è quello di superare la cifra record raccolta nel 2008 e possibilmente di sfondare per la prima volta nella storia del paese il tetto del miliardo di dollari. Per la sua prima elezione, l’allora senatore dell’Illinois fu in grado di contare su oltre 775 milioni di dollari, vale a dire più del doppio di quanto a disposizione della campagna elettorale di George W. Bush nel 2004. Nonostante la pretesa di aver mobilitato un numero enorme di piccoli donatori, la gran parte del denaro raccolto giunse in realtà da singoli contributi superiori ai mille dollari.
I grossi finanziatori continuano ovviamente a giocare un ruolo fondamentale nella selezione della classe politica americana, la quale una volta giunta a Washington finisce pressoché esclusivamente per occuparsi dei loro interessi. A conferma delle manovre orchestrate dietro le quinte dagli uomini di Obama c’è un recente incontro tra il responsabile della campagna elettorale, Jim Messina, e i maggiori finanziatori democratici, ai quali è stato chiesto di raccogliere 350 mila dollari ciascuno entro il 2011.
 Queste iniziative precoci consentono agli aspiranti alla Casa Bianca del Partito Democratico e Repubblicano di presentarsi all’inizio delle competizioni elettorali (primarie) con somme enormi, così da impedire sul nascere qualsiasi sfida eventualmente proveniente da potenziali candidati non legati ai grandi interessi economici e finanziari del paese.
Queste iniziative precoci consentono agli aspiranti alla Casa Bianca del Partito Democratico e Repubblicano di presentarsi all’inizio delle competizioni elettorali (primarie) con somme enormi, così da impedire sul nascere qualsiasi sfida eventualmente proveniente da potenziali candidati non legati ai grandi interessi economici e finanziari del paese.
L’appello di Obama ha in ogni caso rivelato le difficoltà che lo attendono sulla strada verso un secondo mandato. Oltre a ribadire la tradizionale convinzione che a decidere le sorti del voto saranno i cosiddetti elettori “indipendenti”, svincolati dai due principali partiti e recentemente gravitanti attorno all’orbita repubblicana, il presidente democratico ha ammesso di non poter più contare sulla carica innovativa che lo favorì nel 2008.
In quell’occasione gli Stati Uniti uscivano da otto anni tra i più bui della loro storia e il messaggio di cambiamento promosso da Obama - assieme alle sue qualità retoriche - incontrò il desiderio di voltare pagina ampiamente diffuso tra gli americani. Già a due anni di distanza dal suo approdo alla Casa Bianca, tuttavia, la delusione per un Presidente che si è raramente distinto dal suo predecessore, è ormai estremamente diffusa.
Da un lato, gli elettori indipendenti sembrano aver prestato ascolto alle accuse rivolte verso l’amministrazione Obama dagli ambienti repubblicani per una presunta espansione oltre il dovuto delle prerogative del governo federale; dall’altro l’ala liberal del Partito Democratico ha perso ogni speranza di poter assistere ad un’accelerazione in senso progressista. Ancora più grave è poi lo sconforto di quegli americani, quasi sempre appartenenti ai ceti più disagiati, che hanno disertato e continueranno a disertare le urne, avvertendo correttamente l’impossibilità di trovare risposta ai propri problemi all’interno di questo sistema bipartitico.
Il racconto del primo biennio della presidenza Obama è d’altra parte costellato d’iniziative e decisioni rivolte alla difesa delle élite economiche sul fronte domestico e, su quello internazionale, degli interessi imperialistici statunitensi. Il primo Presidente di colore della storia americana, durante il suo primo mandato, ha così ampliato il piano di salvataggio delle banche colpite dalla crisi dell’autunno 2008 e già approvato verso la fine dell’era Bush, determinando il prosciugamento delle casse pubbliche a cui ora si cerca di far fronte tagliando selvaggiamente la spesa sociale.
Se i profitti delle corporation e delle grandi banche di Wall Street sono tornati a livelli record, le condizioni dei lavoratori americani sono nettamente peggiorate e la percentuale dei disoccupati risulta in discesa solo grazie allo scoraggiamento di quanti hanno smesso di cercare un impiego, sparendo dalle statistiche ufficiali. Il prolungamento dei tagli alle tasse per i redditi più elevati voluti originariamente da Bush jr., inoltre, si è accompagnato ad un aumento effettivo del carico fiscale per quelli più bassi.
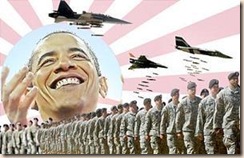 In politica estera e di sicurezza nazionale, infine, l’impegno militare in Iraq è stato solo apparentemente ridimensionato, mentre il coinvolgimento in Afghanistan è stato ampliato a fronte di una crescente ostilità tra gli americani verso un conflitto senza prospettive. Il lager di Guantanamo continua a rimanere in funzione, così come proseguono le detenzioni senza processo e gli abusi in nome della lotta al terrorismo. La recente avventura libica ha poi ulteriormente incontrato l’ostilità dell’opinione pubblica interna, tanto che i sondaggi più aggiornati indicano per Obama un indice di gradimento appena superiore al 40 per cento, cioè al livello più basso dall’insediamento alla Casa Bianca.
In politica estera e di sicurezza nazionale, infine, l’impegno militare in Iraq è stato solo apparentemente ridimensionato, mentre il coinvolgimento in Afghanistan è stato ampliato a fronte di una crescente ostilità tra gli americani verso un conflitto senza prospettive. Il lager di Guantanamo continua a rimanere in funzione, così come proseguono le detenzioni senza processo e gli abusi in nome della lotta al terrorismo. La recente avventura libica ha poi ulteriormente incontrato l’ostilità dell’opinione pubblica interna, tanto che i sondaggi più aggiornati indicano per Obama un indice di gradimento appena superiore al 40 per cento, cioè al livello più basso dall’insediamento alla Casa Bianca.
La situazione nel Partito Repubblicano potrebbe in ogni caso contribuire al successo della campagna elettorale di Obama. Tra i repubblicani, a tutt’oggi un solo candidato ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di partecipare alle primarie - l’ex governatore del Minnesota, Tim Pawlenty - e finora non è chiaro chi potrà emergere come sfidante dell’attuale Presidente democratico. Il predominio dell’estrema destra nelle primarie repubblicane potrebbe oltretutto produrre un candidato difficile da digerire per moderati e indipendenti nelle elezioni presidenziali vere e proprie, favorendo di conseguenza Obama negli stati dove la situazione risulterà più incerta.
Nonostante il vantaggio dal punto di vista delle risorse finanziarie da investire in campagna elettorale, per Obama e il suo staff di stanza a Chicago cominciano ad emergere alcuni segnali preoccupanti. Gli effetti della più grave crisi dai tempi della Grande Depressione hanno causato il riemergere di un certo conflitto sociale anche negli USA - esploso ad esempio qualche settimana fa in maniera clamorosa in Wisconsin - e la consapevolezza tra la popolazione dell’irreversibilità di un sistema iniquo e totalmente controllato da una ristretta cerchia di privilegiati.
Se anche la campagna appena inaugurata per il voto del 2012 dovesse andare nuovamente a buon fine per Barack Obama, le prospettive per il suo eventuale secondo mandato appaiono già da ora tutt’altro che confortanti. Il Presidente democratico, infatti, si ritroverebbe con ogni probabilità a fronteggiare un Congresso interamente a maggioranza repubblicana, con il quale sarebbe costretto a cercare onerosi compromessi e a spostare inevitabilmente ancora più a destra la barra della sua azione politica.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Laurent Gbagbo non ha firmato la resa e le forze di Alassane Ouattara, il Capo di stato ivoriano legittimamente eletto il 28 novembre scorso, hanno lanciato l’attacco finale. Ouattara ha ritenuto che le trattative che avrebbero dovuto sancire l'uscita di scena di Gbagbo stessero andando troppo per le lunghe ed ha quindi deciso di intervenire militarmente: «Non lo hanno ancora catturato ma accadrà presto» ha dichiarato a France-24 la portavoce di Ouattara, Affoussy Bamba.
Nonostante il pugno di ferro francese i negoziati sono dunque falliti; ieri sera, mentre ad Abidjan le truppe di Ouattara circondavano la residenza presidenziale, in una intervista telefonica alla radio francese Lci, Gbagbo aveva affermato che i suoi uomini stavano solo negoziando una tregua e che a livello politico non era stata ancora presa alcuna decisione: «Ho vinto le elezioni e non sto negoziando la mia uscita di scena». Una dichiarazione tutto sommato franca che non lasciava margine di trattativa.
L’attacco è iniziato verso le otto del mattino, con colpi d’arma pesante alternati al lancio di razzi sparati contro la residenza personale di Gbagbo, nel quartiere di Cocody, e contro il palazzo presidenziale e la caserma della Gendarmeria d’Abgan; nel quartiere settentrionale di Adjamé è iniziata subito la caccia ai miliziani pro-Gbgabo mentre nella Zona 4C, tra Boulevard Valery Giscard d’Estaing e Boulevard de Marseille dove risiede la comunità europea e dove hanno sede numerose attività commerciali francesi, i giovani patrioti davano il via ad una serie di atti vandalici e saccheggi con l’incendio di auto e negozi.
 Deserte le strade dei quartieri di Abobo e Anyama, epicentro degli scontri delle settimane scorse, e di Vridi-Canal, dove la gente vive chiusa in casa per paura dei furti e delle violenze commesse dai numerosi giovani che vanno in giro armati. Secondo alcune stime tra il Plateau (il centro) e Cocody ci sarebbero circa cinquemila uomini, soldati della Guardia Repubblicana e dei gruppi speciali della Gendarmeria, delle forze d’assalto della Marina (i Fumaco) e di una piccola parte dell’esercito regolare ancora fedele a Gbagbo.
Deserte le strade dei quartieri di Abobo e Anyama, epicentro degli scontri delle settimane scorse, e di Vridi-Canal, dove la gente vive chiusa in casa per paura dei furti e delle violenze commesse dai numerosi giovani che vanno in giro armati. Secondo alcune stime tra il Plateau (il centro) e Cocody ci sarebbero circa cinquemila uomini, soldati della Guardia Repubblicana e dei gruppi speciali della Gendarmeria, delle forze d’assalto della Marina (i Fumaco) e di una piccola parte dell’esercito regolare ancora fedele a Gbagbo.
Fino ad ora gli attacchi di arma pesante e le aggressioni non hanno risparmiato nessuno: saccheggiata e danneggiata gravemente l’Università di Abobo-Adjamé, interrotte le trasmissioni della televisione di Stato e delle radio private, colpiti il carcere civile di Maca e i quartieri di Anyama, Yopougon, Akandjé e Williamsville; rapiti e trucidati decine di civili, sequestrato e poi liberato il direttore diocesano della Caritas in Costa d’Avorio, Richard Kissi, prete ivoriano incaricato di distribuire viveri e medicinali a circa 1600 sfollati che da settimane sono rifugiati presso la scuola cattolica, la locale moschea e alcune parrocchie.
Gbagbo sta mostrando un certo grado di resistenza ed è difficile sapere cosa stia realmente accadendo; le fonti Misna parlano di una città deserta e di una popolazione rinchiusa in casa. Sono ormai alcuni giorni che nella capitale economica della Costa d’Avorio manca l’acqua e la corrente elettrica; le scorte alimentari cominciano a scarseggiare e la situazione umanitaria è assolutamente drammatica, con gli ospedali che iniziano a non poter più fronteggiare le emergenze. La comunità internazionale spinge affinché il presidente uscente dia le dimissioni e dopo le misure restrittive varate alcune settimane nei confronti di 92 personalità ivoriane, ieri Bruxelles ha deciso di colpire Gbagdo con nuove sanzioni finanziarie.
Da Parigi intanto arriva l’ammissione del ministro degli Affari esteri francese, Alan Juppé, che ha riconosciuto il fallimento dei negoziati ed ha e sostenuto che né le forze francesi né quelle dell’Onu sono coinvolte in queste ultime operazioni militari; di tutt’altra opinione il portavoce di Gbagbo, Ahoua Don Mello, che denuncia come i soldati dell’operazione “Licorne” starebbero intervenendo per fornire un sostegno aereo e terrestre a quello che ritengono l’assalto finale.
C’è chi sospetta che Gbagbo avesse già preparato il discorso di resa e contattato il governo del Benin per chiedere rifugio per sé e per i suoi figli, ma sembra il ministro della Gioventù, Charles Ble Goudé, il Consigliere spirituale della presidenza, Moise Koré, e la moglie Simone, già invischiata nella misteriosa scomparsa del giornalista franco-canadase Guy André Kieffers, lo abbiano “convinto” a combattere fino alla fine. Una resistenza ad oltranza sembra comunque improbabile: Ouattara controlla il 90% del Paese e i bollettini confermano che dopo i razzi piovuti il 18 marzo sulla capitale, i soldati regolari delle Forces de Defense et de Sécurité (Fds) hanno abbandonato Agnibilekrou e Abengourou e hanno perso il controllo della “regione del cacao”.
 Cadute Daloa e Duékoué, dove gli scontri a fuoco e i machete hanno causato la morte di circa 500 civili, le Forces Républicaines de Cote d'Ivoire (Frci) di Ouattara hanno preso il controllo di Buyo e Soubré, conquistato il porto di San Pedro, le località di Tanda e Tiébissou e la capitale politica Yamoussoukro, città nativa di Félix Houphouet-Boigny, padre della Nazione; sigillate le vie di comunicazione che portano alla frontiera con la Liberia, e le direttrici da dove, fino a pochi giorni fa, arrivava il flusso di mercenari assoldati dal regime.
Cadute Daloa e Duékoué, dove gli scontri a fuoco e i machete hanno causato la morte di circa 500 civili, le Forces Républicaines de Cote d'Ivoire (Frci) di Ouattara hanno preso il controllo di Buyo e Soubré, conquistato il porto di San Pedro, le località di Tanda e Tiébissou e la capitale politica Yamoussoukro, città nativa di Félix Houphouet-Boigny, padre della Nazione; sigillate le vie di comunicazione che portano alla frontiera con la Liberia, e le direttrici da dove, fino a pochi giorni fa, arrivava il flusso di mercenari assoldati dal regime.
Mentre Gbagbo perde posizioni, in Costa d’Avorio il quadro politico si fa sempre più complica e non è detto che la resa del fondatore del Fronte Popolare Ivoriano (Fpi) metta la parola fine alla crisi. Le vittorie riportate dalle Frci, l’esercito voluto da Ouattara per dare una veste più credibile ai guerriglieri delle Forces Armées des Forces Nouvelles (Fafn), stanno logorando i nervi degli ex guerriglieri e sembra che lo stesso premier Soro sia pronto a rivendicare il ruolo di leader della resistenza, così come sono pronti a presentare il conto tutti coloro che sono rimasti fuori dalla spartizione delle poltrone seguita alla guerra civile.
Non si è poi ancora ben capito dove vogliano arrivare i Commando invisibili del generale ribelle Ibrahim Coulibaly e la partita che stanno giocando uomini di vertice come il Capo di stato maggiore Soumaila Bakayokò e il Colonnello Michel Gueu, comandante in seconda della regione di Bouaké, ex zona ribelle della Valle del Bandama.
Abidjan è un vulcano pronto ad esplodere, una città sotto assedio dove proliferano gruppi armati di ogni forma e foggia, formati da mercenari provenienti dalla Sierra Leone, dalla Liberia, dal Senegal e dalla Nigeria, brigate pro e contro Gbagbo e commando al soldo dei signori della guerra. Dopo la notizia del rapimento di due francesi, un malese e un cittadino del Benin, prelevati da un gruppo di uomini armati penetrati all’interno dell’albergo della capitale nel quale alloggiavano, le truppe di Parigi hanno accelerato le operazioni per evacuare i circa 12 mila stranieri presenti nell’ex colonia e nella capitale sono stati organizzati tre punti di raccolta, centri presso i quali vengono organizzati i trasferimenti per l’aeroporto di Houphouet-Boigny controllato dalle teste di cuoio della Brigata francese.
