- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Sono più di diecimila i bambini accolti, ogni anno in Italia, con scopi terapeutici. E, negli ultimi venti anni, oltre cinquecentoventimila. Dal disastro di Chernobyl (evento in cui il Belpaese ha cominciato ad aprire le porte ai minori stranieri per motivi di cura e di svago) ad oggi, i programmi solidaristici per ospitarli sono diventati sempre più numerosi e più strutturati. Prevedono soggiorni di ‘risanamento’, per un massimo di centoventi giorni l’anno, consistenti nell’assunzione di alimenti sani, soggiorni in luoghi salubri, cure mediche e controlli preventivi.
Oltre a ciò vi sono programmi di ‘socializzazione’ basati sull’accoglienza in un ambiente sereno, con una quotidianità di cura, basati sulla condivisione del principio di solidarietà. L’obiettivo é trasformare la paura di luoghi sconosciuti e lontani in una possibilità, per i bambini che provengono da aree a rischio, soprattutto dal punto di vista sanitario, di incontro e confronto.
Quelli ospitati nel 2015 provengono, principalmente, dalla Bielorussia e, a seguire ma con grande distacco numerico, dalla Bosnia Erzegovina, dalla Federazione Russa e dall’Algeria e hanno un’età che oscilla fra gli otto e i dodici anni. Coloro che arrivano dai paesi dell’ex Jugoslavia, provengono, in genere, da strutture di accoglienza; gli altri, da contesti famigliari.
Anche in Italia vengono accolti, quasi sempre, soprattutto nei centri urbani sotto di diecimila abitanti, da genitori o da famiglie senza figli, con un’età superiore ai cinquant’anni considerato che la scelta di ospitarli impatta sull’organizzazione della vita quotidiana e sulla gestione dell’economia domestica.
Secondo quanto si legge nel report "Minori stranieri. Il fenomeno dell’accoglienza temporanea in Italia nel 2015", realizzato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le regioni italiane più generose verso questo tipo di accoglienza sono quelle del Nord Ovest: in testa la Lombardia, poi Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, nelle quali trova accoglienza oltre un terzo dei minori, seguite dalle Isole e dal Sud. Carente il Centro Italia, eccezion fatta per il Lazio.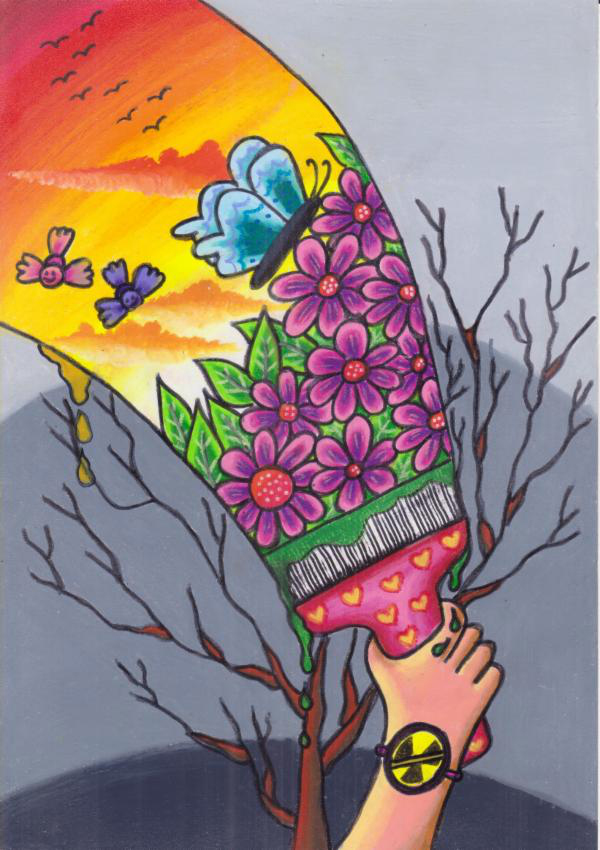 Ma non tutto è così semplice. In più occasioni, i percorsi di risanamento sono stati demonizzati da più parti, sia perché letti come un sistema che provoca danni nei bambini abbandonati che nel loro paese vivono in orfanotrofio e, per poche settimane l’anno, conoscono, ancor prima dell’affetto di una famiglia, il consumismo sfrenato.
Ma non tutto è così semplice. In più occasioni, i percorsi di risanamento sono stati demonizzati da più parti, sia perché letti come un sistema che provoca danni nei bambini abbandonati che nel loro paese vivono in orfanotrofio e, per poche settimane l’anno, conoscono, ancor prima dell’affetto di una famiglia, il consumismo sfrenato.
Perciò, seppur migliorati sotto il profilo fisico, tornerebbero malati sotto quello psicologico, inquinati nell’atteggiamento mentale e culturale. Viene poi messo l’accento anche su un altro aspetto: intorno al fenomeno dell’accoglienza temporanea si creerebbe un indotto che interessa numerosi attori.
Si muovono, infatti, quasi tutti gli alberghi della Bielorussia quando accolgono le famiglie italiane; si incrementa anche buona parte del fatturato della compagnia aerea Belaria e un gran numero di interpreti, traduttori e accompagnatori (anche improvvisati) ‘sfruttano’ il fenomeno, rendendo i bambini solo uno strumento. Utile anche, a volte a bypassare le lungaggini per l’adozione. Ma questo è un capitolo a parte.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Aumenta l’età ed è più stabile la condizione professionale, per entrambi i partner delle coppie che si sottopongono alla procreazione medialmente assistita. Coppie che, dopo tre anni circa di tentativi per ottenere una gravidanza, scanditi da un tempo pari, in media, ai primi quindici mesi di dubbi e domande relativi alla difficoltà di concepire un figlio e dai successivi dieci mesi (minimo) prima di rivolgersi a un medico, in genere il ginecologo di fiducia, hanno un livello d’istruzione più alto e una condizione professionale più certa.
Per metà di loro, e sono sempre di meno rispetto a una ricerca precedente, effettuata nel 2008, la diagnosi di infertilità ha una causa specifica, e per le restanti, il motivo rimane inspiegato: il percorso diagnostico è articolato, soprattutto per le coppie del Sud e delle Isole, in cui l’individuazione della ragione dell’infertilità è sempre meno definita.
Eterogeno, invece, nell’intera penisola, il protrarsi dei tempi di attesa per accedere al trattamento: meno di tre mesi per le coppie che si sono rivolte a un centro privato, fino ai sei per quelle che hanno optato per uno convenzionato e oltre gli undici per quelle che hanno scelto una struttura pubblica.
La scelta, per la maggior parte dei pazienti intervistati nell’indagine “Diventare genitori oggi: il punto di vista delle coppie in PMA”, realizzata dal Censis, è stata condizionata dalla buona fama, e, in percentuali decisamente inferiori, perché è vicino casa o perché lo ha consigliato il medico curante. Ma c’è, pure, chi è stato orientato dai risultati delle ricerche su internet o perché economicamente più conveniente.
Che sia la FIVET omologa, quella a cui fa ricorso il 60,9 per cento delle coppie, o l’ICSI omologa per il 42,3 per cento del campione (ma non è trascurabile la percentuale di coloro che effettuano la crioconservazione dei gameti o il crio-transfer da scongelamento), il costo non è per tutti accessibile. Sebbene, soprattutto al Nord, le cure siano sostenute dal costo del ticket, il 35,4 per cento delle coppie ha pagato di tasca propria, principalmente al Centro, al Sud e nelle Isole, spendendo, occhio e croce, quattromila euro.
Ma tant’è. Loro, in linea di massima, sono soddisfatte. Meno dal punto di vista degli aspetti psicologici e relazionali sia per le difficoltà legate alla complessità del percorso, in cui è frequente l’assenza di un unico riferimento che possa guidare la coppia nel tempo, sia per l’incapacità dei centri, dove è riscontrabile una carenza informativa, di dare risposte alle problematiche di un vissuto così intimo.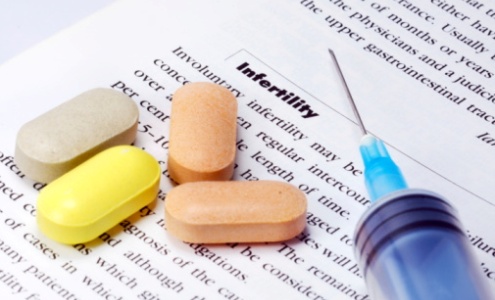 E se il primo tentativo fallisce, fonte di frustrazione che impatta notevolmente nel vissuto della coppie, il 65,4 per cento di queste intende riprovarci e solo il 31 per cento contempla la possibilità della strada dell’adozione, che diventa, invece, sempre più concreta all’aumentare del grado di istruzione.
E se il primo tentativo fallisce, fonte di frustrazione che impatta notevolmente nel vissuto della coppie, il 65,4 per cento di queste intende riprovarci e solo il 31 per cento contempla la possibilità della strada dell’adozione, che diventa, invece, sempre più concreta all’aumentare del grado di istruzione.
E la metà delle coppie ammette che il problema dell’infertilità sia un pensiero costante, motivo di disagio sia a causa della medicalizzazione di alcuni aspetti della vita intima, vedi la sessualità, sia per la sensazione di percepirsi diversi dagli altri e per la scarsa comprensione da parte dei familiari e degli amici più vicini. Quelli stessi che, però, scendono in piazza per difendere la possibilità di selezionare l’embrione.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Per le famiglie è il modo più economico di risolvere l’impatto di un problema opprimente, per gli immigrati è un mezzo di sussistenza remunerativo che non richiede grande specializzazione e, nel contempo, evita al sistema pubblico di trovare soluzioni alternative. Perché, a parte il sistema di previdenza sociale, il welfare state italiano, nulla ha fatto per il benessere familiare relativamente alla cura dei soggetti vulnerabili presenti nelle famiglie. Che, obtorto collo, sono dovute ricorrere a un welfare autoprodotto, risolvendo con la figura dell’assistente familiare.
Un compromesso oneroso, però: sia per le famiglie, con svantaggi di natura economica, fiscale e gestionale, sia per le badanti - generalmente donne - perché è una forma occupazionale totalizzante, da condurre in maniera duplice, divisa tra paese d’origine e quello d’accoglienza. Ogni famiglia, in media, spende per l’assistenza dei propri anziani o disabili, seicento e ottantanove euro al mese e, nel 91 per cento dei casi, non sono supportate da alcuna forma di contributo pubblico.
Non solo costi economici, ma, anche, tutta una serie di oneri gestionali e amministrativi: dalla comprensione della normativa per l’assunzione alle procedure per il permesso (o rinnovo) di soggiorno, dai conteggi per gestire la busta paga al versamento periodico dei contributi previdenziali.
Dal canto loro le badanti, con un’età compresa tra i trenta e i quarantanove anni, provenienti principalmente da Ucraina, Filippine, Moldavia, Perù e Sri Lanka, in circa venti anni, secondo quanto si legge nel papier “Il ruolo delle assistenti familiari nel welfare italiano”, redatto dall’ISMU, si sono quintuplicate e oggi sono circa ottocentomila; assistono persone over settantacinque, risiedendo, soprattutto nel Nord Ovest e nel Centro Italia, presso gli assistiti che, occhio e croce, sarebbero un milione.
Oltre due terzi degli assistenti famigliari che prestano servizio in Italia sono irregolari, una condizione che risulta in aumento negli ultimi anni, complice la crisi e non, certo, attribuibile al decremento della domanda di cura, prova ne sia la diminuzione delle iscrizioni all’INPS. Sebbene l’opzione dell’irregolarità sia, il più delle volte, una scelta concordata tra la famiglia, che risparmia, e la badante, che accumula più velocemente denaro per tornare in patria, la condizione è connotata da forte precarietà perché sciolti, entrambi, da qualsiasi garanzia. E per le assistenti famigliari è vulnerabilità a tutto tondo, anche relazionale. Attività esigente per la fatica fisica quotidiana e per la tensione dovuta alla vita transnazionale, nonché per i comportamenti dispotici di taluni datori di lavoro, per le badanti, quello della cura, non è solo un lavoro.
E per le assistenti famigliari è vulnerabilità a tutto tondo, anche relazionale. Attività esigente per la fatica fisica quotidiana e per la tensione dovuta alla vita transnazionale, nonché per i comportamenti dispotici di taluni datori di lavoro, per le badanti, quello della cura, non è solo un lavoro.
E’ il luogo dove trascorrono la propria esistenza e in cui è circoscritta la propria (limitata) intimità, violata, pure, da richieste dai confini molto labili: viene sollecitato un coinvolgimento affettivo che pesa sul loro (precario) equilibrio. In bilico tra il mantenere solidi e vivi i rapporti con gli affetti della vita precedente e il costruirne di nuovi nel contesto ospitante ma poco ospitale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Fa un lungo viaggio, il carbone. Parte dalla Colombia, arriva in Europa e nel mar Mediterraneo. Più grande produttore di carbone dell’America Latina e quinto esportare del mondo, la Colombia ha riserve che potrebbero durare per i prossimi duecento anni. Circa ottanta milioni di tonnellate l’anno interamente destinate all’esportazione ma nei territori sventrati dalle miniere rimane appena il 25 per cento delle royalties.
Nella prima metà degli anni ottanta, le attività estrattive erano nelle mani delle imprese statali fino a quando il Fondo Monetario Internazionale non esercitò le sue pressioni sulla privatizzazione che prese di mira le risorse naturali e, da allora, alla fine degli anni ottanta, il settore energetico e minerario è nelle spire del business privato.
Più precisamente, delle grandi corporation straniere che, coadiuvate da un legiferare sfrontato a loro favore, si dedicano alle attività estrattive prevalendo sui diritti di quelle persone, senza permessi e senza ricompensare le comunità locali.
Violenza e conflitti, i metodi per controllare i territori nelle regioni del carbone e in prossimità dei porti, sempre di proprietà delle società che lo estraggono, da dove salpano le navi cariche per l’Europa. Nei porti di Amsterdam, Rotterdam e Anversa. In Italia, in quelli di Civitavecchia, Brindisi, La Spezia, Vado Ligure, Fiume Santo, Monfalcone, Marghera, Ancona, Porto Vesme e Genova. Carbone che brucia, soprattutto, nelle centrali dell’Enel, al posto della quale, nella zona di Vado Ligure, dal 2003, è subentrata la Tirreno Power, per metà francese e per metà italiana, i cui stabilimenti sono stati messi sotto sequestro per il mancato rispetto di varie prescrizioni e per “decessi riconducibili alla presenza della centrale”, che ancora (per poco, forse) opera in un impianto di La Spezia, e nei grandi complessi di Civitavecchia e Brindisi.
Il carbone utilizzato è quello colombiano. Nel dossier “Profondo Nero. Il viaggio del carbone dalla Colombia all’Italia: la maledizione dell’estrattivismo”, redatto da Re:Common, riporta uno stralcio delle quarantaquattro pagine della relazione con cui i Pm il 17 giugno 2015 hanno concluso l’indagine preliminare: “Sceglievano, almeno sino al 2013, - si legge - tipologie di carbone di qualità inferiore e meno costosa (…) in particolare di provenienza indonesiana e colombiana, piuttosto che carbone proveniente da Russia e Usa, più costoso, ma avente percentuali inferiori di zolfo”. E’ un nemico, il carbone (anche per Matteo Renzi stando a quanto ha dichiarato il 22 giugno 2015, in occasione degli Stati generali sui cambiamenti climatici) perché è frutto dell’estrattivismo che non è un modello economico. E’, piuttosto, un sistema: fondato sulla promozione del consumo anziché sul lavoro e basato sulla funzione della corruzione sistemica.
E’ un nemico, il carbone (anche per Matteo Renzi stando a quanto ha dichiarato il 22 giugno 2015, in occasione degli Stati generali sui cambiamenti climatici) perché è frutto dell’estrattivismo che non è un modello economico. E’, piuttosto, un sistema: fondato sulla promozione del consumo anziché sul lavoro e basato sulla funzione della corruzione sistemica.
Va al di là del ruolo economico per diventare protagonista politico e sociale. Colpendo direttamente le popolazioni che abitano le terre della polvere nera, appropriandosi dell’acqua e dei loro luoghi, distruggendo l’agricoltura famigliare, aggredendo la salute di milioni di individui, eliminando gli abitanti rurali. Con una serie di omicidi, sparizioni forzate, profughi e disastri ambientali. E viaggia, il carbone, a bordo di interessi insospettabili.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
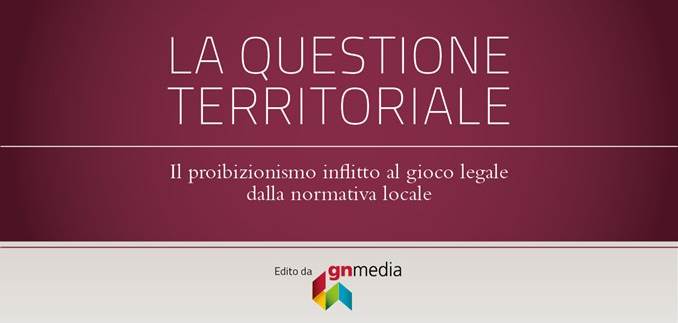 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Il gioco pubblico e il suo rapporto tra legge nazionale e regolamentazione locale è un tema che negli ultimi anni è cresciuto d'importanza, anche alla luce della miriade di normative regionali, provinciali e comunali che sono spuntate come funghi, cercando di risolvere alcune questioni che, a detta degli amministratori territoriali, restavano poco chiare. Ma allo stesso tempo creando una contrapposizione tra stato e territori su un tema sicuramente delicato come quello del gioco con vincita.
Per questo desta particolare interesse il libro di Geronimo Cardia, La questione territoriale. Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale. Si tratta di una raccolta di interventi e scritti a partire dal 2011, che offrono un quadro chiaro ed esaustivo delle varie normative regionali e comunali sul gioco e del loro rapporto con la regolamentazione statale. La contrapposizione tra la normativa territoriale e quella nazionale sul gioco pubblico italiano, e il suo possibile superamento, è il filo rosso che tiene insieme la raccolta di articoli che ha dato vita al libro. Il volume è stato realizzato dalla casa editrice Gn Media con il supporto di Novomatic Italia.
Come può lo Stato intervenire per favorire una corretta gestione del gioco pubblico? È possibile trovare un punto di equilibrio nell’offerta di gioco che evidenzi gli aspetti “ludici” e non quelli “ludopatici? Ci sono le condizioni per un accordo tra lo Stato ed Enti locali su una materia così delicata e controversa? “A queste domande è dedicato il bel libro di Cardia. La pretesa non è quella di dare un “verdetto”, come opportunamente ricorda Alessio Crisantemi nel preambolo al libro - afferma il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta - eppure, attraverso la lettura della realtà legislativa che il libro ripercorre, si intravedono le strade da imboccare. Una prima risposta ci viene dalla conferma della riserva statale in materia di giochi che, prima ancora che nella raccolta di risorse finanziarie, si sostanzia nella esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e, contemporaneamente, di contrastare le varie forme di illegalità di un fenomeno, quale il gioco e le scommesse, che è insito nella società”.
“Il panorama che abbiamo davanti non è dei più allettanti: i cambiamenti conseguenti alla evoluzione tecnologica e alle condizioni internazionali di mercato, non sono sempre stati adeguatamente accompagnati da un corrispondente quadro regolatorio che, nel giusto tentativo di porre freno al diffondersi indiscriminato del gioco illegale, governasse nel contempo, la crescita del disagio sociale”, ha proseguito. Il libro di Cardia ci dà una panoramica esaustiva del fenomeno”, ha aggiunto il sottosegretario.
Un testo che trae spunto proprio dall'esigenza di arrivare a una normativa chiara e univoca sul gioco, come spiega l'autore del libro: “È dal 2011 che gli operatori del gioco legale cercano di mettere in luce in tutte le sedi (giudiziali, culturali, giornalistiche) quanto la normativa prodotta dalle realtà territoriali (Regioni, Province, Comuni e questi ultimi con o senza copertura normativa provinciale o regionale) in merito alla distribuzione e alle modalità di distribuzione del gioco legale presenti caratteri di inadeguatezza, inapplicabilità oltre che di illegittimità, con tutte le conseguenze sul piano degli effetti".
