- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Tra le misure di sicurezza adottate in occasione del G-8 di questa settimana in Irlanda del Nord, potrebbero essercene alcune che rientrano a fatica in questa definizione e che, a differenza di altre utili per tenere lontane scomode manifestazioni di protesta, con ogni probabilità gli illustri ospiti del governo britannico non gradirebbero particolarmente. L’ennesima rivelazione del Guardian sullo scandalo intercettazioni ha infatti raccontato lunedì di come Londra metta sotto controllo i telefoni e i computer dei partecipanti a simili eventi, in particolare di due vertici del G-20 organizzati qualche anno fa nella capitale del Regno Unito.
La nuova esclusiva del Guardian si basa sempre sui documenti ottenuti dall’ex contractor della CIA e dell’NSA, Edward Snowden, e rivela un altro aspetto dell’apparato della sorveglianza costruito dagli Stati Uniti e al quale la Gran Bretagna partecipa attivamente, quello destinato cioè al controllo dei vertici di altri governi, indipendentemente dal fatto che essi siano considerati rivali o alleati.
La diffusione dei nuovi documenti riservati rischia di mettere in grave imbarazzo il governo conservatore di David Cameron proprio mentre quest’ultimo è impegnato ad accogliere i propri colleghi del G-8, molti dei quali già presenti a Londra nel 2009, andando ad aggiungersi alle questioni affrontate nel vertice organizzato nei pressi di Belfast.
L’operazione descritta dal Guardian è stata opera del cosiddetto GCHQ (Government Communications Headquarters), l’agenzia britannica corrispondente all’NSA americana, con la quale condivide e collabora nel controllo pervasivo delle comunicazioni elettroniche domestiche e internazionali.
Il piano del GCHQ consisteva sostanzialmente in un vero e proprio test delle “innovative capacità di intelligence per intercettare le comunicazioni delle delegazioni ospiti” del G-20 andato in scena nell’aprile 2009 e del summit dei ministri delle Finanze del G-20 del settembre successivo. Il motivo delle intercettazione di membri di governi stranieri sembra essere stato quello di acquisire informazioni sensibili che sarebbero tornate utili al governo di Londra in vista degli incontri ufficiali.
Il programma dell’operazione, secondo il Guardian, includeva in primo luogo il monitoraggio della posta elettronica dei delegati, compresa l’appropriazione dei dati di log in, da ottenere anche tramite la creazione di finti internet cafés, dei cui servizi i partecipanti al G-20 venivano incoraggiati ad usufruire. Inoltre, l’apparato della sicurezza britannico sarebbe penetrato nei sistemi di sicurezza degli smartphone personali dei rappresentanti del G-20, sempre con lo scopo di controllare e-mail e telefonate.
Le comunicazioni così intercettate sarebbero state analizzate da una squadra di 45 analisti attiva 24 ore su 24. L’intera operazione aveva l’approvazione del governo laburista dell’epoca, guidato dal primo ministro Gordon Brown. Le informazioni, infatti, erano state poi passate a quest’ultimo e ad alcuni ministri del suo gabinetto, a cominciare dall’allora ministro degli Esteri, David Miliband.
In particolare, un documento rivelato da Edward Snowden fa riferimento ad uno strumento di sorveglianza “utilizzato in molte occasioni durante recenti conferenze in Gran Bretagna” e che permette di “acquisire messaggi di posta elettronica senza rimuoverli dal server remoto”, così che gli intercettatori sono in grado di leggere le e-mail ancora prima degli intercettati. Le informazioni relative ai log in ottenute grazie alla messa in scena degli internet cafés, inoltre, hanno consentito di avere “opzioni di intelligence relativamente ai delegati anche dopo la fine della conferenza”. Uno degli obiettivi più importanti dei servizi di sicurezza britannici era ovviamente l’allora presidente russo, Dmitry Medvedev, il quale, assieme agli altri delegati del governo di Mosca, si è visto inconsapevolmente intercettare le proprie telefonate dalla stessa NSA americana in collaborazione con il GCHQ.
Uno degli obiettivi più importanti dei servizi di sicurezza britannici era ovviamente l’allora presidente russo, Dmitry Medvedev, il quale, assieme agli altri delegati del governo di Mosca, si è visto inconsapevolmente intercettare le proprie telefonate dalla stessa NSA americana in collaborazione con il GCHQ.
I documenti relativi all’operazione indicano una durata di essa di almeno sei mesi, mentre il programma di monitoraggio nel vertice dei ministri delle Finanze del settembre 2009 a Londra prevedeva, tra l’altro, una particolare attenzione per i delegati turchi. Il ministro di Ankara, Mehmet Simsek, e altri 15 colleghi e delegati vari venivano indicati come “possibili obiettivi”, così da “appurare la posizione della Turchia in relazione agli accordi presi nel summit di aprile” e testare la disponibilità del paese euro-asiatico “a cooperare con il resto dei membri del G-20”.
Nel corso del vertice di settembre, il GCHQ avrebbe fatto ricorso anche ad una nuova tecnica, studiata per fornire ai propri analisti un resoconto in tempo reale di ogni telefonata fatta o ricevuta dai delegati, il cui contenuto veniva proiettato su uno schermo di 15 metri quadrati presso il centro operativo dell’agenzia governativa. I dati ottenuti in questo modo sarebbero stati poi tempestivamente invitati ai rappresentanti britannici al G-20, ritrovatisi perciò in una posizione di vantaggio nei negoziati.
La descrizione del programma di intercettazioni messo in atto dal governo di Londra, come afferma lo stesso Guardian, conferma dunque un sospetto di lunga data, vale a dire l’esistenza di simili attività di spionaggio nel corso di summit internazionali. Nello specifico, la più recente rivelazione dimostra come anche in Gran Bretagna questi metodi illegali condotti da agenzie di intelligence dietro le spalle della popolazione vengano usati e giustificati da governi di qualsiasi orientamento politico.
Come emerge dai documenti resi noti da Snowden, inoltre, i G-20 del 2009 sono stati un banco di prova per valutare l’efficienza degli strumenti e delle tecniche impiegate dal GCHQ, così da perfezionarli nel futuro a seconda delle esigenze della classe dirigente britannica. La scelta dei delicati summit di Londra del 2009 da parte delle autorità britanniche, infine, appare tutt’altro che casuale, dal momento che essi avvennero a pochi mesi dal tracollo finanziario che ha scatenato la più grave crisi economica dagli anni Trenta del secolo scorso. I vertici, infatti, furono caratterizzati da profonde divergenze tra le varie potenze del pianeta su come rispondere alla situazione di panico diffuso, nonché dall’emergere di rivalità sopite e rinvigorite dalla crisi del capitalismo globale. Da qui la necessità, secondo Washington e Londra, di acquisire un vantaggio strategico in previsione delle complicate trattative con alleati e rivali.
La scelta dei delicati summit di Londra del 2009 da parte delle autorità britanniche, infine, appare tutt’altro che casuale, dal momento che essi avvennero a pochi mesi dal tracollo finanziario che ha scatenato la più grave crisi economica dagli anni Trenta del secolo scorso. I vertici, infatti, furono caratterizzati da profonde divergenze tra le varie potenze del pianeta su come rispondere alla situazione di panico diffuso, nonché dall’emergere di rivalità sopite e rinvigorite dalla crisi del capitalismo globale. Da qui la necessità, secondo Washington e Londra, di acquisire un vantaggio strategico in previsione delle complicate trattative con alleati e rivali.
Oltre ai partecipanti del G-20, secondo i documenti ottenuti dal Guardian, le autorità di Londra hanno spiato sempre nel 2009 anche i convenuti nell’isola caraibica di Trinidad per un summit del Commonwealth britannico, l’organizzazione che raccoglie le ex colonie del Regno Unito più il Ruanda e il Mozambico.
L’uso di sofisticati strumenti tecnologici di sorveglianza delle comunicazioni di organi di governo non beneficia però esclusivamente Stati Uniti o Gran Bretagna. Un recente articolo apparso sul quotidiano australiano The Age ha infatti rivelato come almeno anche un altro stretto alleato di Washington abbia ottenuto importanti vantaggi dai programmi dell’NSA recentemente smascherati.
Un anonimo funzionario del governo di Canberra ha cioè affermato come le attività dell’intelligence americana siano state “assolutamente decisive” per fare ottenere all’Australia un seggio provvisorio per gli anni 2013 e 2014 al Consiglio di Sicurezza ONU. Queste dichiarazioni non spiegano il modo in cui il governo laburista del premier Julia Gillard abbia tratto vantaggio dall’operato dell’NSA ma, anche alla luce dell’articolo di lunedì del Guardian, è più che lecito ipotizzare il ricorso a pratiche illegali nella campagna diplomatica che ha portato al voto dell’ottobre scorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la scelta dei membri provvisori del Consiglio di Sicurezza.
In ogni caso, tutte le rivelazioni dei giorni scorsi sono con ogni probabilità solo la punta dell’iceberg, dal momento che gli Stati Uniti, assieme ai governi loro alleati, continuano a fare affidamento su sistemi di monitoraggio ben più invasivi di quelli resi noti da Snowden, i quali, già di per sé, indicano abbondantemente come il processo di creazione di uno stato di polizia sia giunto ormai ad uno stadio avanzato.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Con un risultato a sorpresa, l’11esima elezione presidenziale della storia della Repubblica Islamica dell’Iran ha decretato la nettissima vittoria del candidato moderato Hassan Rouhani. Contrariamente alla maggior parte delle tesi sostenute da media e commentatori occidentali, il voto nel paese mediorientale è stato contrassegnato da una sostenuta partecipazione popolare e da una sostanziale libertà di scelta degli elettori, confermando la relativa apertura del sistema politico iraniano, soprattutto in relazione a quello delle vicine monarchie dittatoriali del Golfo Persico alleate di Stati Uniti ed Europa.
Anche se ben lontana dai livelli del 2009, quando sfiorò l’85%, l’affluenza alle urne nella giornata di venerdì ha superato le aspettative, assestandosi attorno al 72% nonostante l’esclusione preventiva da parte del Consiglio dei Guardiani di due candidati considerati tra i più popolari, l’ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani e il capo di gabinetto di Ahmadinejad, Esfandiar Rahim Mashaei. Le lunghe code al di fuori dei seggi hanno addirittura costretto il governo iraniano a prolungare l’orario del voto fino alla serata di venerdì.
Favorito dall’abbandono alla vigilia dell’unico candidato con credenziali “riformiste, l’ex vice-presidente Mohammad Reza Aref, già dopo lo spoglio delle prime schede Rouhani aveva fatto intravedere una solida performance. Alla fine, il Ministero dell’Interno di Teheran lo ha dichiarato vincitore già al primo turno con il 50,7% dei consensi, vale a dire oltre 18 milioni di voti espressi.
Sulla candidatura di Rouhani sono chiaramente confluiti i suffragi dell’elettorato che si riconosce nel movimento “riformista” grazie all’appoggio pubblico ricevuto settimana scorsa di Rafsanjani e dell’altro ex presidente, Mohammad Khatami. Il largo successo di Rouhani, tuttavia, ha evidenziato anche un significativo sostegno ricevuto dall’elettorato rurale e dalle classi urbane più disagiate, penalizzate da un’economia in grave crisi a causa delle sanzioni occidentali e dal progressivo abbandono delle politiche populiste promosse durante i primi anni dell’amministrazione Ahmadinejad.
Il voto di venerdì, inoltre, è stato segnato dal clamoroso fallimento dei candidati conservatori, indicati da molti, soprattutto in Occidente, come i favoriti per il successo grazie all’appoggio, peraltro mai dichiarato pubblicamente, di Khamenei. L’attuale negoziatore sul nucleare, Saeed Jalili, ha in particolare pagato la linea dura che ha ispirato la sua campagna elettorale, riuscendo a raccogliere poco più dell’11% dei consensi, meno anche dell’altro presunto favorito, il sindaco di Teheran, Mohammed Baqer Qalibaf, fermatosi al 16,6%.
Ancora più indietro sono finiti gli altri tre candidati ammessi dal Consiglio dei Guardiani: l’ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Mohsen Rezaee (10,6%), l’ex ministro degli Esteri e consigliere dell’ayatollah, Ali Akbar Velayati (6,2%), e l’ex ministro del Petrolio, Seyed Mohammad Qarazi (1,2%).
Se la decisione di ammettere alla competizione solo candidati che non rappresentavano una minaccia al sistema era stata presa a maggio dai vertici della Repubblica Islamica tramite la selezione del Consiglio dei Guardiani, la scelta del presidente tra i rimanenti candidati - espressione di diverse posizioni ideologiche - è stata dunque interamente nelle mani degli elettori iraniani.
La vittoria di Rouhani è stata favorita anche dalle divisioni nel campo conservatore o “principalista”, nel quel il ritiro a pochi giorni dal voto dell’ex presidente del Parlamento (Majilis), Gholam Haddad Adel, ha contribuito ben poco a unificare il voto attorno ad un unico candidato. Queste divisioni hanno mostrato a loro volta le differenze che caratterizzano le varie fazioni dell’establishment conservatore iraniano, soprattutto in relazione ai rapporti con l’Occidente e alle trattative sulla questione del nucleare. Proprio la possibile evoluzione dell’Iran attorno a quest’ultima vicenda, oltre che alla crisi in Siria, è stata al centro delle speculazioni dei media occidentali dopo l’affermazione di Rouhani, il quale durante la campagna elettorale ha frequentemente criticato la gestione sia della politica estera ed economica del governo uscente che dei colloqui sul nucleare del capo-negoziatore Jalili.
Queste divisioni hanno mostrato a loro volta le differenze che caratterizzano le varie fazioni dell’establishment conservatore iraniano, soprattutto in relazione ai rapporti con l’Occidente e alle trattative sulla questione del nucleare. Proprio la possibile evoluzione dell’Iran attorno a quest’ultima vicenda, oltre che alla crisi in Siria, è stata al centro delle speculazioni dei media occidentali dopo l’affermazione di Rouhani, il quale durante la campagna elettorale ha frequentemente criticato la gestione sia della politica estera ed economica del governo uscente che dei colloqui sul nucleare del capo-negoziatore Jalili.
Le sue posizioni moderate, il sostegno ricevuto dal movimento “riformista” e il precedente dell’accordo siglato sulla sospensione delle attività legate al nucleare quando era alla guida dei negoziati con l’Occidente fa infatti sperare in molti in un ammorbidimento dell’atteggiamento della delegazione iraniana nei futuri colloqui. La linea diplomatica che seguirà il paese, tuttavia, verrà in ultima analisi stabilita dallo stesso Khamenei.
Rouhani è comunque una personalità totalmente integrata nel sistema della Repubblica Islamica, come confermano i numerosi incarichi che ricopre all’interno dei vari organi che ne compongono la struttura del potere. Rouhani è infatti membro dell’Assemblea degli Esperti fin dal 1999, del Consiglio per il Discernimento dal 1991, del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dal 1989 (di cui è stato segretario, e quindi capo negoziatore per il nucleare, tra il 1989 e il 2005) e vice-presidente del Parlamento in due occasioni.
Come ha riportato l’agenzia di stampa ISNA, nella sua prima dichiarazione televisiva dopo l’elezione, il presidente-eletto ha sottolineato la sua vicinanza all’ayatollah Khamenei, esprimendo il suo apprezzamento per la Guida Suprema e per “la nazione iraniana che ha risposto positivamente” all’appello di quest’ultimo di recarsi in massa alle urne.
Lo stesso Khamenei, a sua volta, nella giornata di sabato si è congratulato con Rouhani per il successo elettorale, aggiungendo che il vero vincitore è stato il popolo iraniano, il quale “con prudenza e giudizio ha affrontato la guerra di nervi lanciata dai lacchè dell’egemonia globale”.
Al di là della retorica post-elettorale di Khamenei, è possibile che l’atteggiamento iraniano di fronte all’Occidente sarà di maggiore disponibilità nei prossimi mesi, rappresentando perciò una sfida per gli Stati Uniti e i loro alleati, responsabili di un’escalation di minacce, intimidazioni e sanzioni senza precedenti nei confronti di Teheran.
L’elezione sostanzialmente libera di un presidente moderato, ben disposto verso il dialogo con la comunità internazionale e appoggiato da un movimento “riformista” che trova il favore dell’Occidente dovrebbe infatti rendere più complicato per Washington o Tel Aviv decidere un’eventuale azione militare per risolvere la questione del nucleare iraniano.
Se Rouhani, con l’approvazione di Khamenei, dovesse mantenere le promesse elettorali e cercare più attivamente una soluzione diplomatica alla crisi sul nucleare, la palla passerebbe ancora una volta nel campo dell’Occidente, da dove le manovre per forzare un cambio di regime a Teheran o la ricerca di una sottomissione incondizionata al proprio dettato verrebbero smascherate clamorosamente. Il successo della presidenza Rouhani, in ogni caso, dipenderà anche dall’impatto sulla maggioranza della popolazione delle politiche economiche che verranno adottate per far fronte alla crisi e, soprattutto, dall’equilibrio che il suo governo riuscirà a stabilire con gli altri centri di potere della Repubblica islamica.
Il successo della presidenza Rouhani, in ogni caso, dipenderà anche dall’impatto sulla maggioranza della popolazione delle politiche economiche che verranno adottate per far fronte alla crisi e, soprattutto, dall’equilibrio che il suo governo riuscirà a stabilire con gli altri centri di potere della Repubblica islamica.
Come hanno ricordato gli ex funzionari del Dipartimento di Stato USA, Flynt e Hillary Mann Leverett, sul loro blog GoingToTehran alla vigilia del voto, i presidenti dell’Iran devono infatti tradizionalmente fare i conti innanzitutto con la figura della Guida Suprema, il cui compito è quello di assicurare che le politiche messe in atto dal governo non mettano a rischio “l’identità e la sicurezza a lungo termine della Repubblica”.
Inoltre, come hanno dimostrato le difficoltà incontrare dall’amministrazione Ahmadinejad in questi ultimi anni, il presidente nel proprio operato potrebbe essere seriamente ostacolato dal Parlamento, presieduto dal potente speaker Ali Larijani, impegnato nel tentativo di ridimensionare i poteri della più importante carica esecutiva del paese.
All’interno di questi vincoli dovrà perciò muoversi il pragmatico e conciliatore Rouhani, la cui gestione sul fronte domestico e internazionale contribuirà a modellare il futuro della Repubblica Islamica dell’Iran nei prossimi quattro anni.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Ricorrendo ancora una volta ad accuse completamente fabbricate, l’amministrazione Obama ha dato il via libera alla fornitura diretta di armi americane ai “ribelli” in Siria. Facendo uso di armi chimiche nel conflitto in corso, secondo gli USA, il regime di Bashar al-Assad avrebbe infatti oltrepassato la cosiddetta “linea rossa” fissata dal presidente democratico, determinando un intervento diretto degli Stati Uniti a sostegno dell’opposizione. Le fantomatiche prove addotte da Washington per giustificare il coinvolgimento in una nuova guerra in Medio Oriente si basano però su rapporti di intelligence confezionati ad arte, esattamente come accadde in occasione della disastrosa e illegale invasione dell’Iraq poco più di un decennio fa
Nonostante i recenti commenti di un’autorevole membro della speciale commissione ONU per la Siria, che attribuiva con buone probabilità l’uso di gas sarin ai “ribelli” stessi, così come, tra l’altro, l’arresto in Turchia di membri del gruppo terrorista Fronte al-Nusra attivo in Siria nelle cui abitazioni erano state trovate sostanze chimiche utilizzabili a fini militari, il governo americano ha deciso di procedere con un’iniziativa da tempo richiesta non solo dalle bande armate che compongono una variegata quanto impopolare opposizione ma anche dagli alleati europei e mediorientali che hanno finora sostenuto lo sforzo di armare e finanziare le operazioni anti-regime.
L’annuncio dell’accelerazione degli Stati Uniti è stato dato nella serata di giovedì dal vice-consigliere per la Sicurezza Nazionale, Ben Rhodes, e la svolta era stata anticipata dalla Associated Press qualche giorno fa in previsione di un vertice del governo USA andato in scena questa settimana alla Casa Bianca per decidere nuove iniziative in relazione alla difficile situazione in Siria.
Rhodes ha così affermato che la conferma dell’uso di gas chimici è basata sull’esame di campioni biologici provenienti dalla Siria e le conclusioni del suo governo sono state prese grazie a “flussi multipli e indipendenti di informazioni”, così che esisterebbe “un alto grado di confidenza” per accusare Assad, vale a dire nessuna certezza. La decisione di distribuire armi ai “ribelli” presa a Washington è la diretta conseguenza dei rovesci militari patiti dall’opposizione nelle ultime settimane, a loro volta dovuti all’ostilità nei loro confronti nutrita dalla maggioranza della popolazione siriana e all’assistenza fornita da Hezbollah e dall’Iran al regime di Damasco.
La decisione di distribuire armi ai “ribelli” presa a Washington è la diretta conseguenza dei rovesci militari patiti dall’opposizione nelle ultime settimane, a loro volta dovuti all’ostilità nei loro confronti nutrita dalla maggioranza della popolazione siriana e all’assistenza fornita da Hezbollah e dall’Iran al regime di Damasco.
Ai primi di giugno i “ribelli” avevano infatti perso la città di Qusayr, al confine con il Libano, centro nevralgico del traffico di armi a loro destinato proveniente dai paesi vicini. Dopo l’ingresso a Qusayr delle forze regolari e di un contingente inviato oltreconfine da Hezbollah, Assad ha da poco iniziato la preparazione di nuove operazioni per riprendere il controllo totale anche di Homs e, soprattutto, Aleppo.
La riconquista di quest’ultima città, la più grande del paese, significherebbe l’assestamento di un ulteriore pesantissimo colpo alle aspirazione dei “ribelli”, i quali vedrebbero messe in crisi le loro comunicazioni con la Turchia, da cui provengono armi e guerriglieri fondamentalisti.
Di fronte all’inesorabile avanzata delle forze del regime, i vertici dell’opposizione armata nei giorni scorsi avevano perciò ancora una volta supplicato gli Stati Uniti di dare il via libera all’invio di armi. Il generale Salim Idris, comandante teorico delle milizie appoggiate dall’Occidente, aveva chiesto migliaia di missili anti-carro e anti-aereo, così come centinaia di migliaia di munizioni. La decisione presa a Washington, giovedì, almeno ufficialmente esclude però dalle imminenti forniture gli armamenti pesanti per il timore che possano finire nelle mani di gruppi integralisti ed essere usati in futuro per colpire Israele o gli stessi interessi USA nella regione.
Le spedizioni di armi a gruppi di opposizione definiti moderati o di ispirazione secolare, ma che in realtà hanno chiare tendenze islamiste e le cui operazioni quasi sempre si sovrappongono a quelle di formazioni apertamente terroristiche, verranno coordinate con ogni probabilità con Francia e Gran Bretagna, con i cui leader Obama parlerà la settimana prossima nel corso del G8 in Irlanda.
Parigi e Londra si erano già mosse verso l’invio di armi in Siria dopo avere recentemente convinto l’Unione Europea a mettere fine all’embargo in atto da un anno. Gli stessi governi francese e britannico hanno inoltre agito di comune accordo con Washington nel diffondere la propaganda sull’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad, così da creare un pretesto opportuno per giustificare un maggiore coinvolgimento in Siria.
La decisione presa dall’amministrazione Obama è comunque solo il primo passo verso una sempre più probabile guerra aperta per rimuovere un rivale strategico importante come Assad. Il Wall Street Journal ha infatti rivelato che i progetti del Pentagono per il cambio di regime forzoso a Damasco includono anche l’imposizione di una no-fly zone, universalmente considerata uno strumento per condurre una guerra non dichiarata contro la Siria sul modello del conflitto in Libia nel 2011.
Per dare una facciata presentabile alle proprie manovre, tuttavia, gli USA sostengono che la no-fly zone - da attuare senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU vista la ferma opposizione di Russia e Cina - servirebbe soltanto a creare uno spazio in territorio siriano off-limits alle incursioni aeree del regime, così da favorire l’addestramento e il riarmo dei “ribelli”. Per evitare l’impedimento delle Nazioni Unite, inoltre, gli Stati Uniti potrebbero operare dalla Giordania per abbattere la flotta aerea di Assad senza entrare in territorio siriano. L’esplosione di un conflitto su vasta scala provocato dall’irresponsabilità delle politiche degli Stati Uniti, dell’Unione Europea, della Turchia e delle monarchie dittatoriali del Golfo Persico, appare dunque oggi molto più probabile. Ad essere coinvolta in una possibile guerra potrebbe essere, oltre all’Iran, anche la Russia, il cui governo ha subito criticato la decisione di Obama.
L’esplosione di un conflitto su vasta scala provocato dall’irresponsabilità delle politiche degli Stati Uniti, dell’Unione Europea, della Turchia e delle monarchie dittatoriali del Golfo Persico, appare dunque oggi molto più probabile. Ad essere coinvolta in una possibile guerra potrebbe essere, oltre all’Iran, anche la Russia, il cui governo ha subito criticato la decisione di Obama.
Da Mosca, nella giornata di venerdì un funzionario del Cremlino ha definito “poco convincenti” le prove nelle mani degli USA sull’uso di armi chimiche da parte di Assad, suggerendo un parallelo con le “errate” informazioni di intelligence che fornirono il pretesto di invadere l‘Iraq all’amministrazione Bush.
Decisamente più esplicito è stato poi il presidente della commissione parlamentare per le relazioni internazionali, Alexei Pushkov, il quale ha bollato le prove sull’uso di armi chimiche come “fabbricate”. Per il portavoce del ministero degli Esteri russo, invece, la nuova ondata di armi dirette in Siria farà aumentare “il livello dello scontro e le violenze contro i civili”.
La svolta americana, infine, potrebbe spingere la Russia a onorare il contratto siglato con Damasco nel 2010 per la fornitura del sofisticato sistema di difesa missilistico S-300, la cui consegna, inizialmente prevista per l’estate di quest’anno ma continuamente rimandata, secondo gli esperti consentirebbe al regime di Assad di contrastare efficacemente una campagna di bombardamenti nel paese.
Dopo avere contribuito in maniera decisiva a fomentare un conflitto settario che ha causato ormai quasi 100 mila morti, per promuovere i propri interessi strategici gli Stati Uniti sono ora pronti a scatenare una nuova guerra “umanitaria” che rischia di portare il bilancio delle vittime a livelli esorbitanti.
Il tutto, ancora una volta, basando le proprie azioni su falsità e prove manipolate, nonché sulla collaborazione di regimi oscurantisti e repressivi, come quello turco del premier Erdogan, impegnato a chiedere il rispetto dei diritti democratici della popolazione siriana mentre reprime nel sangue e con l’approvazione di Washington le proteste esplose in tutto il paese contro il suo governo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Per la prima volta dalla rivelazione del colossale programma di sorveglianza elettronica messo in atto segretamente dagli Stati Uniti, un organo ufficiale del governo cinese ha discusso in maniera pubblica la vicenda messa in moto dall’ex contractor della CIA e dell’NSA, Edward Snowden. Ad affrontare il caso è stato il quotidiano in lingua inglese, China Daily, il quale ha opportunamente evidenziato il doppio standard di Washington nell’affrontare le questioni della cyber-sicurezza, rispedendo in sostanza al mittente l’escalation di accuse formulate contro Pechino nelle ultime settimane dall’amministrazione Obama.
Per la testata, controllata dal governo cinese, la notizia dell’esistenza dei programmi segreti PRISM e, soprattutto, Boundless Informant, grazie al quale gli USA intercettano le comunicazioni elettroniche che avvengono in paesi stranieri, rappresenta una macchia all’immagine internazionale degli Stati Uniti, nonché una minaccia alle relazioni tra le prime due economie del pianeta.
La prima critica, in particolare, va direttamente al cuore del principale motivo di scontro tra Washington e Pechino, cioè le accuse rivolte a quest’ultimo governo di essere dietro attività di hackeraggio ai danni di agenzie governative e compagnie private americane. Come di consueto, anche in questo caso è apparso dunque chiaro come gli Stati Uniti siano responsabili di attività discutibili o palesemente illegali che, tuttavia, essi attribuiscono ai loro rivali internazionali.
Che gli USA siano i maggiori utilizzatori di armi tecnologiche per promuovere i propri interessi era sensazione comune ma le rivelazioni degli ultimi giorni hanno contribuito a confermarlo con prove concrete. Lo stesso Snowden lo ha affermato apertamente in un’intervista rilasciata mercoledì al quotidiano di Hong Kong South China Morning Post.
Il 29enne analista informatico ha infatti affermato che gli USA monitorano le comunicazioni elettroniche cinesi almeno dal 2009 e gli obiettivi comprendono membri del governo, università e aziende. Una delle ragioni che hanno spinto Snowden a rivelare i programmi dell’NSA è stato proprio il desiderio di dimostrare “l’ipocrisia del governo americano quando sostiene di non prendere di mira [nelle operazioni informatiche segrete] infrastrutture civili, come farebbero invece i suoi avversari”.
Oltre alla stessa scelta di riparare in territorio cinese per sfuggire alle ritorsioni del proprio governo, queste dichiarazioni di Snowden suggeriscono forse un qualche ruolo giocato dalle autorità di Pechino nelle rivelazioni dei programmi dell’NSA al Guardian e al Washington Post, tanto più che esse sono giunte praticamente in concomitanza con un vertice bilaterale in California tra i presidenti Obama e Xi Jinping, dove la cyber-guerra tra i due paesi avrebbe avuto un posto di rilievo.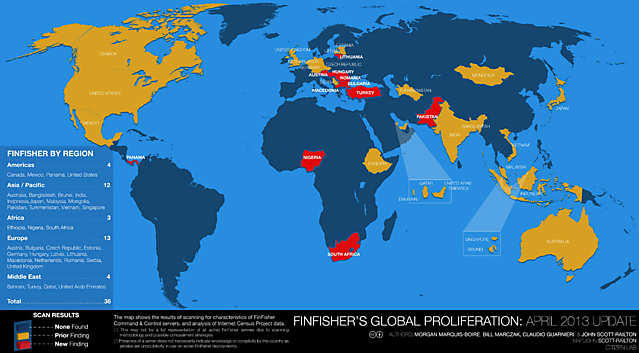 In ogni caso, l’esposizione delle attività di intercettazione condotte dagli USA in paesi sovrani, in contravvenzione di ogni regola del diritto internazionale, potrebbe in qualche modo rimescolare le carte della rivalità in atto con la Cina, intensificata dopo la cosiddetta “svolta” asiatica decisa dall’amministrazione Obama fin dal 2009 per contenere l’espansionismo di Pechino.
In ogni caso, l’esposizione delle attività di intercettazione condotte dagli USA in paesi sovrani, in contravvenzione di ogni regola del diritto internazionale, potrebbe in qualche modo rimescolare le carte della rivalità in atto con la Cina, intensificata dopo la cosiddetta “svolta” asiatica decisa dall’amministrazione Obama fin dal 2009 per contenere l’espansionismo di Pechino.
La gravità delle rivelazioni sia sul fronte domestico che internazionale sono comunque risultate chiare dall’aggressiva campagna messa in atto dalla classe dirigente americana e da buona parte dei media “mainstream” per incriminare lo stesso Snowden, così come per minimizzare la pervasività dei programmi di intelligence o esaltarne la presunta efficacia nel prevenire possibili attentati terroristici.
Evitando accuratamente di prendere in considerazione il contenuto delle rivelazioni e la violazione dei diritti costituzionali dei programmi segreti, molti politici americani hanno così chiesto punizioni esemplari per Edward Snowden. Tra i più feroci accusatori di quest’ultimo c’è la presidente della commissione per i servizi segreti del Senato, la democratica Dianne Feinstein, come i suoi colleghi da tempo a conoscenza delle attività illegali condotte dietro le spalle degli americani dal proprio governo, la quale ha senza mezzi termini definito Snowden un “traditore” per avere reso noto informazioni riservate.
L’auspicio nemmeno troppo segreto della classe politica d’oltreoceano è però addirittura quello di criminalizzare la stessa attività giornalistica, come ha confermato questa settimana il deputato repubblicano Peter King, in un’intervista alla CNN dove si è detto favorevole all’apertura di un’indagine giudiziaria anche ai danni del giornalista del Guardian, Glenn Greenwald, che ha pubblicato le recenti rivelazioni.
Secondo la logica di King, d’altra parte, sarebbero queste fughe di notizie che rivelano la totale illegalità con cui opera il governo di Washington a “mettere a rischio vite americane e a danneggiare il paese”.
Se accuse formali contro Greenwald sono tutt’altro che improbabili - come dimostra il complotto messo in atto per incriminare Julian Assange di WikiLeaks - la persecuzione di Snowden è invece scontata, dal momento che il Dipartimento di Giustizia ha già avviato un’indagine che porterà alla richiesta di estradizione dell’ex contractor americano.
La campagna di discredito contro Snowden e l’ennesimo dibattito-farsa in corso sui principali giornali USA circa la migliore definizione da attribuirgli - “eroe” o “traditore” - serve anche ad evitare l’emergere di qualsiasi ipotesi di incriminazione per coloro che all’interno del governo hanno deciso l’implementazione di programmi anti-costituzioni, compreso il presidente Obama, contro il quale le prove di un possibile impeachment vanno ormai ben al di là di quelle su cui si basò, ad esempio, lo scandalo che costrinse alle dimissioni Richard Nixon nel 1974.
Nessuna richiesta di rendere conto nemmeno delle dichiarazioni fuorvianti rilasciate ripetutamente dai vertici dell’intelligence ai rappresentanti del popolo sembra arrivare poi dai giornali americani. Clamorose sono state in particolare le menzogne del direttore dell’Intelligence Nazionale, nonché supervisore dell’NSA, James Clapper, il quale durante un’audizione al Congresso nel mese di marzo aveva assicurato i suoi intervistatori che l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale non raccoglie “intenzionalmente” informazioni sui cittadini americani. Il direttore dell’NSA, generale Keith Alexander, a sua volta nei mesi scorsi aveva più volte smentito che la sua agenzia è impegnata in attività di intercettazione delle comunicazioni elettroniche degli americani. Lo stesso Alexander è apparso mercoledì di fronte ad una commissione del Senato per difendere la gigantesca violazione dei diritti costituzionali da parte dell’NSA ma i senatori presenti hanno diligentemente evitato di chiedere spiegazioni sulle sue precedenti false dichiarazioni.
Il direttore dell’NSA, generale Keith Alexander, a sua volta nei mesi scorsi aveva più volte smentito che la sua agenzia è impegnata in attività di intercettazione delle comunicazioni elettroniche degli americani. Lo stesso Alexander è apparso mercoledì di fronte ad una commissione del Senato per difendere la gigantesca violazione dei diritti costituzionali da parte dell’NSA ma i senatori presenti hanno diligentemente evitato di chiedere spiegazioni sulle sue precedenti false dichiarazioni.
Il ricorso sistematico alla menzogna e all’inganno da parte della classe dirigente americana per limitare i danni seguiti alle rivelazioni di Guardian e Washington Post è chiaramente motivato dalla necessità di provare a giustificare ciò che un sistema democratico dovrebbe considerare inammissibile, senza alcuna eccezione.
Pervasi da un senso di panico per il progressivo venir meno della credibilità del sistema politico americano agli occhi della popolazione, i detentori del potere negli USA sono costretti a ricorre a intimidazioni, minacce e menzogne senza fine, che non fanno altro però che dimostrare ulteriormente il loro totale disinteresse per il rispetto dei diritti democratici.
Ancora menzogne, perciò, hanno caratterizzato la difesa dei programmi PRISM e Boundless Informant da parte, tra gli altri, di James Clapper e Dianne Feinstein. Entrambi in questi giorni hanno fatto riferimento agli arresti dei terroristi Najibullah Zazi e David Hadley, il primo con l’accusa di avere progettato un attentato sventato nella metropolitana di New York nel 2009 e il secondo per avere preso parte alla pianificazione degli attacchi a Mumbai, in India, nel 2008.
Secondo la versione ufficiale, Zazi e Hadley sarebbero stati individuati e assicurati alla giustizia proprio grazie ai programmi segreti di intercettazione dell’NSA. Una serie di indagini giornalistiche - condotte principalmente dal Guardian e dalla testata americana indipendente ProPublica - dimostrano al contrario come la cattura di entrambi sia stata dovuta ad attività tradizionali di intelligence e alla collaborazione tra agenzie USA e britanniche, mentre i programmi di sorveglianza dell’NSA non hanno avuto alcun ruolo.
Hadley, oltretutto, ben prima dei fatti di Mumbai era stato un informatore della DEA americana (Drug Enforcement Administration) e, con ogni probabilità anche di CIA e FBI, e le autorità statunitensi erano state più volte allertate dai familiari circa i suoi contatti con gli ambienti integralisti pakistani. La menzogna più eclatante e dalle implicazioni più inquietanti utilizzata dal governo americano è però quella che riguarda le fondamenta stesse della costruzione di un apparato della sicurezza nazionale da stato di polizia, vale a dire la necessità di combattere con ogni mezzo la “guerra al terrore” su scala planetaria.
La menzogna più eclatante e dalle implicazioni più inquietanti utilizzata dal governo americano è però quella che riguarda le fondamenta stesse della costruzione di un apparato della sicurezza nazionale da stato di polizia, vale a dire la necessità di combattere con ogni mezzo la “guerra al terrore” su scala planetaria.
Un documento interno della NSA del 2000, declassificato qualche anno fa, aveva infatti dimostrato come la preparazione delle misure messe in atto dopo l’11 settembre 2001 fosse già iniziata ben prima dell’evento che avrebbe portato a guerre rovinose e all’assalto ai diritti democratici negli Stati Uniti.
Nel cosiddetto memorandum “Transition 2001” si affermava cioè che, se anche “il Quarto Emendamento [che protegge da perquisizioni e confische senza un valido motivo] è applicabile ai sistemi di intelligence elettronica di ieri e di oggi, l’Era dell’Informazione ci spingerà a ripensare e ad applicare diversamente procedure e politiche nate in un diverso ambiente di sorveglianza”.
“L’NSA”, proseguiva il documento, “continuerà a svolgere le proprie missioni rispettando il Quarto Emendamento e tutte le leggi applicabili, tuttavia… è necessario comprendere che le missioni di domani richiederanno una robusta e continua presenza nelle reti di telecomunicazione globali che ospitano le comunicazioni protette degli americani e dei nostri avversari”.
L’avanzamento di questi programmi di sorveglianza a meno di un anno dagli attacchi al World Trade Center, infine, veniva giudicato eccessivamente lento, a meno che non avesse avuto luogo “un evento catastrofico, come una nuova Pearl Harbor”.
Le previsioni vecchie di oltre un decennio dell’NSA sembrano dunque essersi concretizzate, confermando come il progetto di sorvegliare sistematicamente il comportamento di virtualmente tutti gli americani e degli avversari degli USA sullo scacchiere internazionale sia in gran parte svincolato dall’anti-terrorismo e dalle ragioni della sicurezza nazionale.
Il riferimento fatto dal memorandum “Transition 2001” a possibili quanto ingiustificabili deroghe alle garanzie fissate nel Quarto Emendamento, poi, ricalca sorprendentemente le dichiarazioni del presidente Obama e di altri politici di Washington in questi giorni, tutte volte a difendere un sistema sempre più repressivo ormai del tutto al di fuori di un quadro autenticamente democratico.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Venerdì prossimo gli elettori iraniani si recheranno alle urne per eleggere il successore di Mahmoud Ahmadinejad alla presidenza di una Repubblica Islamica segnata da profonde divisioni politiche interne e da un’economia sempre più in affanno a causa delle sanzioni occidentali dovute allo stallo sull’annosa questione del proprio programma nucleare civile.
La campagna elettorale partita sotto tono il 22 maggio scorso ha subito una modesta scossa negli ultimi giorni in seguito al ritiro dalla competizione di due degli otto candidati approvati dal Consiglio dei Guardiani su oltre 600 aspiranti alla presidenza.
L’abbandono della corsa dell’unico candidato considerato riformista, l’ex vice-presidente Mohammad Reza Aref, sarebbe stato deciso in particolare per evitare la dispersione del voto di coloro che vedono con favore un riavvicinamento all’Occidente e una maggiore apertura del mercato iraniano al capitale internazionale.
Il voto dei riformisti, quindi, potrebbe così confluire interamente sul moderato Hassan Rowhani, già capo dei negoziatori sul nucleare tra il 2003 e il 2005, nonché relativamente più noto di Aref, soprattutto dopo l’appoggio ufficiale ricevuto martedì dalle due personalità più popolari tra questa sezione della società iraniana, gli ex presidenti Mohammad Khatami e Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.
L’entusiasmo elettorale di un movimento, come quello riformista, che fa riferimento principalmente ai giovani e alla borghesia urbana, non appare in ogni caso nemmeno lontanamente paragonabile a quello che il cosiddetto Movimento Verde aveva suscitato durante il voto contestato del 2009 con le candidature di Mir-Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi, entrambi tuttora agli arresti domiciliari. Oltretutto, il fervore residuo di una parte dei riformisti si era spento il mese scorso proprio con l’esclusione dalla corsa alla presidenza di Rafsanjani.
La capacità di Rowhani, il quale nel 2009 aveva condannato le proteste di piazza seguite alla rielezione di Ahmadinejad, di accedere al secondo turno di ballottaggio rimangono tuttavia quanto meno dubbie, soprattutto in assenza di sondaggi attendibili. Le sue chances di piazzarsi tra i due candidati più votati alla chiusura delle urne nella serata di venerdì dipenderanno dal gradimento suscitato in un periodo così breve in una parte dell’elettorato generalmente sfiduciata e che percepisce il sistema come bloccato e in sostanza impossibile da cambiare dall’interno.
Soprattutto, però, l’eventuale successo di Rowhani - così come di qualsiasi altro candidato sulla sponda conservatrice - dipenderà dalla quantità di consensi che riuscirà ad intercettare tra la classe lavoratrice urbana e i votanti nelle aree rurali, vale a dire la parte del paese maggiormente colpita dalle difficoltà e dai cambiamenti economici di questi anni e che ha rappresentato la base elettorale dei successi di Ahmadinejad nel 2005 e nel 2009.
Anche questa fetta dell’elettorato, sia pure oggetto di meno attenzioni da parte dei media occidentali rispetto alla borghesia alla moda di Teheran che tende a preferire i politici “riformisti”, era stata privata a maggio del candidato teoricamente in grado di difendere i suoi interessi, il capo di gabinetto di Ahmadinejad, Esfandiar Rahim Mashaei, considerato una minaccia all’establishment conservatore a causa del suo populismo e della sua probabile intenzione di rafforzare i poteri attribuiti alla figura del presidente.
Rowhani, in ogni caso, appare senza dubbio il candidato preferito dall’Occidente, come confermano i commenti apparsi sui media che lo descrivono, tra l’altro, come un politico “pragmatico” e in grado di mediare tra riformisti e conservatori. Nel suo incarico alla guida dei negoziatori sul nucleare, inoltre, Rowhani era riuscito a siglare un accordo provvisorio e parziale per la sospensione delle attività legate al discusso programma.
Sul fronte conservatore, invece, il ritiro dell’ex presidente del Parlamento e consuocero dell’ayatollah Ali Khamenei, Gholam Haddad Adel, sembra aver fatto bene poco per chiarire i rapporti di forza in vista del voto. I due favoriti dovrebbero comunque essere il carismatico sindaco di Teheran, Mohammed Baqer Qalibaf, e l’attuale capo dei negoziatori sul nucleare e segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Saeed Jalili.
I due favoriti dovrebbero comunque essere il carismatico sindaco di Teheran, Mohammed Baqer Qalibaf, e l’attuale capo dei negoziatori sul nucleare e segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Saeed Jalili.
Quest’ultimo, in particolare, viene considerato da molti il candidato preferito di Khamenei, non solo per la sua fermezza di fronte alle richieste occidentali e la dimostrata fedeltà alle direttive della Guida Suprema, ma anche per la sua mancanza sia di una vera e propria base elettorale sia di legami con le influenti fazioni che formano l’élite della Repubblica Islamica.
La presunta scelta di Jalili da parte di Khamenei, secondo questa tesi, sarebbe dettata dalla volontà di evitare l’esperienza vissuta dopo la rielezione di Ahmadinejad. L’ayatollah, cioè, non intenderebbe ritrovarsi a fare i contri con una forte personalità come quella del presidente uscente - per certi versi paragonabile a quella di Qalibaf - il quale dopo il successo del 2009 ha rapidamente perso l’appoggio di Khamenei perché considerato una minaccia per le istituzioni clericali della Repubblica Islamica.
Secondo altri analisti, al contrario, Khamenei non avrebbe in realtà scelto alcun candidato per il successo e sarebbero piuttosto i candidati stessi, soprattutto quelli senza una base elettorale significativa, a fare a gara per apparire come i protetti della Guida Suprema. La reticenza di Khamenei e l’insolita schiettezza che ha caratterizzato l’unico confronto televisivo tra i candidati ha dato qualche credibilità a questa interpretazione, secondo la quale perciò l’esito del voto di venerdì sarebbe del tutto aperto.
Inoltre, le critiche rivolte a Jalili per la gestione troppo rigida delle trattative sul nucleare con l’Occidente da parte di un altro candidato conservatore, l’ex ministro degli Esteri e consigliere dell’ayatollah, Ali Akbar Velayati, avrebbero evidenziato le divisioni esistenti all’interno della classe dirigente iraniana sull’atteggiamento da tenere nei confronti dell’Occidente per superare un’impasse diplomatica che dura da molti anni.
I giudizi negativi espressi da Velayati e da altri candidati alla linea dura tenuta da Jalili indicherebbero così per qualcuno una certa disponibilità da parte dei vertici dell’Iran a fare ulteriori passi per cercare un dialogo diretto con gli Stati Uniti. A conferma di ciò ci potrebbe essere, tra l’altro, anche la rivelazione fatta mercoledì dalla Reuters di una “insolita” lettera inviata qualche mese fa a Khamenei dal ministro degli Esteri, Ali Akbar Salehi, per promuovere “un’ampia discussione con gli USA”. Un invito, quello di Salehi, a cui l’ayatollah, pur senza mostrare ottimismo, non si sarebbe opposto. Al di là del comunque importante esito delle elezioni presidenziali in Iran, la sensazione diffusa è che le sorti delle trattative sul nucleare che hanno occupato buona parte della campagna elettorale dipenderanno più che altro dall’atteggiamento che intenderà adottare Washington, da dove le ripetute aperture di Teheran nell’ultimo decennio sono state puntualmente respinte.
Al di là del comunque importante esito delle elezioni presidenziali in Iran, la sensazione diffusa è che le sorti delle trattative sul nucleare che hanno occupato buona parte della campagna elettorale dipenderanno più che altro dall’atteggiamento che intenderà adottare Washington, da dove le ripetute aperture di Teheran nell’ultimo decennio sono state puntualmente respinte.
Sfruttando l’esclusione di candidati autorevoli da parte del Consiglio dei Guardiani e le misure per tenere sotto controllo il dissenso interno in vista del voto, l’amministrazione Obama ha infatti criticato apertamente il processo elettorale iraniano. Soprattutto, poi, il periodo di transizione in corso verso l’insediamento di un nuovo presidente continua ad essere caratterizzato dall’imposizione di nuovi pesanti sanzioni unilaterali da parte degli Stati Uniti, come il recente tentativo di impedire all’Iran di accedere al denaro generato dalle sue esportazioni depositato su conti bancari esteri.
Una nuova escalation di misure punitive, quella del governo USA, che conferma come l’obiettivo rimanga quello di utilizzare la questione del nucleare per giungere ad un cambio di regime a Teheran o, in alternativa, di concludere un accordo per risolvere la crisi ma secondo le proprie condizioni, riassumibili nella sottomissione dell’Iran agli interessi strategici americani, con il conseguente rischio di compromettere la natura stessa della Repubblica Islamica e la rimanente legittimità della sua classe dirigente agli occhi della popolazione.
