- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Lo scorso venerdì le delegazioni del presidente deposto dell’Honduras Manuel Zelaya e del governo golpista al potere hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione della crisi politica iniziata nel paese centroamericano il 28 giugno. Dopo mesi di trattative che si erano continuamente arenate sulla questione del reintegro del presidente democraticamente eletto, a sbloccare la situazione è stato l’intervento del governo americano che ha inviato una propria delegazione a Tegucigalpa per convincere il leader del regime, Roberto Micheletti, a cedere alle pressioni della comunità internazionale.
Nonostante il compromesso sia stato propagandato da Washington come un trionfo per la democrazia, il ritorno di Zelaya alla guida del paese a meno di un mese dalle elezioni presidenziali appare, prima che inutile, tutt’altro che scontato. Così come la tardiva presa di posizione dell’amministrazione Obama non potrà evitare il compiersi dello scopo ultimo di un colpo di stato che essa stessa aveva in definitiva tacitamente appoggiato: impedire il cambiamento politico e sociale nel secondo paese più povero del continente. Se Zelaya verrà restituito al suo ruolo costituzionalmente legittimo, la sua sarà in ogni caso una brevissima presidenza privata di poteri in un governo da condividere con le stesse persone che cinque mesi fa lo avevano costretto all’esilio.
Le premesse per lo scioglimento dell’impasse honduregna, come già anticipato, erano state poste dall’arrivo nella capitale dell’assistente al Segretario di Stato americano per l’emisfero occidentale, Tom Shannon, già in carica durante l’amministrazione Bush, e del consigliere di Obama per l’America Latina, Dan Restrepo. Obiettivo della delegazione americana era quello di rendere legittime agli occhi della comunità internazionale le elezioni presidenziali del 29 novembre prossimo, trasformandole nell’occasione per ristabilire finalmente l’ordine in Honduras. Dal momento che praticamente nessun paese, USA compresi, appariva disposto ad accettare il risultato di un voto condotto con il presidente legittimo asserragliato nell’ambasciata brasiliana, dove era giunto a fine settembre, il governo di Micheletti ha finito col cedere.
I termini dell’accordo firmato dalle due parti a Tegucigalpa con la benedizione di Washington risultano molto simili a quelli contenuti nella proposta avanzata dal presidente del Costa Rica, Oscar Arias, dopo il golpe di giugno e che da subito aveva mostrato ben poche possibilità di raggiungere un qualche risultato definitivo. Ciò include in primo luogo la formazione di un governo di unità nazionale, all’interno del quale non è chiaro quale sarà la sorte dei politici e dei funzionari ministeriali vicini a Zelaya e rimpiazzati all’indomani del golpe. Nessun provvedimento invece verrà preso nei confronti di quei membri dell’esercito protagonisti del colpo di mano dello scorso giugno.
Da parte sua, Zelaya rinuncerà a qualsiasi pretesa di dar vita ad un Assemblea Costituente per modificare una Carta che l’Honduras ha adottato nel 1982, dopo la fine del regime militare, e che da allora ha servito gli interessi di un’oligarchia detentrice della gran parte della ricchezza del paese. Proprio il tentativo di Zelaya di tenere una consultazione popolare non vincolante per rivedere la costituzione era stato il pretesto scatenante il golpe. Secondo i golpisti, infatti, il presidente stava cercando di cambiare la costituzione in modo da ottenere l’abolizione del limite di un solo mandato alla guida del paese per poter correre nelle elezioni di novembre. Un’accusa evidentemente falsa, dal momento che l’eventuale elezione di un’assemblea costituente avrebbe dovuto tenersi proprio al momento della scelta del suo successore.
Una commissione con il compito di investigare a fondo gli eventi legati al golpe verrà poi istituita, mentre un organo costituito da esperti indipendenti honduregni e internazionali veglierà sull’implementazione dell’accordo. Mentre sarà escluso qualsiasi procedimento criminale ai danni di quanti sono stati coinvolti nel colpo di stato, nessuna amnistia è prevista invece, come chiedeva inizialmente Zelaya, per eventuali reati politici. Una condizione verosimilmente voluta dai militari, a quanto pare tuttora intenzionati a processare il presidente legittimo per tradimento.
Un altro punto critico delle trattative era poi la scelta dell’organismo a cui affidare l’eventuale decisione formale di reintegrare Zelaya. Quest’ultimo si aspettava infatti un voto del parlamento, nonostante in esso conservasse il supporto di appena un quinto dei deputati, mentre per Micheletti avrebbe dovuto essere quella stessa Corte Suprema che aveva deliberato la rimozione del suo rivale a deciderne il ritorno. Secondo il compromesso mediato agli USA, alla fine, la Corte Suprema dovrà emanare una propria opinione in merito allo status di Zelaya, sulla quale poi il Congresso sarà chiamato ad esprimere il voto decisivo.
Sui tempi tuttavia rimane estrema incertezza e le prime indicazioni fanno temere ulteriori ritardi nell’applicazione dell’accordo. In un’intervista alla stazione radio honduregna HRN, infatti, il presidente del Parlamento, José Alfredo Saavedra, ha già fatto sapere di non voler accettare ultimatum da parte di nessuno in merito alla data di un possibile voto sulla sorte di Zelaya. Fino a quel momento, Micheletti rimarrà così in carica con i pieni poteri. Ancora più preoccupanti sono state addirittura le dichiarazioni rilasciate da un membro dello staff del presidente golpista, Marcia Facussé de Villeda, a Bloomberg News, alla quale ha ammesso che “Zelaya non sarà reintegrato. Con la firma dell’accordo semplicemente ci siamo assicurati il riconoscimento delle elezioni presidenziali da parte della comunità internazionale”.
In attesa dei nuovi sviluppi della situazione, Mel Zelaya e il suo entourage rimangono bloccati dentro l’ambasciata brasiliana a Tegucigalpa, accerchiata dalle forze di sicurezza honduregne che nelle ultime settimane hanno puntualmente dissolto con la forza ogni manifestazione pacifica a sostegno del presidente deposto. Zelaya, che verrà comunque sostituito dal suo successore il prossimo mese di gennaio, ha da parte sua descritto l’accorso siglato venerdì scorso come un “segno di pace per il nostro paese e del ristabilimento della nostra democrazia”. I suoi ringraziamenti sono andati al Segretario di Stato Hillary Rodham Clinton e alla delegazione americana protagonista della mediazione, così come al presidente costaricano Arias e al governo brasiliano di Lula.
Significativamente assente dai ringraziamenti di Zelaya è stato invece il presidente venezuelano Hugo Chavez, tra i critici più vigorosi del golpe di giugno. Proprio la progressiva vicinanza con Chavez, consolidata da contratti di fornitura di petrolio all’Honduras al di sotto del prezzo di mercato, era stata un'altra delle scuse che avevano condotto al colpo di stato. La classe dominante honduregna aveva più volte criticato la svolta a sinistra di Zelaya nel corso del suo mandato presidenziale, paventando per il proprio paese un percorso verso il socialismo simile a quello intrapreso dal Venezuela.
Il presunto successo diplomatico degli Stati Uniti, in ogni caso, non dissolve di certo le ombre e le ambiguità di un’amministrazione che pure aveva condannato ufficialmente il golpe fin dall’inizio. Innanzitutto, rimane l’interrogativo di un intervento americano che avrebbe potuto giungere ben prima della fine di ottobre per risolvere la crisi. Soprattutto alla luce della profonda influenza storicamente esercitata da Washington sull’Honduras, per il quale rappresenta di gran lunga il primo partner commerciale e l’investitore estero più importante.
Una strategia dilatoria quella dell’amministrazione Obama che, se ufficialmente è stata dettata dalla volontà di non intervenire direttamente nelle questioni interne di un paese sovrano, favorendo piuttosto il dialogo tra le parte in causa, ha dato l’impressione a molti di assecondare il governo di Micheletti prolungando le trattative fino alle elezioni di fine novembre, così da mettere da parte Zelaya e, di riflesso, contenere l’espansione nel continente di Hugo Chavez. Un sospetto alimentato anche dagli stretti legami dal punto di vista militare tra USA e Honduras, circostanza che rende difficile credere che Washington fosse stata all’oscuro delle manovre golpiste in atto la scorsa estate.
Nelle parole di Hillary Clinton dopo l’annuncio dell’accordo, gli esponenti del governo golpista sono stati allora descritti alla stregua di eroi della democrazia honduregna, spazzando via le loro responsabilità nel ribaltamento illegale dell’ordine democratico, ma anche dell’assassinio di almeno una ventina di oppositori, di centinaia di feriti e della soppressione sistematica del dissenso nel paese.
Se l’esito della crisi politica dell’Honduras rimane insomma ancora tutto da verificare, con i due candidati della destra favoriti per la vittoria nelle elezioni presidenziali, chi esce sconfitto dall’intera vicenda, almeno per ora, sembra essere il movimento di protesta sorto tra i lavoratori e le classi più emarginate nel corso dell’esilio forzato di Zelaya. Una richiesta di cambiamento diventata però impetuosa negli ultimi mesi, proprio in seguito al golpe promosso da quella ristretta aristocrazia economica che controlla il potere, e che promette di portare frutti importanti anche in questo paese nel prossimo futuro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di mazzetta
di mazzetta
Negli Stati Uniti la marijuana è ormai de facto libera in diversi stati. Non che sia stata legalizzata, ma attraverso il cavallo di Troia dell'uso medico, la pianta ha ormai conquistato spazi di libertà impensabili fino a qualche anno fa. La questione dell'uso medico della marijuana si segnala per la massiccia quantità d'ipocrisia che è stata necessaria per giungere fino allo status attuale.
L'uso medico della marijuana è conosciuto da migliaia di anni e anche recenti ricerche hanno dimostrato l'efficacia nel trattamento di un numero impressionante di patologie. La usavano gli antichi cinesi, gli egizi, i greci, gli indiani ed è rimasta in uso in medicina fino alla campagna di criminalizzazione del ventesimo secolo. Numerose ricerche in età moderna ne hanno certificato le capacità anticancro, i benefici che può recare a chi soffre di diversi disturbi mentali e neurologici come di dolori cronici e altro ancora. I cannabinoidi contenuti nella cannabis si sono dimostrati versatili ed efficaci, senza provocare i pesanti effetti collaterali dei rimedi già in uso per le stesse necessità.
Nonostante queste virtù siano riconosciute e certificate anche da recenti ricerche, sono pochissimi i farmaci disponibili che contengono tetraidrocannabinolo (o THC), la sostanza psicoattiva prodotta dalla cannabis, e sono “dedicati” e testati per la cura di patologie specifiche. Pensando agli Stati Uniti e alle strette limitazioni imposte dalla Food & Drug Administration (FDA) al commercio di cibi e medicinali, c'è da stupirsi per la procedura che ha portato la marijuana a diventare ufficialmente un farmaco.
La marijuana medica è diventata tale a furor di popolo, attraverso referendum o decisioni degli organi legislativi, la FDA non ne ha affatto regolamentato l'uso o la vendita e le procedure stabilite per la sua somministrazione sono tanto aleatorie quanto lontane dal poter essere scambiate per un protocollo terapeutico. Non esistono indicazioni sulla posologia e nemmeno metodi d'assunzione raccomandati, anche se il più innocuo e apprezzato è sicuramente quello attraverso i vaporizzatori che, evitando la combustione e suoi prodotti tossici, assicurano l'effetto terapeutico e l'assunzione del principio attivo, buoni anche per l'uso ricreativo.
Molti altri stati stanno pensando d'introdurre l'uso terapeutico della marijuana e c'è un grande consenso popolare per questo genere di misure. Recentemente, in New Hampshire è stata bloccata una proposta del genere dal veto del governatore, siamo già al secondo tentativo e per poco non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi nelle due camere (76,6% alla Camera e 58,3% al Senato), ma in genere la tendenza indica una rapida espansione nella maggior parte degli stati federati.
Questo procedere disordinato in realtà è figlio del fallimento ufficiale della famosa “War on Drugs”, una guerra costata miliardi di dollari che non ha scalfito minimamente il traffico internazionale di droghe e che negli ultimi anni, in silenzio e senza attirare grande attenzione, è stata dichiarata persa e finita. Una presa di coscienza che non poteva che comportare un ripensamento drastico delle politiche antidroga, già minate dalla realtà. Prima ancora, il fallimento della War on Drugs aveva già comportato una depenalizzazione di fatto del commercio di marijuana, visto che in molti stati i procuratori scrivevano chiaro e tondo che non avrebbero perseguito chi fosse stato trovato in possesso di meno di duecentocinquanta chilogrammi. Meglio concentrare gli sforzi sui traffici di cocaina e metanfetamine, che hanno inondato il mercato a dispetto di qualsiasi contrasto. In molti stati la diffusione di migliaia di laboratori domestici per la produzione di droghe sintetiche ha reso incongrua e inutile la caccia alla marijuana anche agli occhi dei conservatori.
In un quadro del genere, vietare l'uso medico della marijuana è ancora più assurdo che vietarne il consumo ricreativo e chi ha provato questa via traversa per aggirare il perbenismo formale dei legislatori, è stato premiato dal successo e dal consenso popolare. Una volta aperti i “dispensari” legali di marijuana ad uso medico e concesso l'accesso alla “cura” dietro la semplice indicazione di un medico, i dispensari sono diventati migliaia e le persone in cura tantissime. La vaghezza legislativa si è resa necessaria in presenza di leggi federali repressive; gli stessi medici sono stati autorizzati a prescrivere informalmente la marijuana ai pazienti evitando i ricettari, perché una prescrizione con tutti i crismi potrebbe diventare la prova per un'accusa federale. Con queste premesse e la quantità di patologie che in teoria beneficiano del THC, i malati si sono moltiplicati esponenzialmente.
Una rivista alternativa di Denver ha cercato un recensore specializzato in marijuana medica. Il discorso non fa una piega, se c'é un mercato è normale che ci sia chi riferisce di questo mercato per orientare i consumatori, anche perché i “dispensari” possono avere qualsiasi forma, dagli antri iper-giovanili tappezzati di poster di Bob Marley fino al luogo asettico d'ispirazione ospedaliera. Poi ci sono le diverse varietà di medicamento, con un’offerta che spazia per oltre quindici varietà d'erba a larga diffusione e numerose produzioni di nicchia.
Per cercare di chiudere qualche incongruenza, il Dipartimento di Giustizia ha ordinato ai procuratori federali di evitare procedimenti contro i consumatori di marijuana medica in regola con la legislazione degli stati d'appartenenza. Una decisione di segno “federalista”, ma soprattutto un evidente viatico alla situazione che si è venuta a creare nella realtà. Una realtà sfumata da Stato a Stato nella quale, come in Europa, si passa da stati nei quali l'uso della marijuana può essere legale, decriminalizzato, illegale e non perseguito o assolutamente illegale e ora priva del cappello federale criminalizzante.
Una situazione che giustamente alcuni commentatori conservatori hanno definito un insulto all'intelligenza; proprio da costoro è venuta la richiesta di aprire un dibattito serio sulla legalizzazione. Una richiesta incredibile fino a pochi anni fa, per questo la dimostrazione più tangibile del fatto che i tempi siano politicamente maturi per chiudere il secolo della paranoia contro la canapa. Oggi l'ipotesi appare plausibile, tanto che la California di Schwarzenegger, repubblicano atipico, sta pensando ad alta voce alla legalizzazione della canapa con un occhio ai proventi che deriverebbero dalla sua tassazione, un toccasana per le casse di uno stato sull'orlo del fallimento e anche un brutto colpo alle gang messicane che ormai hanno tracimato negli States con tanto di piantagioni.
Un discreto caos dal quale si stano giovando indubbiamente i consumatori, ma un caos che in qualche maniera dovrà essere risolto, sia per rimuovere l'insulto all'intelligenza che per offrire un quadro certo e verificato all'impiego terapeutico del THC. Una soluzione che non potrà che includere la legalizzazione dell'uso ricreativo, lo studio e l'introduzione di protocolli terapeutici per il suo uso medico e in genere la liberalizzazione della produzione della canapa negli Stati Uniti. Una soluzione che sicuramente ha ancora parecchi feroci oppositori, in particolare in alcuni settori economici, ma che può contare oggi su una platea molto più vasta di sostenitori e su alcuni alleati anche tra i conservatori.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Emanuela Pessina
di Emanuela Pessina
BERLINO. I socialdemocratici tedeschi hanno annunciato grandi cambiamenti per il prossimo congresso di partito, previsto a Dresda (nel nord della Germania) tra il 12 e il 15 novembre: si parla addirittura di una sostituzione completa delle maggiori personalità politiche interne. Se questo passo aiuterà a redimere le sorti della Spd, in forte crisi dopo i disastrosi risultati delle elezioni 2009, è tutto da vedere. E, al riguardo, si è interrogato anche Thomas Steg, portavoce ufficiale del governo dal 2002 al 2009 e consigliere dell’ex-vicecancelliere Frank-Walter Steinmeier (Spd).
In un articolo apparso sul quotidiano di sinistra tedesco Tageszeitung (taz) di ieri, Steg ha affermato che “il cambio di guardia annunciato dall’Spd non verrà ricordato nella storia come una vera e propria cesura”, anche se si è trattato, ha ammesso, di un "passo inevitabile”. Secondo Steg, inserire nuove personalità nella rosa dei socialdemocratici non può, di per sé, bastare alla salvezza dei socialdemocratici: la rovina della Spd è stata “lenta e annunciata” e per risalire è necessario un lavoro duro e costante.
Steg, tuttavia, non si è limitato a commentare l’annunciato cambio di guardia: nel suo articolo ha proposto anche un’analisi approfondita della crisi dell’Spd, l’unica certezza del momento. Più che come un fenomeno nuovo e inaspettato, il politico ha presentato la difficile situazione attuale come il “risultato di tendenze concomitanti che agiscono da molto tempo”. In particolare, Steg ha proposto una lettura chiara e disincantata delle cause della miseria in cui è caduta l’Spd.
“La delimitazione contraddittoria dell'Spd dal partito di sinistra, la mancanza di una prospettiva di maggioranza durante la campagna elettorale e la linea strategica poco chiara, sono soltanto alcune delle sfaccettature del dilemma dell’Spd”, ha sottolineato Steg. Il vero problema è piuttosto “il profondo estraniamento che l’Agenda 2010 ha provocato negli elettori tradizionali dell’Spd”, ha precisato Steg, riferendosi al pacchetto di riforme strutturali proposte da Gerhard Schröder di recente. Un tradimento, in un certo senso, delle aspettative degli elettori. Per un'analisi approfondita di queste teorie, comunque, Steg rimanda a un saggio di Stephan Meise apparso di recente in un libro edito in lingua tedesca da Heiko Geiling, dedicato interamente alla crisi del partito, “Die Krise der Spd”.
La crisi della Spd, in effetti, non è mai stata così profonda come quella attuale. Le elezioni del 2009 hanno fatto registrare un crollo di consensi, per i socialdemocratici, dell’11,2% rispetto al 2005 e del 15,5% rispetto al 2002; risultati che non sono bastati a garantire al partito nessun ruolo nella maggioranza. Dopo undici anni di governo, la Spd del candidato-cancelliere socialdemocratico Steinmeier si sta trovando a doversi costruire un nuovo ruolo tra le fila dell’opposizione.
Un ruolo, per la Spd, molto difficile anche solo da immaginarsi. E lo ha notato anche la Linke, il partito di estrema sinistra che ha conquistato un inaspettato successo alle recenti elezioni. Secondo quanto riportato dal Taz, infatti, il presidente della frazione della Linke, Petra Pau, ha annunciato che “non c’è coalizione nell’opposizione” in quanto “l’Spd non si è ancora abituata al suo nuovo ruolo“. Visti gli esordi, c’è d’aspettarsi che la Linke non mancherà di far valere il suo recente successo elettorale, non ammorbidendo certo la strada già in salita dei socialdemocratici.
Per questi ultimi, d'altra parte, non sarà certo facile dimenticare le numerose voci di corridoio secondo cui molti nuovi elettori della Linke, il partito del famoso fuoriuscito dalle fila dell'Spd, Oskar Lafontaine, provengono proprio dai delusi della Spd, il partito che (agli occhi degli elettori) non è riuscito ad affrontare in modo soddisfacente la crisi economica. Anche perché la Linke, nelle recenti elezioni, ha ottenuto un aumento addirittura del 7,9% rispetto al 2002, guadagnandosi un peso non indifferente all'interno del Bundestag tedesco. Un travaso di voti, quello dalla Spd verso la Linke, che rischia di divenire un passaggio delle consegne.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Luca Mazzucato
di Luca Mazzucato
NEW YORK. È sempre stata consuetudine per l'esercito americano obbedire agli ordini della Casa Bianca, ma ora non più. Una fronda interna al Pentagono è uscita allo scoperto e da qualche mese cerca di forzare la mano ad Obama per ottenere un aumento delle truppe in Afghanistan. Il presidente invece attende la riconferma di Karzai al ballottaggio. Rinforzi subito, rinforzi in seguito o invece iniziare la ritirata? Mentre la campagna militare in Afghanistan ricorda sempre più quella in Vietnam, la vera battaglia si gioca a Washington.
La situazione sul campo in Afghanistan e in Pakistan sta precipitando. Quasi ogni giorno autobombe o kamikaze mietono decine e centinaia di vittime e i Talebani, che ormai controllano gran parte dell'Afghanistan, portano gli attacchi fin nei luoghi “sicuri” nel centro di Kabul. Il numero di vittime per mese tra i soldati americani è il più alto dall'inizio dell'invasione, otto anni fa. La guerra costa sessantacinque miliardi di dollari all'anno, che gravano su un bilancio federale disastrato. I sondaggi rivelano che, per la prima volta dal 2001, la maggioranza degli americani è favorevole ad un ritiro, e la tendenza è in aumento.
Il presidente Obama ha assunto la posizione del grande “cunctator,” temporeggiando per mesi in attesa di elaborare una nuova strategia in Afghanistan. Secondo Obama la guerra in Afghanistan è il vero perno della strategia americana contro il terrorismo. Inizialmente favorevole ad un'escalation, Obama ha bloccato i propri piani a causa del fallimento delle elezioni presidenziali, che hanno prima dato Karzai come vincitore per poi essere annullate a causa di brogli massicci. In attesa del ballottaggio di Novembre per sapere chi sarà il “sindaco di Kabul,” Obama non vuole prendere alcuna decisione.
In questo quadro, il comandante delle forze americane in Afghanistan, Stanley McChrystal, sta facendo carte false per convincere gli alleati della NATO ad appoggiare l'invio di altre ottantamila truppe nel paese asiatico. La scorsa settimana, il generale si è presentato alla riunione NATO in Slovacchia per battere cassa, ottenendo il sì all'escalation da parte di quasi tutti gli alleati (tranne Olanda e Danimarca). Scavalcando la catena di comando e intromettendosi nell'arena politica a gambe tese.
Secondo una recente inchiesta di Rolling Stones, il fatto che McChrystal stia cercando di mettere Obama all'angolo e costringerlo ad approvare l'escalation è infatti tutta politica e non militare. In vista delle primarie per le presidenziali del 2012, il comandante in capo dell'esercito generale David Petraeus sta affilando i coltelli per una partenza in pole position. Petraeus, l'artefice dell'escalation in Iraq che nel 2007 portò ad una temporanea stabilizzazione del conflitto grazie all'invio di ventimila nuove truppe, vuole fare il bis in Afghanistan.
In settembre, per tastare il terreno, fonti vicine a Petraeus fecero filtrare alla stampa un rapporto del Pentagono altamente riservato nel quale si prediceva una chiara sconfitta in mancanza di una vasta escalation. A quel punto, il generale McChrystal cominciò ad apparire sui principali network, chiedendo più truppe e contraddicendo il vicepresidente Joe Biden, il cui piano punta a sostituire i soldati americani con il nuovo esercito afghano e puntare sulla controinsurrezione. Con il fuoco repubblicano a coprirgli le spalle, Petraeus sarebbe deciso a riscuotere il grande consenso di cui gode tra il pubblico in sonante moneta elettorale.
Obama è intrappolato tra i suoi generali da una parte e la base democratica dall'altra. Molti senatori e deputati progressisti hanno lanciato una campagna per il ritiro dall'Afghanistan. Gli elettori democratici sono in stragrande maggioranza favorevoli al ritiro ed è ormai chiaro che Obama si è messo in una posizione estremamente imbarazzante. Mentre la pressione dell'esercito aumenta, se Obama rifiutasse l'aumento di truppe chiesto da McChrystal offrirebbe il fianco alla litania repubblicana di essere “tenero sul terrorismo,” in vista delle elezioni di medio termine dell'anno prossimo.
Se Obama approvasse l'escalation, la massiccia presenza militare americana si prolungherebbe di molti anni, mentre i primi eventuali risultati non si vedrebbero per almeno un anno, secondo le analisi del Pentagono. Un risultato comunque tardivo per le elezioni di medio-termine e possibilmente disastroso per la corsa alla rielezione nel 2012. Se Obama appoggiasse l'escalation, infatti, si assumerebbe la piena responsabilita' di una eventuale futura sconfitta.
L'alternativa all'escalation, che Joe Biden sta elaborando e a cui il Pentagono si oppone, prevede la riduzione delle operazioni di fanteria e della presenza di truppe americane sul territorio, in favore dell'uso di “droni” telecomandati (per diminuire i morti tra i soldati, a scapito delle vittime civili) e della strategia della “controinsurrezione,” ovvero operazioni mirate contro membri di Al Qaeda e non contro le milizie talebane.
Ma l'assunzione alla base di questa nuova strategia é la distinzione netta tra l'attivita' di resistenza dei Talebani da una parte (che verrebbero gradualmente coinvolti nella ricostruzione dello stato afghano, come le varie milizie in Iraq) e i gruppi della jihad internazionale dall'altra, attivi soprattutto al confine con il Pakistan. Sottigliezze diplomatiche difficili da sostenere sui network televisivi, dove la propaganda repubblicana tritatutto continua a sostenere che Obama stesso é un pericolo per la sicurezza nazionale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
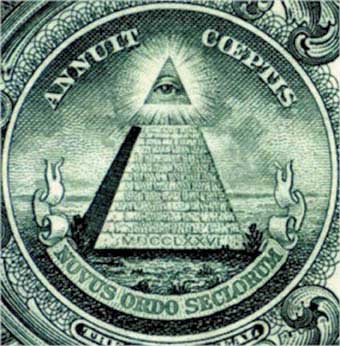 di Michele Paris
di Michele Paris
Con un tasso ufficiale di disoccupazione salito al 9,8% nel mese di settembre, i salari in discesa e l’accesso al credito ancora complicato, negli Stati Uniti il livello della spesa privata ha fatto segnare nel secondo trimestre del 2009 una riduzione vicina al 2% su base annua. Una contrazione ragguardevole alla luce delle abitudini degli americani e di un dato che nell’ultimo ventennio aveva fatto segnare aumenti annuali mediamente superiori al 3%.
Se i cittadini comuni e le piccole aziende hanno dovuto necessariamente stringere i cordoni della borsa per far fronte agli effetti della crisi finanziaria, altrettanto non si può dire per le grandi compagnie e le loro associazioni, le quali nell’anno in corso hanno fatto registrare, al contrario, un considerevole incremento dei loro investimenti nelle attività di lobbying per influenzare a Washington un’agenda legislativa densa di questioni importanti per il loro futuro.
Il primato degli esborsi, come di consueto, va alla Camera di Commercio degli Stati Uniti (USCC), capace di spendere ben 35 milioni di dollari tra luglio e settembre. Una cifra enorme che va ad aggiungersi ai 17,5 milioni già stanziati nel corso dei primi sei mesi dell’anno. L’accelerazione nel ritmo della spesa nell’ultimo periodo di un organismo che rappresenta più di tre milioni di imprese in America corrisponde, in sostanza, all’attività del Congresso, dove a partire dall’estate hanno preso la strada dell’approvazione definitiva numerosi provvedimenti di legge in discussione da mesi. Gli investimenti del 2009 della USCC in questo ambito, d’altra parte, risultano tanto più ingenti quanto sono stati parzialmente inefficaci quelli dello scorso anno, effettuati direttamente a favore delle campagne elettorali di candidati repubblicani.
I lobbisti al soldo della Camera di Commercio americana si sono concentrati in particolare sulla battaglia per la riforma sanitaria. Obiettivo principale, naturalmente, è quello di evitare che nel progetto di legge tuttora allo studio finisca per essere incluso un piano pubblico alternativo a quelli privati, molto temuto perché produrrebbe una maggiore concorrenza sul mercato delle assicurazioni sanitarie. Per le aziende rappresentate dalla USCC, però, le leggi dalle quali potrebbero ottenere condizioni di favore sono anche quelle che riguardano la riduzione delle emissioni in atmosfera e la riforma del sistema finanziario.
Tutti temi ugualmente cari anche all’associazione delle industrie manifatturiere (NAM), che raccoglie 14 mila aziende di vari settori in ciascuno dei 50 stati americani ed è guidata dall’ex governatore repubblicano del Michigan, John Engler. La NAM è passata così da circa un milione di dollari spesi nel secondo trimestre del 2009 per rappresentare i propri interessi nella capitale ad addirittura 5,8 milioni negli ultimi tre mesi. Particolarmente sentiti per gli industriali d’oltreoceano sono le questioni legate al carico fiscale e alla sindacalizzazione dei lavoratori dipendenti, facilitata dalla possibile approvazione di un disegno di legge (EFCA) da tempo fermo al Senato dopo l’OK della Camera dei Rappresentanti.
Il calendario legislativo influenza dunque in maniera inevitabile le strategie delle associazioni e delle singole aziende toccate dai cambiamenti che si prospettano per loro nel prossimo futuro. Per oliare i meccanismi decisionali nei momenti critici, ecco giungere allora sulle migliaia di lobbisti registrati a Washington una pioggia di dollari per ottenere in cambio provvedimenti modellati in base agli interessi dei poteri forti. Significativo in questo senso è lo sforzo sostenuto dall’associazione degli immobiliaristi americani (NAR), la quale, sempre nel terzo trimestre dell’anno, ha sborsato 4,2 milioni di dollari per convincere il Congresso ad estendere il credito d’imposta previsto per gli acquirenti di immobili.
Legge sul cambiamento climatico e riforma sanitaria, oltre ad essere due terreni di scontro politico trasversale, hanno anche contribuito notevolmente ad arricchire le casse della cosiddetta “K Street”, cioè delle compagnie di lobby, molte delle quali hanno sede proprio sull’omonima strada della capitale. Il primo provvedimento, approdato in questi giorni ad una commissione del Senato in vista del summit di dicembre sul clima a Copenhagen, ha determinato una spesa in attività di lobbying da parte dell’Edison Electric Institute (EEI) – organismo che cura gli interessi dei fornitori di energia elettrica – di circa 8 milioni di dollari nel corso del 2009, una cifra superiore già di un terzo rispetto a quanto investito durante tutto il 2008. Superiore quasi di tre volte rispetto all’anno scorso è stata la somma stanziata (2,7 milioni di dollari) per intervenire nello stesso ambito dall’American Petroleum Institute (API), l’associazione dell’industria petrolifera americana.
Per plasmare una riforma del sistema sanitario in base ai propri interessi, invece, la potentissima Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) ha speso nel 2009, finora, 6,8 milioni di dollari, a fronte dei 5,4 milioni del 2008. Questa associazione, il cui attuale presidente è l’ex deputato repubblicano della Louisiana Billy Tauzin, rappresenta molte compagnie operanti nel settore parafarmaceutico e delle biotecnologie e qualche mese fa aveva stipulato con la Casa Bianca un accordo per garantire un risparmio di 80 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni alle casse pubbliche nell’ambito della nascente riforma sanitaria. Un accordo criticato dai parlamentari democratici che hanno accusato PhRMA di essersi così messa al sicuro da ulteriori tagli ai rimborsi dei medicinali da parte del governo federale eventualmente previsti dal provvedimento finale che sarà licenziato dal Congresso.
Nonostante il terzo trimestre dell’anno comprenda il mese di agosto, per gran parte del quale il Congresso sospende le proprie attività, l’incremento medio delle spese a favore dei lobbisti di Washington si è verificato proprio in questo periodo dell’anno. Un segnale questo dell’ansia diffusa nell’élite industriale e finanziaria americana nel momento in cui si è iniziato a decidere del destino di svariati progetti voluti dalla nuova amministrazione. Analizzando i dati tuttavia si trovano anche singole grandi aziende che hanno sensibilmente ridotto gli investimenti destinati alla difesa dei propri interessi nell’arena politica. Anche in questo caso, però, l’andamento della spesa sembra rispecchiare la cadenza delle decisioni prese nella capitale, piuttosto che il riflesso di difficoltà prodotte dalla crisi economica.
È il caso, ad esempio, della General Motors, protagonista di una spesa pari a 2,7 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2008 quando infiammava ancora il dibattito intorno al suo fallimento e al conseguente salvataggio da parte del governo federale. Una volta avviata la procedura di bancarotta controllata e assicurato l’intervento governativo, poche settimane dopo l’insediamento alla Casa Bianca di Barack Obama, la compagnia di Detroit ha praticamente chiuso i rubinetti di spesa alla voce lobbying. Tanto che nei tre mesi che vanno da luglio a settembre 2009 la General Motors per questa voce di bilancio ha speso “appena” 180 mila dollari.
