- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato con 186 voti a favore, due contrari e due astenuti, il blocco statunitense contro Cuba. Per la ventesima volta, i governi di tutto il mondo hanno ribadito l’inaccettabilità, sul piano del diritto internazionale, dell’aspetto palese della guerra di Washington contro L’Avana. Per la ventesima volta, da quando, nel Novembre del 1992, venne calendarizzata nei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, la mozione presentata da Cuba, dal titolo “Necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America contro Cuba” ha rappresentato quindi una sonora sberla per la politica statunitense.
I voti contrari sono stati quelli degli Stati Uniti e Israele, mentre gli astenuti sono le Isole Marshall, Micronesia e Palau; se si accantona il giudizio sull’autonomia e lo spessore politico dei tre isolotti, il voto statunitense e israeliano sembra sinistramente suonare come una conferma indiretta del fatto che il blocco sia in primo luogo una violazione gigantesca dei diritti umani, oltre che una mostruosità giuridica.
Gli Stati Uniti, nel tentativo di difendere l’indifendibile, hanno sostenuto che il blocco è in realtà un embargo e che, come tale, è una scelta di politica interna statunitense, con ciò indicando una supposta inabilità dell’Onu al giudizio. Ma è facile constatare come la pretesa nordamericana sia del tutto fuori luogo. Perché se pure è vero che la scelta d’istituire il blocco è frutto di scelte di politica interna statunitense, le innumerevoli conseguenze dello stesso riguardano invece l’intera comunità internazionale, colpita dall’extraterritorialità delle disposizioni previste dalle leggi Torricelli e Helms-Burton, che sono la cornice giuridico-legislativa all’interno della quale l’aggressione all’isola caraibica si estende anche al resto della comunità internazionale. La legge Torricelli e la Helms-Burton hanno infatti esteso all’intera comunità internazionale il blocco Usa contro Cuba, azzerandone così qualunque dimensione bilaterale per trasformarla in questione internazionale.
Proprio quindi per la sua extraterritorialità, oltre che per l’ossessivo minuzioso dettaglio delle sanzioni (a Cuba e a terzi) oggetto dei numerosi dispositivi ad esse collegate, definire il blocco come embargo è falso; come minimo è perniciosamente riduttivo, incongruo rispetto alle dimensioni, la durata e l’extraterritorialità dei provvedimenti e alle conseguenze che ha provocato e che provoca tanto all’isola come al resto della comunità internazionale. E il fatto che le misure siano prese ai danni di un paese con il quale formalmente non vige uno stato di guerra, rende il tutto solo più vigliacco, vergognoso e ingiustificabile. Per i suoi obiettivi, per la sua portata e per i mezzi impiegati per ottenerli, il blocco degli Stati Uniti contro Cuba si qualifica come un atto di genocidio in base a ciò che sancisce la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948, e come un atto di guerra economica, in base alla Conferenza Navale di Londra del 1909.
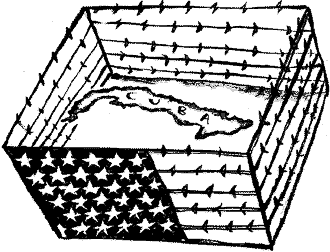 L’embargo, infatti, è solitamente usato come misura esclusivamente commerciale a carattere temporaneo, mentre nel caso di Cuba il blocco si regge su un insieme di leggi, decreti presidenziali e misure amministrative interne ed estere che comportano una guerra di tipo politico, commerciale, finanziario e giuridico sull’intero teatro internazionale, cui si aggiungono operazioni d’intelligence, militari e di sostegno diretto e dimostrato ad attività terroristiche. E anche sotto il profilo riguardante le operazioni commerciali e finanziarie, si deve ricordare che qualunque paese al mondo che intrattenga relazioni finanziarie e commerciali con Cuba viene coinvolto.
L’embargo, infatti, è solitamente usato come misura esclusivamente commerciale a carattere temporaneo, mentre nel caso di Cuba il blocco si regge su un insieme di leggi, decreti presidenziali e misure amministrative interne ed estere che comportano una guerra di tipo politico, commerciale, finanziario e giuridico sull’intero teatro internazionale, cui si aggiungono operazioni d’intelligence, militari e di sostegno diretto e dimostrato ad attività terroristiche. E anche sotto il profilo riguardante le operazioni commerciali e finanziarie, si deve ricordare che qualunque paese al mondo che intrattenga relazioni finanziarie e commerciali con Cuba viene coinvolto.
Se, infatti, una qualunque impresa, di qual si voglia paese, dispone di filiali o consociate nel territorio statunitense o, comunque, realizza iniziative imprenditoriali con imprese statunitensi, ove commerci anche con Cuba rischia di vedersi congelati i fondi e persino l’arresto dei suoi manager (legge Helms-Burton). Dunque, l’unico elemento di verità nelle dichiarazioni statunitensi è che il blocco è un insieme di leggi, norme e disposizioni interne degli Stati Uniti e, in questo senso, il fatto che si estendano al resto del mondo non ne muta la genesi; ma l’originaria disposizione di embargo decisa da Kennedy nel 1962 con il Proclama 3447, che ampliò le restrizioni commerciali varate da Eisenhower nell'ottobre 1960, è profondamente mutata nel corso dei decenni, assumendo un’aperta ed illegale connotazione extraterritoriale che la connota da anni come un fulgido esempio di pirateria internazionale. Questo per sottolineare la coerenza nei difensori del libero scambio..
Sull’aspetto interno agli Usa del blocco contro Cuba ci si potrebbe chiedere perché, dati i cinquanta e passa anni di vigenza del blocco e reiterata la sua inutilità nei confronti dei fini dichiarati, procedere ancora, infischiandosene della mancanza di risultati e persino della riprovazione internazionale oltre che dei danni provocati alle stesse imprese Usa che si vedono private di relazioni commerciali in un’area territorialmente vicina? Perché - e questo è l’unico elemento di verità nella posizione Usa - il blocco contro Cuba rappresenta sì un aspetto importante della politica interna: la vittoria elettorale in Florida, stato decisivo per le elezioni alla Casa Bianca, è legata al livello di alleanza tra i due partiti con la lobby terroristico-mafiosa cubano-americana con sede a Miami. E le centinaia di milioni di dollari veicolati dalla NED, dall’USAID e dalla stessa CIA che corrono sull’onda dei progetti spionistici contro Cuba definiti elegantemente come “fondi per la democrazia a Cuba”, fanno gola al piccolo esercito di politici e affaristi della Florida che ne utilizzano buona parte per incrementare i loro collegi elettorali.
Ma non si tratta solo di questo. Ad un livello diverso, peraltro maggiormente preoccupante, risulta ulteriormente determinante nel mantenimento del blocco l’intreccio ricattatorio tra le agenzie militari e spionistiche statunitensi e le organizzazioni terroristiche dei fuoriusciti cubani, manovalanza storica delle covert action degli Stati Uniti in Centro e Sud America. Un’eventuale inversione di rotta degli Usa che riportasse l’interesse nazionale al centro della politica regionale, comporterebbe in automatico una presa di distanza dal conglomerato blocco terroristico-mafioso cubano-americano, il quale non esiterebbe a reagire, scoperchiando il velo di segretezza che copre le nefandezze spionistiche e terroristiche di Washington nel continente e non solo. Dallas ha insegnato qualcosa.
D’altra parte, le organizzazioni dei fuoriusciti cubani rappresentano la manovalanza più affidabile per le operazioni segrete proprio perché l’intreccio di convenienza reciproca - che vede la loro sopravvivenza come risultato della benevolenza della Casa Bianca e di Langley - si sposa perfettamente con la convenienza del governo Usa nell’utilizzo della manovalanza terroristica per le sue politiche di “contenimento del comunismo”, come definiva eufemisticamente Kissinger operazioni come il colpo di stato in Cile. Difficilissimo rompere quel vincolo senza prima ripensare una linea politica che non scambi gli interessi statunitensi di dominio dell’area con una politica regionale di dialogo e integrazione. Fantascienza allo stato attuale.
 E a rappresentare anche simbolicamente la relazione tra la politica estera della Casa Bianca e i gusanos di Miami, c’è (tra gli altri) Ileana Ros-Lehtinen, detta “la lupa feroce”. Nota per non essere proprio una cima, è esponente della destra più oltranzista, amica del golpista hondureno Micheletti e amica intima e sostenitrice del terrorista Luis Posada Carriles, definito negli Usa il “bin Ladin delle Americhe”. Proprio in virtù di quest’amicizia, la Lehtinen è stata anche la presidentessa d’onore del “Fondo Legale Luis Posada Carriles”, nato con l’obiettivo di riscuotere fondi per il terrorista che organizzò l’attentato contro un aeroplano civile cubano dove morirono 73 persone.
E a rappresentare anche simbolicamente la relazione tra la politica estera della Casa Bianca e i gusanos di Miami, c’è (tra gli altri) Ileana Ros-Lehtinen, detta “la lupa feroce”. Nota per non essere proprio una cima, è esponente della destra più oltranzista, amica del golpista hondureno Micheletti e amica intima e sostenitrice del terrorista Luis Posada Carriles, definito negli Usa il “bin Ladin delle Americhe”. Proprio in virtù di quest’amicizia, la Lehtinen è stata anche la presidentessa d’onore del “Fondo Legale Luis Posada Carriles”, nato con l’obiettivo di riscuotere fondi per il terrorista che organizzò l’attentato contro un aeroplano civile cubano dove morirono 73 persone.
La signora Lehtinen, eletta nel Partito Repubblicano con il voto della lobby cubano-americana, negli ultimi giorni ha chiesto a Obama rispettivamente di: bombardare Cuba come la Libia; proibire l’esibizione negli Usa della compagnia teatrale di bambini “La Colmenita” di Cuba, definendo i piccoli attori come “spie di Castro”; minacciare la Spagna per la presenza della Repsol nelle perforazioni petrolifere a Cuba.
L’equilibrio mentale della signora è da sempre oggetto di curiosità tra gli osservatori politici negli Stati Uniti, ma forse non è un caso che sia diventata Presidente della Commissione Esteri del Congresso Usa, riferendo in ciò implicitamente il valore assoluto dell’istituzione legislativa statunitense. Il blocco contro Cuba, che é nato, vive e prospera nel rapporto torbido che intercorre tra terroristi cubano-americani e Casa Bianca, trova nel ruolo della signora Lehtinen una sintesi simbolica perfetta.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
In queste ore rappresentanti del Quartetto (Nazioni Unite, Stati Uniti, Russia ed Unione Europea) si sta esercitando in una prima tornata di incontri indiretti con Israeliani e Palestinesi. Secondo Tony Blair, discusso inviato speciale del Quartetto, non si tratta nemmeno di “proximity talks”, ovvero di negoziati condotti bilateralmente per il tramite di un mediatore, quanto piuttosto di un banco di prova per sondare le differenze tra le proposte dei due contendenti e verificare se esista o meno lo spazio di agibilità politica per colmarlo.
L’obiettivo degli incontri di ieri, come spiegato da Blair al Los Angeles Times in un’intervista pubblicata l’altro ieri notte, è di trovare un accordo che preveda la stesura di un piano condiviso su confini e sicurezza da rendere operativo entro i prossimi tre mesi. “Una volta studiata la proposta sui confini, vedremo quanto sono distanti le posizioni”. Peccato però che i palestinesi, già dai tempi dei negoziati di Annapolis (2008), abbiano fatto una loro proposta sui confini e su eventuali scambi di terre con gli israeliani; mentre ad oggi non sembra sia ancora pervenuta la controfferta di questi ultimi.
La notizia del coinvolgimento di mediatori esterni e la possibilità che si apra una nuova stagione di negoziati è positiva, anche considerando che a mettere in moto questo processo è stata la “corsa” di Abbas alle Nazioni Unite per ottenere il riconoscimento della Palestina come stato membro, o - nella peggiore delle ipotesi - come osservatore (come il Vaticano). Tuttavia, sul buon esito del processo pesa inevitabilmente l’ipoteca costituita dalla liberazione di Gilad Shalit, che ha fortemente indebolito Al-Fatah a vantaggio di Hamas.
 Nell’intervista di ieri Edmund Sanders, caporedattore da Gerusalemme, ha messo sotto torchio Blair, sottoponendolo ad un fuoco di fila di domande, alcune delle quali allusive e una decisamente imbarazzante. Le impressioni ricavate a caldo dalla viva voce dell’inviato speciale del Quartetto non sono molto confortanti. Sanders provoca Blair sulla mancanza d’incisività del Quartetto: “Chiedete agli israeliani di bloccare gli insediamenti e si continua a costruire; pregate i palestinesi di riprendere la trattativa e loro non ne vogliono sapere; come mai la credibilità del Quartetto è così bassa?”.
Nell’intervista di ieri Edmund Sanders, caporedattore da Gerusalemme, ha messo sotto torchio Blair, sottoponendolo ad un fuoco di fila di domande, alcune delle quali allusive e una decisamente imbarazzante. Le impressioni ricavate a caldo dalla viva voce dell’inviato speciale del Quartetto non sono molto confortanti. Sanders provoca Blair sulla mancanza d’incisività del Quartetto: “Chiedete agli israeliani di bloccare gli insediamenti e si continua a costruire; pregate i palestinesi di riprendere la trattativa e loro non ne vogliono sapere; come mai la credibilità del Quartetto è così bassa?”.
La risposta diplomatica di Blair conferma l’alta opinione che di sé hanno i rappresentanti del quartetto, evidentemente convinti che la via della pace passi necessariamente attraverso il loro intervento: “Non esiste alcuna altra entità che consenta al processo di essere gestito in modo intelligente dagli attori chiave”. Una delle ragioni della sua impotenza, per inciso, è il fatto che, come ammette lo stesso Blair, il Quartetto può “fare pressione, tentare di convincere, perfino allettare le parti in causa”; ma di sicuro non ha alcuna possibilità di sanzionarli se non si attengono a quanto richiesto.
Se è vero che il Quartetto rappresenta l’unica speranza di salvezza i due popoli, c’è poco da stare allegri. Qui Sanders ha gioco facile, ricordando a Tony Blair come i quattro componenti si siano scannati per mesi tra loro nel vano tentativo di mettere a fuoco una posizione comune sui punti chiave, “confini”, “rifugiati”, “capitale a Gerusalemme Est” e “Israele come Stato Ebraico”. Come fa il Quartetto a catalizzare i negoziati di pace se non riesce nemmeno a mettere a punto una posizione comune proprio sui temi su cui si propone come intermediario esclusivo? Francamente, è di poco conforto apprendere da Blair che “a settembre a New York si è stati vicini a un accordo sui parametri, ma non è stato possibile comporre alcune divergenze”.
 Sanders, infine, solleva il tema dell’adeguatezza della figura di Tony Blair quale inviato speciale del Quartetto. Se non bastasse il grave deterioramento della sua immagine, inevitabilmente legata alla guerra in Iraq, ci sono ragioni di buon senso che gli consiglierebbero di fare un passo indietro. In particolare il suo ruolo di consulente della banca d’affari JP Morgan, che tende a sovrapporsi pesantemente agli obblighi derivanti dal suo impegno di “uomo di pace” in Medio Oriente. Il giornalista del LA Times fa esplicitamente riferimento al ruolo presumibilmente avuto da Blair nel favorire Wataniya, una società di telefonia mobile di proprietà di società del Qatar e del Kuwait, e la British Gas.
Sanders, infine, solleva il tema dell’adeguatezza della figura di Tony Blair quale inviato speciale del Quartetto. Se non bastasse il grave deterioramento della sua immagine, inevitabilmente legata alla guerra in Iraq, ci sono ragioni di buon senso che gli consiglierebbero di fare un passo indietro. In particolare il suo ruolo di consulente della banca d’affari JP Morgan, che tende a sovrapporsi pesantemente agli obblighi derivanti dal suo impegno di “uomo di pace” in Medio Oriente. Il giornalista del LA Times fa esplicitamente riferimento al ruolo presumibilmente avuto da Blair nel favorire Wataniya, una società di telefonia mobile di proprietà di società del Qatar e del Kuwait, e la British Gas.
Il caso Wataniya è abbastanza spinoso: sembra infatti che Blair abbia fatto pressioni sul governo israeliano per far liberare delle frequenze che sarebbero poi state utilizzate dalla società di telefonini della penisola arabica e, si dice, cara a Abbas e affini. Secondo la ricostruzione dei fatti fatta da Reuters, ben 16 milioni di dollari di aiuti, originariamente destinati a piccole attività agricole e artigianali palestinesi, sarebbero state dirottati sulla società mediorientale, che per inciso era cliente di JP Morgan (anche se c’è chi non manca di ricordare che Blair sia consulente anche del Governo del Kuwait, che controlla indirettamente il 24% del capitale di Wataniya).
Vero è che anche restavano altri fondi per gli scopi suddetti, e che comunque Wataniya ha prodotto effetti economici benefici grazie all’indotto; ma il conflitto di interessi pesa eccome sulla credibilità, già abbastanza malridotta, del capo mediatore. Ma su questo, Blair è stato chiaro: “Resterò”, ha detto, chiudendo l’intervista.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Alessandro Iacuelli
di Alessandro Iacuelli
Si tratta di un mormorio, di voci prima diffuse, poi smentite. Fatto sta che lo scorso 8 ottobre le della Gendarmeria europea (Eurogendfor), di cui ci siamo già occupati sul Altrenotizie al momento della sua fondazione, sarebbero sbarcate a Igoumenitsa, in Grecia, provenienti dalla base di Vicenza, per poi essere trasferite alla base di Larissa, dopo aver attraversato tutto il Paese in direzione est, e da lì ripartire verso i Balcani.
Fonti giornalistiche greche hanno confermato di aver visto militari e veicoli sbarcare a Igoumenitsa, con tanto di effigie dell’esercito comunitario. Secondo le fonti ufficiali, si tratterebbe di un’esercitazione dell’Eurogendfor (che riunisce truppe di Olanda, Romania, Francia, Spagna, Portogallo e Italia) assieme ad alcuni soldati originari della Repubblica Ceca e facenti parte della Seebrig, la forza di pace multinazionale "Sudest Europa" che agisce sotto l’egida Onu.
Insomma, pare si tratti di un’operazione di routine, già programmata da tempo. Sta di fatto che l'esercitazione è andata a cadere, caso strano, proprio in Grecia e proprio a ridosso degli scioperi programmati per il 19 e 20 ottobre scorsi. Alquanto strano che una forza di polizia internazionale vada ad esercitarsi proprio in un luogo dove da settimane si susseguono serrate e manifestazioni di piazza, non sempre pacifiche.
 Giovedì scorso, con una nota diffusa a tarda notte, la polizia greca ha negato "la presenza di forze europee di gestione della crisi", tuttavia venerdì, due parlamentari del partito Comunista hanno presentato un'interrogazione al ministro della Protezione dei cittadini, chiedendogli se i militari europei fossero realmente arrivati nel Paese per aiutare le forze dell'ordine ateniesi a sedare eventuali situazioni di tensione. Al momento di scrivere, il ministro non ha risposto, nonostante uno dei suoi portavoce abbia confermato ai giornalisti la presenza della brigata "Balcani" della Seebrig.
Giovedì scorso, con una nota diffusa a tarda notte, la polizia greca ha negato "la presenza di forze europee di gestione della crisi", tuttavia venerdì, due parlamentari del partito Comunista hanno presentato un'interrogazione al ministro della Protezione dei cittadini, chiedendogli se i militari europei fossero realmente arrivati nel Paese per aiutare le forze dell'ordine ateniesi a sedare eventuali situazioni di tensione. Al momento di scrivere, il ministro non ha risposto, nonostante uno dei suoi portavoce abbia confermato ai giornalisti la presenza della brigata "Balcani" della Seebrig.
Non si sa, quindi, se la presenza dell'eurogendarmeria in Grecia sia davvero un'esercitazione o se sia intervenuta in piazza durante le recenti manifestazioni. Alcuni giornali greci sostengono che le voci legate ai militari comunitari siano state create per far pressione sui corpi di polizia greci, accusati di troppa indulgenza nei confronti dei manifestanti e idealmente loro vicini in quanto pubblici dipendenti, e quindi bersaglio dei tagli del Governo nell'ambito del piano di austerity.
L'Eurogendfor è composta da 3000 uomini con sede in Italia, organizzati in due brigate. Per quanto riguarda l'evenutale veridicità della voce che parla di un'esercitazione, occorre dire che ciò pare alquanto strano, poichè la Grecia non è un Paese membro di Eurogendfor. Analogo discorso vale se la forza internazionale è davvero intervenuta a scopo antisommossa nelle manifestazioni di piazza: la Grecia non fa parte del trattato di Veslen, trattato da cui ha origine la polizia militare europea, e in ogni caso sul suolo greco, in un momento di particolare crisi sociale interna, è venuta a trovarsi una forza militare straniera.
Senza scendere nella fantapolitica, se così fosse questa forza antisommossa, di cui fanno parte solo le polizie militari dei Paesi che hanno firmato il trattato di Veslen, quali ordini sta eseguendo? Da parte di chi? Del governo greco, che non fa parte del trattato, o dei paesi firmatari?
 I detrattori di queste voci ricordano che l'Eurogendfor è una forza di Polizia militare istituita nel 2004, da impiegare in zone di crisi e di guerra, oppure dove le forze militari hanno appena lasciato il campo ad un nuovo governo dopo un conflitto. Insomma, si tratta di crisi di tipo bellico e non certo di rivolte di piazza. Per il momento, l'Eurogendfor è composta da Carabinieri, Gendarmeria Nazionale francese, Guardia Civil spagnola, Guardia Nazionale Repubblicana portoghese e Marechaussee Reale olandese. L'Italia fornisce all'Eurogendfor il maggior contributo di uomini. Eurogendfor non obbedisce ai Parlamenti nazionali, ma direttamente ai singoli governi dei Paesi componenti. Il Quartier Generale si trova a Vicenza e che lo Stato ospitante, cioè l'Italia, sostiene tutte le spese del Quartier Generale.
I detrattori di queste voci ricordano che l'Eurogendfor è una forza di Polizia militare istituita nel 2004, da impiegare in zone di crisi e di guerra, oppure dove le forze militari hanno appena lasciato il campo ad un nuovo governo dopo un conflitto. Insomma, si tratta di crisi di tipo bellico e non certo di rivolte di piazza. Per il momento, l'Eurogendfor è composta da Carabinieri, Gendarmeria Nazionale francese, Guardia Civil spagnola, Guardia Nazionale Repubblicana portoghese e Marechaussee Reale olandese. L'Italia fornisce all'Eurogendfor il maggior contributo di uomini. Eurogendfor non obbedisce ai Parlamenti nazionali, ma direttamente ai singoli governi dei Paesi componenti. Il Quartier Generale si trova a Vicenza e che lo Stato ospitante, cioè l'Italia, sostiene tutte le spese del Quartier Generale.
Fatto sta che il trattato di costituzione di Eurogendfor, che dopo la sua ratifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 Maggio 2010, recita nell'art.3 che: "Eurogendfor potrà essere utilizzata al fine di: a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; (...) c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d'intelligence; (...) e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici.
Pertanto, non si tratta affatto di una superpolizia impiegata in casi estremi e scenari di guerra: la legge dice che possono intervenire in piazza. E il mistero resta, poichè non si capisce, né dal Trattato di Veslen, né dai regolamenti istitutivi, se il corpo armato può intervenire se "chiamato" da un Paese non firmatario. Insomma una vicenda certamente inquietante, e si resta in attesa di risposta al quesito iniziale: chi ha assicurato l'ordine pubblico, alle recenti manifestazioni del 19 e 20 ad Atene? Sicuri che fosse qualcuno in grado di parlare in greco?
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Mentre prosegue il tour elettorale del presidente Obama negli Stati Uniti per la rielezione nel 2012 con un messaggio di speranza per la classe media americana, una recente analisi della sua rete di finanziatori indica quali siano le vere forze dietro lo sforzo per conquistare un secondo mandato alla Casa Bianca. L’indagine è stata condotta dal Washington Post e rivela come Barack Obama abbia finora incassato molto più denaro proveniente dal settore finanziario rispetto a tutti i suoi rivali repubblicani.
Nonostante la retorica populista profusa da Obama nelle ultime settimane e il tentativo di appropriarsi in qualche modo del movimento “Occupy Wall Street”, il mondo della finanza americano non sembra preoccuparsi troppo per una presunta svolta a sinistra del presidente. I fondi raccolti da quest’ultimo in quest’ambito superano infatti quelli combinati di tutti i candidati in corsa per la nomination repubblicana.
Ciò che consente a Obama di far segnare numeri così importanti é anche il dettato stesso della legge elettorale americana, secondo la quale il presidente in carica, essendo già il candidato sicuro del proprio partito per le presidenziali del 2012, può raccogliere fin da ora denaro non solo per la propria campagna elettorale ma anche da destinare al Comitato Nazionale del Partito Democratico. I repubblicani devono invece per il momento limitarsi a chiedere donazioni per loro stessi, mentre il Comitato Repubblicano potrà contare sui finanziamento raccolti a proprio favore dal candidato alla presidenza solo quando la nominationsarà ufficialmente assegnata.
Secondo la legge elettorale USA, Obama e i candidati repubblicani possono ricevere da ogni singolo donatore un massimo di 5.000 dollari per l’intero ciclo elettorale del 2012. Per il momento, solo Obama può però riscuotere fino a 30.800 $ per il Comitato Nazionale Democratico per ogni anno solare. Ciò significa che il presidente democratico può contare su un maggiore flusso di denaro, pur disponendo teoricamente di un numero più ristretto di finanziatori.
Tra i vertici e i dipendenti di banche, hedge funds, compagnie di assicurazioni, servizi immobiliari e altre società del mondo finanziario che lo avevano lanciato nel 2008, Obama dimostra quindi di aver conservato una solida base di finanziatori. Questa sezione dell’élite finanziaria americana è in definitiva la stessa che tre anni fa lo aveva selezionato e spinto alla Casa Bianca come candidato del cambiamento dopo otto anni di amministrazione Bush.
In questi primi mesi di campagna Obama ha incassato 15,6 milioni di dollari dall’industria finanziaria, di cui 12 destinati al Comitato Nazionale Democratico. Il favorito per la nomination in casa repubblicana, Mitt Romney, ha raccolto meno della metà di questa cifra, mentre il suo principale sfidante, Rick Perry, circa due milioni. I rimanenti candidati repubblicani, invece, non superano singolarmente i 400 mila dollari.
 Escludendo il denaro che andrà al partito, i fondi ottenuti da Obama potrebbero apparire limitati. Bisogna tenere presente, tuttavia, non solo i limiti di donazione imposti per legge ai singoli candidati (5.000 dollari) ma soprattutto che le risorse destinate al Comitato finiranno comunque in gran parte a finanziare la competizione democratica più importante del 21012, cioè quella di Obama per la Casa Bianca.
Escludendo il denaro che andrà al partito, i fondi ottenuti da Obama potrebbero apparire limitati. Bisogna tenere presente, tuttavia, non solo i limiti di donazione imposti per legge ai singoli candidati (5.000 dollari) ma soprattutto che le risorse destinate al Comitato finiranno comunque in gran parte a finanziare la competizione democratica più importante del 21012, cioè quella di Obama per la Casa Bianca.
Come esempio del consenso di cui gode l’attuale inquilino della Casa Bianca negli ambienti finanziari, il Washington Post cita le cifre sborsate dai dipendenti della compagnia Bain Capital di Boston, co-fondata proprio da Mitt Romney. Da questa compagnia il candidato repubblicano ha avuto finora “solo” 34 mila dollari da 18 donatori, contro i 76 mila di Obama, sia pure elargiti da appena tre suoi sostenitori.
Quello che più conta rilevare, in ogni caso, è il fatto che tutti i candidati in corsa per la Casa Bianca - democratici e repubblicani - stanno facendo a gara per assicurarsi l’appoggio e gli assegni dei big della finanza. Ciò dimostra ancora una volta a quali interessi sarà chiamato a rispondere il prossimo presidente degli Stati Uniti.
Come sottolinea poi il Washington Post, i persistenti profondi legami con Wall Street sono difficili da conciliare con i toni da paladino della classe media che Obama sta esibendo in questo periodo. In realtà, la contraddizione è solo apparente, poiché l’appello di Obama alle classi più disagiate è puramente una mossa strategica messa in atto soltanto per cercare di mobilitare la base elettorale democratica in vista del voto del prossimo anno.
Sulla vera natura dei contrasti tra il presidente e Wall Street, di cui i media d’oltreoceano continuano parlare, fa luce poi una dichiarazione rilasciata ancora al Washington Post da un anonimo finanziatore di Obama. Secondo questo banchiere la disaffezione di Wall Street nei confronti di Obama “è ingigantita”. A suo dire, un contingente di manager del settore finanziario di New York, Chicago e dalla California rimane fermamente nel campo di Obama, la cui la politica economica condividein pieno.
Ancora più rivelatrice della doppiezza di Obama è infine la caratterizzazione che lo stesso “executive” fa al giornale americano degli attacchi lanciati dal presidente al mondo finanziario. Infatti, secondo quest’ultimo, “è probabilmente utile da un punto di vista politico se Obama non viene visto come l’uomo di Wall Street”. La parvenza di un sistema apparentemente democratico va insomma salvaguardata, anche se gli ordini continueranno a venire impartiti dall’élite economica e finanziaria che controlla le leve del potere a Washington.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Nessuna sorpresa nelle elezioni presidenziali di domenica in Argentina. Il presidente uscente, la 58enne Cristina Fernández de Kirchner, ha infatti conquistato un’agevole vittoria che le permetterà di inaugurare un secondo mandato il prossimo mese di dicembre. Una crescita economica impetuosa, una coraggiosa politica d’inclusione sociale e un’opposizione debole e divisa hanno permesso alla vedova dell’ex presidente, Nestor Kirchner, di ottenere il consenso più alto da quando l’Argentina è tornata alla democrazia nel 1983.
Secondo i dati quasi definitivi, Cristina Fernández ha raccolto quasi il 54 per cento dei voti espressi, staccando il suo più immediato inseguitore di qualcosa come 37 punti percentuali. Il governatore socialista della provincia di Santa Fe, Hermes Binner, si è infatti fermato al 17 per cento. Il risultato ha permesso alla “Presidenta” di chiudere la partita già al primo turno. Secondo la legge elettorale argentina, il vincitore può evitare il ballottaggio se supera la soglia del 45 per cento oppure ottiene almeno il 40 per cento con un margine superiore al 10 per cento sul secondo classificato.
Ancora peggiori sono stati i risultati per gli altri contendenti. Al terzo posto é giunto il senatore Ricardo Alfonsín, figlio dell’ex presidente argentino Raul e candidato per l’Unione Civica Radicale di centro. Più indietro sono giunti il governatore della provincia di San Luis, Rodríguez Saa, e l’ex presidente ad interim (2002-2003) Eduardo Duhalde, entrambi esponenti di fazioni di centro-destra del Partito Peronista. Poco più di una manciata di voti hanno raccolto infine Carlos Altamira ed Elisa Carrió della Coalizione Civica di centro, piazzatasi al secondo posto nelle presidenziali del 2007 con il 23 per cento dei consensi.
La coalizione della Presidenta (Frente Para la Victoria, FPV) ha anche allargato la propria delegazione in Parlamento - domenica erano in palio 130 seggi nella camera bassa e 24 al Senato - dove ha riconquistato la maggioranza che aveva perso nel 2009. Allo stesso modo, la maggior parte dei nove posti di governatore in palio dovrebbero andare al suo Partito Justicialista peronista (PJ).
Nel discorso seguito all’annuncio del trionfo, Cristina Fernández ha ringraziato soprattutto gli elettori più giovani ed ha lanciato un appello all’unità del paese. La Presidenta ha poi sottolineato come sia diventata la prima donna in America Latina ad essere stata rieletta per un secondo mandato alla guida del proprio paese, mentre ha ricordato in maniera commossa il marito e predecessore, scomparso nell’ottobre dello scorso anno in seguito ad un attacco cardiaco.
Proprio sulle orme di Nestor Kirchner, Cristina Fernández ha costruito il proprio successo politico. Grazie ad un modello che ad un’economia allo sbando dopo la bancarotta del 2001 ha combinato lo stimolo con generosi programmi sociali, la coppia presidenziale ha guidato un paese che ha fatto segnare, secondo gli stessi dati del FMI, una crescita del PIL del 94 per cento nell’ultimo decennio. Tutto questo restringendo drasticamente la forbice tra i redditi più alti e quelli più bassi e abbattendo i livelli di povertà.
Solo un paio di anni fa, il gradimento nel paese per Cristina Fernández era in realtà crollato, soprattutto in seguito agli effetti di un durissimo scontro con l’agrobusiness locale attorno all’innalzamento di una tassa sulle esportazioni. Da allora, tuttavia, le sue capacità politiche e il boom economico - a cui va aggiunta l’ondata di simpatia suscitata dalla morte del marito - le hanno permesso di recuperare rapidamente terreno di fronte ad un’opposizione priva di valide alternative.
 Il sistema Argentina ha beneficiato enormemente dell’interventismo statale nel settore economico, inaugurato da Nestor Kirchner e proseguito dalla moglie. A due anni dal default sul proprio debito, nel 2003 l’allora presidente decise di svincolarsi dal ricatto della ricetta neoliberista del FMI per farne pagare le conseguenze agli investitori piuttosto che ai cittadini comuni. Vennero così respinte le misure di austerity a favore di iniziative di stimolo finanziate con le riserve della banca centrale. La svalutazione del peso, che uscì così dalla follia monetarista di Domingo Cavallo e Menem che lo avevano quotato 1 a 1 con il dollaro, servì inoltre a ridare competitività all’economia argentina che cominciò ben presto a dare segnali di ripresa.
Il sistema Argentina ha beneficiato enormemente dell’interventismo statale nel settore economico, inaugurato da Nestor Kirchner e proseguito dalla moglie. A due anni dal default sul proprio debito, nel 2003 l’allora presidente decise di svincolarsi dal ricatto della ricetta neoliberista del FMI per farne pagare le conseguenze agli investitori piuttosto che ai cittadini comuni. Vennero così respinte le misure di austerity a favore di iniziative di stimolo finanziate con le riserve della banca centrale. La svalutazione del peso, che uscì così dalla follia monetarista di Domingo Cavallo e Menem che lo avevano quotato 1 a 1 con il dollaro, servì inoltre a ridare competitività all’economia argentina che cominciò ben presto a dare segnali di ripresa.
Nel 2010 il PIL argentino ha fatto segnare una crescita del 9,2 per cento. Nel 2011 la crescita sarà invece dell’8 per cento, cioè superiore a qualsiasi altro paese latinoamericano, mentre i livelli di disoccupazione sono ai minimi storici. Questo andamento ha causato tuttavia un livello piuttosto elevato dell’inflazione - oltre il 20 per cento per il FMI e alcuni analisti privati, intorno al 10 per cento secondo i dati del governo - anche se gli effetti sono stati contenuti dall’adeguamento degli stipendi.
A trascinare l’economia argentina sono state le esportazioni e i prezzi sostenuti delle materie prime e dei prodotti agricoli (grano), destinati in gran parte a paesi emergenti come Cina e Brasile. Il rallentamento dell’economia globale potrebbe perciò frenare a breve la crescita del paese, tanto che le previsioni indicano un aumento del PIL per il 2012 “limitato” al 4,6 per cento. La frenata dell’economia, assieme all’inflazione e alla capacità di mantenere una rete di servizi sociali notevolmente rafforzata in questi ultimi anni, rappresenteranno perciò le sfide più difficili per Cristina Fernández nel corso del suo secondo mandato alla guida del paese.
Su questi punti avevano cercato di conquistare consensi i candidati dell’opposizione, la quale puntava il dito contro la Presidenta anche per la presunta mano pesante usata nei confronti delle voci critiche verso il suo governo e per aver manipolato i dati macroeconomici, così da mascherare l’andamento reale dell’economia.
Le critiche non hanno evidentemente scalfito la popolarità di Cristina Fernández, la quale anzi ha saputo espandere la propria base elettorale - costituita principalmente dai lavoratori e dai ceti più disagiati - raccogliendo consensi tra i giovani e una classe media che, come ha scritto il Financial Times alla vigilia del voto, “condivide il suo messaggio basato sulla redistribuzione della ricchezza e sull’inclusione sociale”.
