- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Ilvio Pannullo
di Ilvio Pannullo
La recente decisione della Germania di proibire le vendite allo scoperto ha avuto come effetto immediato quello di trascinare il valore dell’euro ai minimi da quattro anni. Risultato: la valuta europea vale poco più di 1,22 centesimi sul biglietto verde. Una presa di posizione unilaterale, decisa dal cancelliere tedesco, Angela Merkel, il cui obiettivo è di dare un altolà ai mercati. “L’Euro – ha affermato il capo dell’esecutivo teutonico - è in pericolo: l’unione monetaria su cui si basa la crescita in Germania é un destino comune per tutti noi. La nostra decisione va nel senso di preservare quest’idea comune di moneta unica”.
Per il momento dunque nessuna vendita allo scoperto in Germania, una misura che rimarrà in vigore finché non verrà trovato un accordo europeo sulla materia. L’idea pare tuttavia stia già acquistando forza e, spinte dal decisionismo tedesco, le Autorità di controllo sulle borse europee stanno valutando azioni contro le vendite allo scoperto, per contribuire al corretto funzionamento dei mercati.
E' quanto si legge in un aggiornamento pubblicato dall'associazione delle autorità di controllo dei sistemi finanziari dell'Ue - il Cesr - sulle misure adottate nei diversi paesi per questo problema (il c.d. short selling). Tali azioni "saranno adottate per rafforzare la fiducia nei mercati finanziari e proteggere gli investitori".
Ma cosa sono queste vendite allo scoperto? Perché preoccupano tanto i governi europei, al punto da rendere necessario un tempestivo intervento come quello appena preso dalla Germania? Trattandosi di una misura per il momento valida solo con riferimento alla Borsa tedesca, non c’è migliore esempio per spiegare concretamente quali storture del mercato possa provocare la pratica dello “short selling”, che analizzare quanto accaduto ad un’azienda simbolo dell’efficienza teutonica: la Volkswagen. Si consideri dunque paradigmatica la vicenda che ha interessato quest’azienda, che alla fine dell'ottobre 2008 è riuscita, sia pur brevemente, a diventare la società di maggior valore al mondo senza vendere neppure un'automobile in più rispetto alle previsioni.
Mentre l'economia era ancora in caduta libera, gli operatori di borsa avevano formulato previsioni pessimistiche sul futuro dell'azienda; osservando i dati sui loro monitor, erano giunti alla conclusione che il colosso tedesco, come tutte le altre case automobilistiche, sarebbe andato incontro ad un periodo difficile. S’immagini dunque un trader intimamente convinto che la quotazione del titolo sia destinata a scendere: un modo per monetizzare questa intuizione è vendere subito azioni Volkswagen, per ricomprarle quando il prezzo risale. Dal momento che il trader non va in giro con titoli Volkswagen che gli escono dalle tasche, si rivolge a qualcuno che ne possiede in abbondanza, come un investitore istituzionale, e prende a prestito - a pagamento ovviamente - le sue azioni con la promessa di restituirle a stretto giro.
L'investitore istituzionale è contento perché può guadagnare dal prestito di titoli, che riavrà indietro sani e salvi; il trader è contento perché può vendere le azioni, aspettare che il prezzo scenda, ricomprarle e, con il guadagno, non soltanto pagare il dovuto all'investitore istituzionale, ma saldare anche un'altra rata del suo yacht a Montecarlo. Questo tipo di operazione è chiamata "vendita allo scoperto". In definitiva si vende un titolo che in realtà non si possiede.
Il problema è che il concorrente di Volkswagen, Porsche, aveva cominciato tacitamente a comprare azioni Volkswagen, con l'obiettivo di assicurarsi il controllo di due terzi della società. Quando la portata di quest’ondata di acquisti è venuta alla luce, ci si è resi conto rapidamente che sul mercato non restavano più titoli da scambiare. Il rastrellamento dei titoli Volkswagen operato da Porsche ha impedito che le quotazioni Volkswagen scendessero. I trader stavano dunque vendendo titoli presi a prestito da altri operatori a Porsche e quando quest'ultima ha annunciato la sua intenzione di non rivendere le azioni, tra gli operatori di borsa è scoppiato il panico.
Si è prodotta così un'ondata di "ricopertura di scoperto": gli investitori, cioè, si sono precipitati a chiudere le posizioni che avevano imprudentemente aperto con titoli che non possedevano. I trader avevano scommesso sul fatto che le quotazioni Volkswagen, come quelle di qualsiasi altra casa automobilistica durante una recessione, sarebbero scese; quando invece hanno capito che, nonostante la cattiva performance dell'azienda nel mercato automobilistico, le azioni dell’azienda avrebbero continuato a sconfiggere la forza di gravità, gli speculatori si sono precipitati a ricomprare i titoli prima che il prezzo salisse ulteriormente.
Ma quest’ondata di acquisti non ha fatto altro che spingere le quotazioni ancora più in alto. Il prezzo è aumentato talmente tanto che il titolo Volkswagen è entrato nell'indice Dax 30, l'indice che comprende le maggiori società quotate nella borsa tedesca e questo, a sua volta, ha scatenato un'altra corsa all'acquisto, che però ha avuto come protagonisti non più gli speculatori di borsa, ma gli investitori istituzionali, tradizionalmente più prudenti.
Per capire meglio quanto accaduto anche in questo caso può venire in aiuto un facile esempio: i fondi pensione. I fondi pensione sono investitori istituzionali che investono con l'ottica di conseguire rendimenti a lungo termine, privilegiando un'accumulazione lenta e certa della ricchezza rispetto ad operazioni speculative molto più rischiose (dunque molto più redditizie). Per mantenere il proprio portafoglio in equilibrio gli investitori istituzionali come i fondi pensione tendono ad acquistare soltanto azioni di società cosìdette "blue chip", che sono certamente le meno vulnerabili agli shock che colpiscono i titoli azionari, e che si trovano, generalmente, fra le 30 maggiori società quotate nei mercati. Quando la Volkswagen ha fatto il suo ingresso nella schiera del Dax 30, uno stormo di investitori istituzionali è entrato automaticamente nella partita, acquistando i titoli della società a qualsiasi prezzo.
Il risultato? Il prezzo delle azioni è salito da 200€ a 1000€ nel tempo di una settimana ed il valore della società è aumentato di 300 miliardi di euro. Sia pur brevemente, Volkswagen con un valore contabile di appena 343 miliardi di dollari é diventata più grande della Exxon Mobil, una delle più influenti compagnie petrolifere del mondo. E, in tutto questo, l'azienda non ha alzato un dito. Alla fine - come nelle migliori favole - le regole del Dax sono state modificate, il prezzo si è stabilizzato e, nel 2009, Volkswagen ha acquistato Porsche.
Ora, se si osserva più attentamente la storia appena raccontata ci si accorge di come il problema stia nel fatto che tra il prezzo e il valore dei beni ci sia - nel sistema in cui siamo costretti a vivere - una discrepanza cui gli economisti non possono porre rimedio. Questo perché si tratta di un problema insito nell'idea stessa di prezzi determinati dal profitto e non dall’intrinseco valore del bene che si prende in considerazione.
Siamo dunque tutti costretti ad osservare, impotenti, le continue ed immotivate oscillazioni delle borse, ormi completamente scollegate dalla dimensione di una realtà produttiva purtroppo in costante declino. Intanto gli stregoni della finanza fanno la fila per spiegare al popolo bue che la crisi è ormai alle spalle ed il gioco può ricominciare. Ci raccontano che il gioco è leale e che loro giocano sempre a carte scoperte.
Quello che non dicono, tuttavia, è che le carte sono scoperte perché è il tavolo ad essere truccato e per cambiare il tavolo serve una politica forte e credibile, capace di imporre regole intelligenti che sia poi in grado di far applicare. Ma politica significa popolo e per sperare in una politica più seria una conoscenza diffusa di quelli che sono i meccanismi del grande gioco della finanza è essenziale. Solo una collettiva consapevolezza di quali sono i problemi comuni da affrontare e da risolvere per scongiurare un ulteriore crisi ancor più drammatica di quella ancora in atto, potrà spingere le classi politiche europee a mettere da parte i facili egoismi ed affrontare insieme e coerentemente il problema di regolare i mercati.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Emanuela Pessina
di Emanuela Pessina
BERLINO. Che il mercato finanziario abbia bisogno di un rinnovamento esemplare non è un mistero. Da tempo, ormai, si parla quotidianamente di speculazioni nocive, titoli tossici, strumenti di investimento “alternativi” o “non convenzionali”, insolvenze e così via, per arrivare, immancabilmente, allo spauracchio delle Grande Crisi. Un po’ meno chiaro, purtroppo, è il modo concreto in cui questa trasformazione dovrà avvenire. E, soprattutto, nessuno sa spiegare come si farà a coinvolgere la Borsa dei “piani alti” nei costi della crisi: anche perché ogni riforma, dalla più banale, sembra non trovare spazio all’interno del far west finanziario.
Ancora non è stato deciso, ad esempio, come e se verrà disciplinato il mercato dei cosiddetti credit default swaps, o CDS, contratti derivati sul rischio di credito. I CDS costituiscono la polizza assicurativa degli attori di borsa: chi acquista questi contratti, si assicura contro l’eventualità di un fallimento della società (o dello Stato) che le emette. L’investitore compra i CDS da società finanziarie terze, che risarciranno l’investitore dell’intera somma corrispondente alle obbligazioni assicurate in caso di default. L’unico problema è che le società venditrici di CDS non sono società assicurative ed inoltre sono in grado di garantire protezione anche a chi non detiene in portafoglio i titoli “garantiti” dal derivato.
Benché i CDS siano nati negli anni 90 come prodotto protettivo per creditori reali, il suo impiego speculativo è stato deleterio. Chi sottoscrive CDS per speculare non compra protezione ma piuttosto assume una posizione di vendita allo scoperto sulle emissioni della società oggetto di speculazione, di fatto scommettendo sul suo fallimento: in caso di default, infatti, lo speculatore riceverà dall’emittente del derivato un pagamento pari al nominale garantito.
Ma il circolo vizioso è più ampio: i contratti CDS sono un buon indicatore del premio per il rischio che il mercato richiede per mettere dei soldi nella società su cui vengono “scritti”: pertanto, quando aumenta la probabilità percepita di un fallimento, cresce il valore dei CDS, e con esso il costo dell’indebitamento per la società, in un avvitamento pernicioso e difficilmente controllabile.
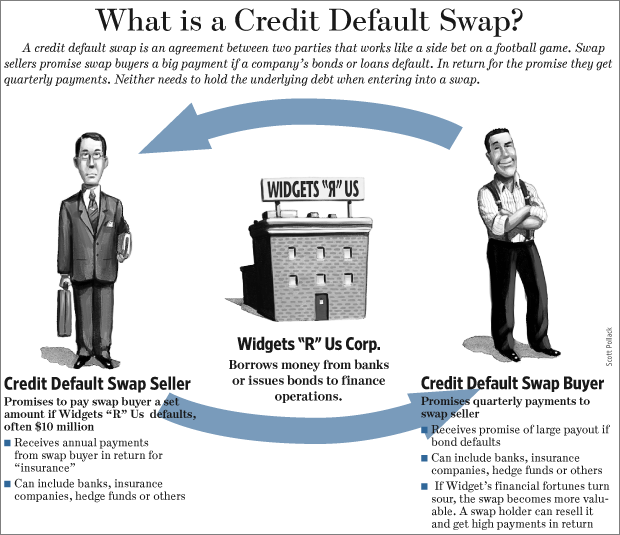 Ed è proprio questa l’accusa da parte dei politici europei nei confronti di molti Hedge Fund inglesi e americani. Questi operatori non bancari, che utilizzano di regola strategie molto sofisticate, hanno realizzato profitti astronomici scommettendo sulla bancarotta di società o Stati terzi (vedi la Grecia). Che il mercato dei CDS sia stato pesantemente “drogato” dalla speculazione è provato dal fatto che al momento dello scoppio della crisi il valore complessivo del mercato dei credit default swap ha superato (e di molto) quello della somma di tutte le obbligazioni nazionali, aziendali, e municipali in circolazione: l’eccedenza tra le due misure è costituita da quei titoli creati e sottoscritti per puri intenti “di scommessa”. Ad aggravare la situazione, i CDS vengono stipulati senza alcuna formalità, né per gli emittenti sono previsti particolari requisiti di capitale. E ora ci si ritrova con una pila di CDS conclusi sullo stesso sottostante.
Ed è proprio questa l’accusa da parte dei politici europei nei confronti di molti Hedge Fund inglesi e americani. Questi operatori non bancari, che utilizzano di regola strategie molto sofisticate, hanno realizzato profitti astronomici scommettendo sulla bancarotta di società o Stati terzi (vedi la Grecia). Che il mercato dei CDS sia stato pesantemente “drogato” dalla speculazione è provato dal fatto che al momento dello scoppio della crisi il valore complessivo del mercato dei credit default swap ha superato (e di molto) quello della somma di tutte le obbligazioni nazionali, aziendali, e municipali in circolazione: l’eccedenza tra le due misure è costituita da quei titoli creati e sottoscritti per puri intenti “di scommessa”. Ad aggravare la situazione, i CDS vengono stipulati senza alcuna formalità, né per gli emittenti sono previsti particolari requisiti di capitale. E ora ci si ritrova con una pila di CDS conclusi sullo stesso sottostante.
La Germania, che in questo momento di crisi ha assunto di fatto la leadership dell’Area Euro, sta lanciando segnali confortanti sul piano della lotta contro la speculazione basata sui derivati di credito. Tanto per dimostrare al mondo che la Cancelliera non solo abbaia ma è in grado anche di assestare qualche morso, la BaFin (CONSOB tedesca) ha annunciato ieri sera il divieto vendite allo scoperto su un paniere di titoli azionari di società assicurative e banche di importanza strategica (tra cui Allianz, Deutsche Bank e Commerzbank) nonché quello di negoziazione di “naked CDS”, ovvero CDS senza sottostante su titoli obbligazionari di emittenti sovrani (per impedire il tipo di giochino, per intenderci, che ha spacciato la Grecia).
Se l’idea alla base della decisione della BaFin è pienamente condivisibile sul piano del principio, non si può negare che essa è stata presa senza nemmeno preoccuparsi di consultare i Francesi, né Bruxelles, il che le ha conferito il poco gradevole stigma della disperazione. Il tutto senza contare che, da un punto di vista pratico non è ben chiaro il modo in cui l’autorità di vigilanza tedesca riuscirà a monitorare il rispetto del divieto da parte degli operatori, dato che la stragrande maggioranza delle transazioni sui derivati di credito continua ad essere negoziata su Londra.
La FSA, Financial Services Authority britannica si è tra l’altro affrettata a spiegare che il veto non potrà applicarsi alle filiali londinesi delle banche tedesche... Se poi si pensava di proteggere i titoli greci, si può concludere che la mossa è platealmente fallita, dato che lo spread sui titoli ellenici, proibizioni o no sui CDS, si è allargato di altri 37 centesimi.
Se gli Stati europei riusciranno a portare avanti un ordinamento del mercato finanziario senza il sostegno degli Stati Uniti è tutto da vedere: sarebbe un primo, indicativo passo verso un nuovo ottimismo nei confronti di un’economia capitalista che ha deluso i più. Certo, l’esordio gauchiste della Merkel non è dei più confortanti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Come scrive nel suo op-ed sul New York Times, Bethany Mc. Lean, collaboratrice di Vanity Fair USA e Fortune ed esperta del caso Enron, a provocare la spaventosa crisi globale non fu una serie di sfortunate circostanze, quanto piuttosto la condotta apertamente criminale di diversi attori del mercato finanziario. In complice sequenza ci sono le banche, la Federal reserve e il Congresso USA.
Le prime hanno venduto immondizia facendola pagare per oro; i “garanti”, applicati nel formidabile gioco di pompare profitti a breve, assumendo rischi che non erano in grado di coprire (e che spesso non erano nemmeno in grado di stimare). Poi la Federal Reserve, colpevole di non aver spento l'euforia creditizia; quindi il Congresso, che non ha mai legiferato seriamente sui derivati oltre ad aver alimentato in tutti i cittadini, anche in chi mai avrebbe mai potuto permettersela, la speranza di poter avere una casa di proprietà. E, naturalmente, le agenzie di rating, che hanno benedetto con bollini di eccellenza investimenti chiaramente destinati a fallire.
Se si escludono la recente azione della SEC contro Goldman Sachs e l'indagine lanciata dal procuratore generale di New York, Andrew Cuomo, contro otto banche (Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Crédit Agricole e Merrill Lynch), fino a poco fa l'unica azione penale contro manager di banche d'affari coinvolte nella crisi finanziaria è stata quella a carico di Ralph Cioffi e di Matthew Tannin, trader della Bear Stearns, fallita ed acquistata da JP Morgan grazie ad un sostanziale contributo governativo - i quali peraltro sono andati assolti a novembre dello scorso anno. Mentre la SEC sta analizzando i rapporti (perversi) tra originator e clienti dei titoli tossici, Cuomo si sta concentrando sulle interazioni (altrettanto inquietanti) tra banche e agenzie di rating.
Già nell'ottobre del 2008, nel corso delle audizioni davanti al Comitato governativo per la Vigilanza e la Riforma (dei mercati finanziari) erano stati resi pubblici edificanti documenti interni delle rating agency: illuminante in tal senso lo scambio di SMS tra due funzionari di Standard & Poor's: "A proposito, quell'emissione è ridicola", scrive uno - "lo so bene, non c'è dubbio che il nostro modello a malapena cattura la metà del rischio reale", risponde l’altro. E ancora: "Non dovremmo emettere il rating", "noi emettiamo rating su qualsiasi operazione. Potrebbero anche essere delle vacche a strutturarlo, noi il rating glielo diamo".
Utile anche prendere atto di quello che Chris Meyer, responsabile del settore CDO (Collateralized Debt Obligation), pensava dei prodotti cui la sua azienda assegnava il massimo dei voti. "Le agenzie di rating contribuiscono alla creazione di un nuovo mostro, il mercato dei CDO. Speriamo di essere tutti ricchi ed in pensione quando questo castello di carte crollerà". A testimonianza del fatto che le agenzie erano di fatto assediate, basta leggere la mail che il capo dei Rischi della società inviò all'amministratore delegato di Moody’s Raymond McDaniel nell’ottobre del 2007: "Gli analisti e i direttori sono continuamente tampinati da banchieri, emittenti e investitori - tutti con argomenti ragionevoli - le cui opinioni finiscono per influire sulle valutazioni, qualche volta in positivo, talora in negativo".
Come spiega Salomon Hughes, sul quotidiano socialista britannico, Morning Star, McDaniel voleva dire che le agenzie erano le “cocche” delle banche. E poiché sono banche a pagare le commissioni, se esse desiderano un buono (o un cattivo) rating, c’è da scommettere che lo otterranno.
L'intreccio perverso banche-agenzie di rating era noto da tempo, tanto è vero che a giugno del 2008, queste ultime erano state costrette a siglare con Cuomo un accordo che prevedeva: un meccanismo per impedire il conflitto di interesse causato dal fatto di fare profitti fatturando gli stessi soggetti valutati (pagamento delle fee in quattro rate e non solo a valutazione completata); l'obbligo per gli emittenti di titoli di rendere noto se avessero chiesto il rating a qualche altra agenzia senza poi utilizzarlo (cosa che avrebbe dovuto evitare che l'emittente facesse shopping tra le rating agency per poi rendere nota solo la valutazione più benevola); la pubblicazione online delle metodologie di valutazione del debitore ceduto.
La prima misura si è rivelata inutile, la terza controproducente. Infatti, rendendo pubblico il metodo con cui viene effettuata la valutazione, le agenzie di rating hanno finito per offrire ai banchieri d'affari uno strumento per assemblare, lavorando a ritroso, portafogli formalmente in linea con i requisiti necessari ad ottenere un "top notch" (AAA), anche se infarciti di elementi tossici: la versione finanziaria della proverbiale situazione di “operazione perfettamente riuscita ma paziente deceduto.”
Non solo: i modelli delle agenzie di rating erano basati su ipotesi ridicole e dogmatiche, tra cui la fede incondizionata nelle magnifiche sorti e progressive del mercato immobiliare e la credenza, altrettanto ridicola, secondo cui il fatto che i debitori ceduti provenissero da aree diverse del paese diversificasse il rischio in modo tale da evitare guai. Ma alle banche non bastava essere prese per mano dalle agenzie di rating e condotte a confezionare in scatole luccicanti l'immondizia che raccoglievano al solo scopo di scommetterci contro: volevano stringere nei loro tentacoli dorati attorno al capitale umano delle agenzie.
Le banche finite sotto lo scrutinio di Cuomo ad un certo punto hanno cominciato ad assumere uomini delle rating agency: portando in casa il know-how e il canale privilegiato con i loro ex colleghi, la possibilità di truffare il mercato aveva come unici limiti quelli imposti dalla fantasia degli "ingeneri finanziari". Come al solito, la palma criminale spetta a Goldman: nel febbraio del 2005, quando la banca d'affari stava ideando un nuovo CDO (Collateralized Debt Obligation) altamente strutturato, Shin Yukawa, un manager della Fitch, partecipò ad un convegno moderato da un dipendente Goldman Sachs, Jonathan M. Egol. Il mese successivo, Yukava era già stato assunto da Goldman Sachs, dove, come raccontano i documenti interni della banca, ha dato un contributo determinante alla costruzione di Abacus 2007-AC1, forse il capolavoro della banca d'affari americana.
Abacus era un CDO (obbligazione basata su un'attività sottostante): il riferimento dello strumento non erano mutui "impacchettati", ma un portafoglio di Credit Default Swap (contratti assicurativi contro il fallimento) su strumenti strutturati. Tra il 2004 e il 2008 Goldman Sachs ha effettuato ben 25 emissioni di Abacus, per un totale di quasi 11 miliardi di dollari, consentendo agli investitori di scommettere sul rialzo o il ribasso del mercato immobiliare: chi era lungo (aveva comprato) titoli Abacus avrebbe realizzato perdite in caso di caduta dei valori immobiliari e viceversa.
Di solito Goldman si dava da fare per mandare lunghi i clienti su Abacus, tenendo le posizioni corte per sé e per alcuni amici fidati: John Paulson, fondatore della Paulson & Company, il fondo Magnetar e il fondo di George Soros. Abacus era una bella macchina per fare profitti sul crollo del mercato immobiliare, al punto che nel 2007 e nel 2008, con il collasso dei subprime aveva cominciato a macinare profitti per Goldman e per i suoi colleghi speculatori globali.
Ma l'apoteosi si ebbe quando Fabrice Tourre (giovane dirigente francese della Goldman londinese) costruì Abacus 2007-AC1, un prodotto di fatto strutturato da Paulson, anche se i documenti ufficiali sostenevano che fosse una società indipendente, la ACA Management LLC a scegliere i titoli. In breve, secondo la ricostruzione della SEC, Paulson pagò 15 milioni di dollari alla Goldman per la strutturazione di Abacus 2007-AC1, costruito su derivati su titoli strutturati quasi tutti downgradati nel giro di due anni dalla sua istituzione. Un buon investimento, a giudicare dei risultati: 1 miliardo di perdite per gli investitori di Abacus 2007-AC1 e un miliardo di utili per Paulson, il quale, guarda caso, era anche lo strutturatore.
Si noti come le rating agency, così generose con gli amici delle banche (ed in particolare di Goldman Sachs), si sono rivelate inflessibili quando si è trattato di declassare il debito della Grecia a "junk" (spazzatura): alla luce degli standard tecnici e morali da esse dimostrate in questi anni terribili per il capitalismo finanziario, la decisione della BCE di ignorare il downgrading, di fatto riducendo all'irrilevanza le agenzie di rating, sembra un passo nella giusta direzione.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Ilvio Pannullo
di Ilvio Pannullo
Ogni volta che gliene viene data la possibilità, il Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, è pronto nel ribadire quanto grande sia stata l’abilità del governo nel gestire la crisi, ancora molto lontana dall’essersi conclusa. In effetti al Ministro spetta il riconoscimento del merito di aver impedito un peggioramento eccessivo dei nostri saldi di finanza pubblica, garantendone livelli meno problematici rispetto a diversi paesi europei che aderiscono alla moneta unica. E poiché paesi solitamente più virtuosi di noi nei conti pubblici ne hanno accettato un consistente deterioramento per affrontare la crisi, l'Italia, che non l’ha fatto, è riuscita a trasformarsi in un paese, almeno in termini relativi - o semplicemente statistici se si è amanti della precisione - virtuoso. Ma da qui a sostenere che i nostri problemi di finanza pubblica siano scomparsi o che siano stati notevolmente attenuati vi è un gran salto; semplicemente si notano di meno in un mondo rapidamente peggiorato nei suoi conti pubblici.
Il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, insieme al Financial Times e ai mercati finanziari internazionali hanno, o per il momento fingono di avere, una buona opinione della finanza pubblica italiana perché, osservandola attraverso gli occhiali del trattato di Maastricht, guardano ai saldi di bilancio in rapporto al Pil e non alle grandezze che quei saldi li determinano, senza cioè osservare entrate e spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo, per avere un'idea sicuramente più chiara delle dinamiche economiche che interessano il nostro paese.
Lo farebbero, se fosse nel loro interesse analizzare più compiutamente lo stato della nostra economia, ma non lo fanno semplicemente perché in questo periodo sono altri i problemi, Grecia in testa. Dal punto di vista del disavanzo pubblico rispetto al Pil - ossia la differenza tra quanto si è speso e quanto si è prodotto - l'Italia nel 2009 è andata meglio della media dell'area Euro e si è tenuta molto distante dai valori di paesi in cui il deficit è letteralmente esploso come la Grecia, l’Irlanda, la Spagna; e, fuori dall'area Euro, la Gran Bretagna. Il nostro rapporto deficit/Pil é infatti solo raddoppiato nel 2009 rispetto al 2008, passando dal 2,7% al 5,3% mentre nell'intera area Euro è più che triplicato, passando dal 2% al 6,2%, e si colloca ora un punto di Pil al di sopra del valore italiano.
È esattamente questo differenziale che ci sta coprendo rispetto alla speculazione internazionale, notoriamente aggressiva con chi versa in posizione di maggior debolezza. Le istituzioni economiche europee sembrano, inoltre, non dare grande peso all'altro rilevante parametro di finanza pubblica alla base del trattato di Maastricht, cioè il rapporto tra il debito pubblico e il Prodotto interno lordo. L'Italia, che ha il terzo maggiore debito pubblico del mondo, senza avere contemporaneamente la terza economia del mondo, (come giustamente ricorda ogniqualvolta gli si chieda conto di qualcosa il Ministro Tremonti) detiene anche il record del peggior rapporto europeo debito/Pil, battendo persino la Grecia. Ma sino a quando riuscirà a tenere il suo rapporto deficit/Pil tra quello dei paesi virtuosi, e s’impegnerà nei prossimi anni a migliorarlo più rapidamente degli altri, nessuno farà troppe storie.
Tutto da vedere se vi riuscirà o meno e, per valutarlo, è necessario per l’appunto estendere l'analisi dal deficit alle due grandezze che lo determinano, la spesa e le entrate pubbliche. In relazione ad esse le dinamiche sono tuttavia molto sfavorevoli: nel 2009, anno di profonda recessione, la spesa pubblica complessiva ha nettamente sforato il valore del 50% rispetto al Pil, anzi ha quasi toccato il 52%, più di tre punti percentuali al di sopra del dato del 2008 e questo nonostante il risparmio di mezzo punto conseguito alla voce degli interessi sul debito. Si tratta del valore europeo più elevato dopo quello dei paesi che hanno rilevanti ed efficienti sistemi di welfare, come la Svezia e la Danimarca.
Indicativo è anche il fatto che, per ritrovare indietro nel tempo un dato simile, bisogna tornare al 1996. Ma in quell'anno, se togliamo dalla spesa pubblica la voce degli interessi sul debito, che pesò allora per 11,5 punti di Pil trattandosi ancora della vecchia lira, se guardiamo quindi alla spesa pubblica primaria, scendiamo ad un valore pari solo al 41%. Se ripetiamo l'operazione del 2009 e togliamo i 4,6 punti di spesa per interessi sul debito, scendiamo invece poco al di sotto del 48%, un valore di quasi sette punti più elevato rispetto a quello del 1996.
Nelle cifre precedenti sta tutto il dramma della nostra spesa pubblica: al netto degli interessi è la più elevata in rapporto al Pil mai raggiunta nella storia d'Italia; inoltre tutto il risparmio conseguito attraverso il cosiddetto "dividendo di Maastricht", cioè il vantaggio derivante dalla conversione degli alti tassi di interesse che gravano sul debito espresso in lire rispetto i bassi tassi del debito espresso in una valuta forte quale è l’Euro, è stato interamente dilapidato. Dal 1996 al 2009 abbiamo risparmiato grazie all'Euro sette punti di Pil di spesa per interessi, ma nonostante tutto i vari governi che si sono succeduti sono riusciti nel miracolo di rendere un simile vantaggio invisibile agli occhi dei cittadini, che dall’introduzione dell’euro hanno ricavato solo una pesantissima perdita di potere d’acquisto.
A parità di pressione fiscale avremmo potuto portare il bilancio pubblico in attivo, oppure avremmo potuto migliorare il disavanzo e ridurre le tasse; invece abbiamo integralmente utilizzato il beneficio per spendere di più sull'insieme delle altre voci. Cosa accadrà quando i tassi di interesse, e con essi il costo del debito, riprenderanno a salire dagli attuali bassissimi valori, è facile immaginarlo.
In questo scenario la Banca d'Italia ha recentemente sancito che il debito italiano è aumentato di 15 miliardi nei primi due mesi dell'anno, mentre le entrate fiscali sono in diminuzione. Nella disperazione generale (negata per ordine di scuderia) si fa filtrare la notizia che l'agenzia delle entrate sta per acquisire una lista di 10.000 nomi di depositari italiani che hanno conti bancari in Svizzera; questi evasori potranno avvalersi dello scudo fiscale pagando un'aliquota del 7% prima che il fisco metta loro le mani addosso. Attilio Befera, direttore generale dell’Agenzia, deve aver pensato: "Meglio pochi maledetti e subito". E, se sono preoccupati, un motivo ci sarà.
Il quadro generale dell’eurozona è infatti decisamente fosco, ma nonostante tutto l'Italia pensa di essere al sicuro con il suo rapporto deficit/Pil inferiore a quello dei suoi partner europei . Purtroppo però è solo un gioco di specchi: le banche d'investimento comprano titoli italiani per mitigare il rischio dell'esposizione al ribasso su Portogallo e Spagna: sembra stiano seguendo un ordine ben preciso di vittime predestinate.
L'andamento della spesa pubblica e la diminuzione delle entrate fiscali non aiuta ad uscire dalla lista nera. Tremonti sa bene che gli scogli sono pericolosamente vicini e i passeggeri pare non sappiano neanche nuotare. Entro l'estate il governo dovrà infatti decidere quale segnale vorrà dare ai mercati e il ministro del Tesoro sta cercando di mitigare l'entità delle manovre da attuare nei prossimi anni con una grande svendita di immobili pubblici: come se una famiglia vendesse il proprio patrimonio per pagare le bollette. Se si considera che il patrimonio pubblico é la garanzia per il nostro debito, ben si comprende il perché non sia catastrofismo, ma realismo, il sostenere che l’Italia sia praticamente già alla canna del gas.
Basterà questo a calmare i mercati e a tenere unita la maggioranza del paese? Chi vivrà vedrà. Quello che è certo, però, è che la mancanza di trasparenza sui mercati avrà un prezzo in termini di compromessi da dover raggiungere tra forze politiche e sociali, in una gigantesca commedia degli errori in cui si dice che tutto va bene nello stesso tempo in cui si stringe la cinghia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Luca Mazzucato
di Luca Mazzucato
New York. La più grande banca d'affari americana è sotto inchiesta da qualche settimana per la madre di tutte le frodi. Il Senato americano ha rese pubbliche le email nelle quali i dirigenti della banca discutevano come fare il pacco e il doppio pacco ai loro investitori. Goldman Sachs avrebbe creato titoli tossici dai mutui spazzatura e, mentre con una mano li vendeva ai consumatori, con l'altra scommetteva sul loro crollo, guadagnando miliardi e facendo scoccare la scintilla della crisi. Le agenzie di rating erano parte integrante di quel sistema di corruzione.
Il santuario della finanza globale è oramai un fortino sotto assedio. L'accusa dell'autorità di vigilanza di Wall Street è estremamente grave perché cancella in un istante il mantra che ha fatto la fortuna di Goldman Sachs: “il cliente prima di tutto.” Un danno d'immagine difficile da recuperare, anche perché gli esperti del settore fanno capire che si tratta solo dell'inizio.
Finalmente si comincia a capire come facesse la banca d'affari a macinare utili quando tutto il mondo sprofondava insieme ai mutui subprime. “Ecco, con parole loro, Goldman Sachs mentre prende the big short, mentre scommette tutto contro il mercato dei mutui,” dice il Senatore Levin, presidente della commissione d'inchiesta del Senato USA che sta investigando sulle responsabilità delle banche nella crisi.
“Banche d'investimento come Goldman Sachs,” prosegue Levin, “non erano semplicemente i creatori del mercato dei mutui, ma anche i promotori di schemi che, mentre producevano utili per le banche, allo stesso tempo facevano esplodere la crisi. Hanno impacchettato mutui tossici all'interno di complessi strumenti finanziari, hanno ottenuto dalle agenzie di rating compiacenti il marchio AAA di totale affidabilità, li hanno venduti agli investitori, amplificando e allargando il rischio a tutto il mercato finanziario, tutto questo mentre scommettevano contro gli stessi titoli che vendevano, mietendo profitti alle spese dei loro clienti.”
Il Senato americano ha reso pubbliche le email scambiate tra i dirigenti della banca durante il periodo caldo del crollo dei mutui subprime nel 2007. Questa corrispondenza elettronica apre uno spaccato sul vero modus operandi del mondo della finanza, di cui Goldman è il santuario per eccellenza. Vediamo alcuni estratti delle conversazioni.
“Brutte notizie,” scrive un impiegato della Goldman il 17 Maggio 2007, quando un titolo che la Goldman aveva appena creato e venduto in calo fa perdere alla banca 2,5 milioni di dollari. La riposta del secondo impiegato è “Buone notizie... siamo protetti per 10 milioni... abbiamo guadagnato 5 milioni.” L'azienda ha preso 5 milioni scommettendo contro il titolo che aveva appena creato e venduto. In poche parole, la Goldman Sachs si assicurava (grazie all'AIG, il gigante assicurativo ora fallito proprio a causa di queste polizze stipulate con Goldman) contro il crollo dei titoli subprime che essa stessa vendeva.
Il 25 Luglio successivo, il capo delle operazioni della banca scrive di aver appena perso 322 milioni di dollari sui mutui residenziali – ma guadagnato 373 milioni scommettendo sul loro crollo. Venticinque minuti dopo la risposta del collega: “Questo ti mostra cosa sta succedendo a quelli che non hanno the big short,” ovvero quelli che non stavano scommettendo sul crollo dei mutui. Soltanto in quella transazione Goldman Sachs ha guadagnato 51 milioni di dollari. La voluminosa raccolta di tutte le email è aperta al pubblico sul sito del Senato americano.
La banca è sotto il doppio fuoco del Senato e della Security and Exchange Commission, che si gioca tutta la sua credibilità con questa inchiesta. I controllori devono far dimenticare di aver chiuso entrambi gli occhi per anni di fronte alle pratiche predatorie delle banche d'affari e soprattutto devono rifarsi della cantonata colossale presa con l'affare Bernie Madoff.
Il tempismo con cui è stata aperta l'inchiesta è favorevole all'Amministrazione Obama, che ha cominciato la discussione sulla riforma del sistema finanziario. Prima della Goldman Sachs, la fallita Lehman Brothers è stata passata ai raggi X e altre frodi finanziarie sono state portate alla ribalta delle cronache. La speranza è che queste inchieste servano a ricreare un momento favorevole alla riforma, che era altissimo nel 2008, all'apice della crisi, ma va scemando mentre l'economia americana riprende a viaggiare. Obama ha dichiarato che non firmerà la riforma se non conterrà regole precise per gli strumenti derivati.
Fa una certa impressione accorgersi come la Goldman Sachs abbia infiltrato il sistema politico e finanziario dell'intero pianeta. Solo alcuni esempi. In America, l'ultimo segretario del tesoro dell'Amministrazione Bush Hank Paulson e il precedente governatore del New Jersey Jon Corzine sono entrambi ex-amministratori delegati della banca. La Goldman Sachs è diretta responsabile, grazie ad un prestito, del disastro finanziario del governo greco e anche Romani Prodi si è rivolto alla banca americana durante il suo primo governo, per un enorme prestito ponte che ci permise di entrare nell'euro. Anche l'attuale governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha lavorato per Goldman per tre anni a partire dal 2002.
Secondo il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, la parte più scandalosa delle email rese pubbliche riguarda non le banche ma le agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's senza le quali niente di tutto questo sarebbe potuto accadere. Il 93% dei titoli finanziari, tutti basati sui mutui subprime, che ottennero nel 2006 il massimo dei voti, l'ambito AAA, sono stati declassati a titoli spazzature due anni dopo. Nelle email dei dipendenti delle agenzie di rating si ripete spesso la necessità di “massaggiare i subprime e i numeri AAA per mantenere le quote di mercato,” e “discutere criteri di aggiustamento” per decidere il valore di quei titoli “a causa della minaccia continua di perdere affari.” Un vero e proprio manuale su come falsificare il rating per massimizzare i profitti dei clienti delle agenzie.
Krugman, dalle pagine del New York Times, ha dichiarato che “una parte troppo grande della ricchezza e del talento degli Stati Uniti è stata usata per escogitare e vendere complessi sistemi finanziari – sistemi che hanno la tendenza a far saltare l'intera economia. Mettere fine questo stato di cose farà sicuramente male all'industria della finanza. E allora?”
