- Dettagli
- Scritto da Administrator
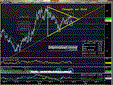 di Ilvio Pannullo
di Ilvio Pannullo
La notizia è ormai conosciuta da tutti. È sempre la stessa da qualche mese a questa parte. Apre tutti i giornali e i telegiornali della nazione, tanto da aver costretto anche il più riottoso italiano ad informarsi su cosa sia il differenziale tra i Buoni Ordinari del Tesoro italiani e i Bund tedeschi. Si potrebbe ragionevolmente considerarla un aggiornamento, un triste aggiornamento. Ecco l’ultimo: ieri, 4 agosto, per la seconda volta nell’anno 2011, le borse europee sono state sospese a causa delle perdite senza freni dei listini. Alla fine per l’Italia il risultato finale ha visto la Borsa di Milano perdere il 5,6%. Il numero merita però una spiegazione: ieri, 4 agosto, una tempesta di panico, paura, credibilità e speculazione si è abbattuta sui pilastri fondamentali della nostra economia. I titoli di Stato italiani, lo strumento economico-giuiridico grazie al quale il paese finanzia le proprie spese pubbliche, hanno ieri accusato il colpo raggiungendo il livello dei titoli spagnoli, salvo poi tornare sotto i 400 punti. Una ben triste consolazione.
Vanno giù tutte le Borse asiatiche: Tokyo, Shanghai, Sydney e Seul segnalano pesanti ribassi sulla scia delle chiusure negative dei mercati europei e di Wall Street. La peggiore è Taiwan che chiude a -5.58%. Peggio solo noi. Si comprende dunque la febbricitante attesa per la giornata di oggi, soprattutto per Piazza Affari, che apre negativa. Il Ftse Mib all'inizio della giornata di ieri segnava un calo del 3,23%. Raffica di sospensioni per eccesso di ribasso, poi il cambio di direzione e il leggero recupero. Negative anche le aperture di tutte le altre borse europee. Fin qui l’aggiornamento. Ma qual è il senso di tutto questo? Quali sono gli insegnamenti che se ne dovrebbero dedurre?
In primo luogo quanto sta accadendo ci dovrebbe far riflettere sul valore delle nostre democrazie rappresentative. La delegazione senza vincolo di mandato della sovranità popolare, in favore di una classe dirigente non preventivamente selezionata attraverso rigide procedure, ha drammaticamente fallito. Appare oltremodo evidente infatti che i nostri leader, tutti, dai politici di governo a quelli di opposizione, dal Presidente della Repubblica ai sindacati, agli industriali, hanno deciso di lasciarci andare a fondo pur di non ammettere che la causa principale della situazione è l’unificazione della moneta, e riconoscere, quindi, che il progetto era sbagliato. Non che sia sbagliata l’idea in sé, piuttosto sono state sbagliate le modalità attraverso le quali il progetto è stato realizzato. E’ sorprendente che perfino Berlusconi, accusato di tutte le colpe possibili e immaginabili, non abbia fatto nemmeno un’allusione a questo problema, nel discorso tenuto alla Camera e al Senato proprio per illustrare la situazione economica del Paese.
Costruire una Unione Economica e Monetaria doveva originariamente essere l’inizio di un progetto molto più ambizioso: creare un’Europa unita, una Nazione Europea. Le difficoltà politiche implicate nell’operazione erano straordinarie, apparentemente insuperabili. Appariva come un sogno, una meta: il mondo vero, irraggiungibile, indimostrabile, impromettibile, ma in quanto già pensato una consolazione, un dovere, un imperativo per tutte le classi dirigenti di un continente dilaniato da due guerre mondiali. Si pensò o si indusse a pensare che l’unificazione economica e monetaria avrebbe poi inevitabilmente portato, gradualmente, ad un’unificazione politica. Così non è stato. Dopo 25 anni dalla firma dell’Atto Unico Europeo nel 1986 e dopo 18 anni da quel 1° novembre del 1993, giorno in cui entrò in vigore il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione Europea, allora firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, nulla di tutto ciò che era stato promesso è stato realizzato. La patria europea rimane un miraggio e ciò che rimane è il senso di amarezza quando si coglie la distanza tra che poteva essere e ciò che è: un gigante economico ora incalzato dalle potenze emergenti di tutti i continenti, un nano politico privo di una voce che possa impegnare tutti gli Stati membri dell’Unione, un verme militare senza bandiera né inno.  In secondo luogo si dovrebbero analizzare le reali ragioni dello status quo e proporre delle soluzioni ragionevoli e dunque concretamente e politicamente praticabili. Proporre l’uscita della Germania dall’euro, come fatto dal premio nobel per l’economia Stiglitz, non può che essere una provocazione in quanto la moneta unica è stata creata proprio nell’interesse tedesco. Dunque cosa fare? Ritornare a battere una moneta il cui valore sia correlato alla nostra economia appare l’unica strada sana e ragionevole, non soltanto per noi ma per molti paesi dell’Unione, quali la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, il Portogallo, visto che è evidentemente una finzione e una falsità che paesi finanziariamente così deboli siano titolari di una moneta apparentemente forte perché corrispondente, sotto il nome di “euro”, al vecchio marco tedesco. È dunque di una finzione che si sta parlando, una falsità che i mercati e le Borse valori di tutto il mondo stanno “giustamente” distruggendo.
In secondo luogo si dovrebbero analizzare le reali ragioni dello status quo e proporre delle soluzioni ragionevoli e dunque concretamente e politicamente praticabili. Proporre l’uscita della Germania dall’euro, come fatto dal premio nobel per l’economia Stiglitz, non può che essere una provocazione in quanto la moneta unica è stata creata proprio nell’interesse tedesco. Dunque cosa fare? Ritornare a battere una moneta il cui valore sia correlato alla nostra economia appare l’unica strada sana e ragionevole, non soltanto per noi ma per molti paesi dell’Unione, quali la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, il Portogallo, visto che è evidentemente una finzione e una falsità che paesi finanziariamente così deboli siano titolari di una moneta apparentemente forte perché corrispondente, sotto il nome di “euro”, al vecchio marco tedesco. È dunque di una finzione che si sta parlando, una falsità che i mercati e le Borse valori di tutto il mondo stanno “giustamente” distruggendo.
Si parla molto in questi giorni dell’aggressione all’euro da parte degli speculatori, ma si tace sui motivi per i quali questa speculazione sia capace di metterci al tappeto con tanta facilità. Dopo tutto come europei siamo il popolo che ha conquistato il mondo intero, ad esclusione della penisola asiatica – geograficamente e antropologicamente l’Eurasia è infatti un unico blocco continentale. La popolazione sfiora i 450 milioni di persone, eppure sembra basti poco per metterle in ginocchio tutte in poco tempo. La verità è stata da tempo raccontata: l’euro – quella che ci viene venduta come la “nostra” moneta – è una moneta fabbricata (“emessa”) da una banca che porta un nome fittizio e truffaldino: si chiama Banca Centrale Europea, ma gli Stati europei non vi hanno quasi nulla a che fare in quanto appartiene a privati cittadini.
Il suo capitale sociale è diviso in quote di proprietà delle singole Banche Centrali Nazionali ed insieme formano il SEBC: il Sistema Europeo di Banche Centrali. Le singole Banche Centrali Nazionali sono a loro volta istituti di diritto pubblico (istituti cioè disciplinati dal diritto pubblico) la cui veste giuridica è quella di mere società per azioni. La proprietà delle azioni, del capitale sociale, implica dunque la proprietà degli istituti di diritto pubblico che sono a loro volta i proprietari della Banca Centrale Europea. Il cerchio si chiude quando si leggono i nomi delle società per azioni proprietarie del capitale sociale delle Banche Centrali Nazionali: semplicemente le banche e i gruppi assicurativi più potenti delle singole aree di influenza. Gli organismi di diritto pubblico chiamati a sorvegliare e garantire la correttezza del sistema bancario sono espressione delle banche e dei gruppi assicurativi, che vantano la più alta capitalizzazione nelle rispettive Borse valori. In altre parole controllori e controllati esprimono interessi comuni. Detto ancora più semplicemente: il conflitto d’interessi più devastante e spaventoso che si sia mai manifestato in questo angolo di mondo.  Per non rimanere sul vago e ragionare astrattamente, si fa riferimento a singoli gruppi di banchieri banchieri, famiglie ricchissime che esercitano l’attività bancaria fin da quando questa ha iniziato ad affermarsi sul nostro continente: dai Fugger di Amburgo ai Roschildt di Francoforte, che possiedono anche buona parte di altre banche, come ancora i famosi Rockfeller, e ancora re e regine anch’essi ricchissimi, quali la Regina d’Olanda Beatrice (una delle donne più ricche del mondo), la regina di Spagna Sofia, il re del Belgio Baldovino, la Regina d’Inghilterra Elisabetta II, solo per citare i più noti ed influenti. L’euro, dunque, è un caso unico nella storia: una moneta che non ha nessuno Stato alle spalle e che, di conseguenza, non ha nessuna entità istituzionale capace di garantirla. Si parla infatti di debiti “sovrani” quando ci si riferisce ai debiti degli Stati, in quanto sono gli Stati che sono “sovrani”, ossia esprimono potere, territorio e autorità su popoli che da loro dipendono e che al tempo stesso ne garantiscono la sovranità. La Banca Centrale Europea non possiede ovviamente nessuna sovranità, così come non la possiede l’Unione Europea non essendo il Parlamento europeo depositario ex lege di alcuna sovranità: entrambe, quindi, non sono (recte: non sarebbero) legittimate a produrre e far circolare nessuna moneta.
Per non rimanere sul vago e ragionare astrattamente, si fa riferimento a singoli gruppi di banchieri banchieri, famiglie ricchissime che esercitano l’attività bancaria fin da quando questa ha iniziato ad affermarsi sul nostro continente: dai Fugger di Amburgo ai Roschildt di Francoforte, che possiedono anche buona parte di altre banche, come ancora i famosi Rockfeller, e ancora re e regine anch’essi ricchissimi, quali la Regina d’Olanda Beatrice (una delle donne più ricche del mondo), la regina di Spagna Sofia, il re del Belgio Baldovino, la Regina d’Inghilterra Elisabetta II, solo per citare i più noti ed influenti. L’euro, dunque, è un caso unico nella storia: una moneta che non ha nessuno Stato alle spalle e che, di conseguenza, non ha nessuna entità istituzionale capace di garantirla. Si parla infatti di debiti “sovrani” quando ci si riferisce ai debiti degli Stati, in quanto sono gli Stati che sono “sovrani”, ossia esprimono potere, territorio e autorità su popoli che da loro dipendono e che al tempo stesso ne garantiscono la sovranità. La Banca Centrale Europea non possiede ovviamente nessuna sovranità, così come non la possiede l’Unione Europea non essendo il Parlamento europeo depositario ex lege di alcuna sovranità: entrambe, quindi, non sono (recte: non sarebbero) legittimate a produrre e far circolare nessuna moneta.
L’Unione Europea ricorda come struttura l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Unesco, e cioè organizzazioni internazionali istituite in forza di accordi internazionali, dotati ciascuno di essi di particolari compiti e particolari strutture. Rimane però il punto di cui sopra: non sono Stati sovrani. Farebbe davvero ridere se l’Onu, per esempio, pretendesse di emettere una moneta valida per tutti gli Stati che vi appartengono. L’euro è perciò una moneta “finta” e non regge alla prova dei fatti in quanto nessuno può garantirla. Dunque, delle due l’una: o si cambiano d’imperio gli obiettivi statutari della Banca Centrale Europea – cosa vietata ad oggi dagli stessi Statuti, della BCE e del SEBC – o gli Stati sovrani d’Europa, e cioè i popoli detentori delle singole sovranità nazionali, farebbero bene a salvaguardare i propri interessi per continuare ad immaginare un futuro libero e sostenibile.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Michele Paris
di Michele Paris
Nella giornata di lunedì, la Chrysler e il principale sindacato americano del settore automobilistico (UAW) hanno aperto ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro in scadenza a metà settembre. I negoziati, che giungono a pochi giorni dall’acquisizione della maggioranza della compagnia statunitense da parte di FIAT, richiederanno con ogni probabilità ulteriori concessioni ai dipendenti, dopo che i precedenti accordi e la bancarotta controllata del 2009 avevano già segnato un drastico peggioramento delle condizioni di lavoro e di retribuzione.
All’apertura delle trattative nella sede di Auburn Hills tra Chrysler e “United Auto Workers”, che rappresenta circa 23 mila lavoratori di questa azienda, faranno seguito quelle tra lo stesso sindacato, General Motors e Ford nel corso della settimana. Le cosiddette “Big Three” occupano oggi complessivamente poco più di 400 mila dipendenti e, in seguito ai fallimenti pilotati di GM e Chrysler, i loro profitti negli ultimi mesi sono tornati a far segnare numeri importanti.
Per salvare Chrysler, l’amministrazione Obama due anni fa sborsò qualcosa come 12,5 miliardi di dollari dei contribuenti. Una cifra oggi quasi tutta rimborsata, dopo che la settimana scorsa FIAT, con 560 milioni di dollari, ha rilevato la rimanente quota in mano al Tesoro USA. Grazie a questa recentissima operazione, la compagnia torinese controlla ora il 53 per cento di Chrysler.
L’obiettivo principale della dirigenza Chrysler nelle trattative con il sindacato è quello di non far aumentare in nessun modo i costi di produzione, così da mantenere l’attuale livello di competitività nei confronti dei produttori esteri. Nelle parole del vice-presidente per le relazioni con il personale, Al Iacobelli, Chrysler “ha la responsabilità di evitare un ritorno alle vecchie formule”, dove per vecchie formule s’intende il mero adeguamento degli stipendi dei lavoratori al costo della vita.
Grazie alle ristrutturazioni e agli accordi siglati a partire dal 2007, tutte e tre le compagnie di Detroit sono riuscite a ridurre notevolmente il costo della loro manodopera. Secondo stime interne, quattro anni fa un dipendente Chrysler costava mediamente 76 dollari l’ora tra stipendio e benefit, mentre oggi si è scesi a 49 dollari (56 per GM e 58 per Ford). Questa riduzione è stata favorita non solo dalla politica dell’amministrazione Obama, il cui obiettivo è l’aumento delle esportazioni americane tramite il ridimensionamento del costo della forza lavoro nel paese, ma anche dalla strategia della UAW (che controlla una fetta di Chrysler), più interessata al mantenimento dei profitti e delle posizioni privilegiate dei suoi dirigenti che all’impoverimento dei lavoratori.
 Tramite il presidente Bob King, la UAW ha infatti già fatto sapere di essere sulla stessa lunghezza d’onda dei vertici di Chrysler. La preoccupazione principale di King sembra essere quella di mantenere l’azienda competitiva, per questo ha promesso che non verranno ripetuti gli errori del passato. In sostanza, la UAW non intende chiedere alcun ritocco verso l’alto della paga oraria dei lavoratori, puntando piuttosto sul diritto di ricevere una parte dei profitti, impennatisi nei primi mesi del 2011. Le retribuzioni, in definitiva, dovranno essere legate alla produttività e agli utili della compagnia, la quale potrà così trasferire le eventuali perdite agli stessi lavoratori nei periodi negativi.
Tramite il presidente Bob King, la UAW ha infatti già fatto sapere di essere sulla stessa lunghezza d’onda dei vertici di Chrysler. La preoccupazione principale di King sembra essere quella di mantenere l’azienda competitiva, per questo ha promesso che non verranno ripetuti gli errori del passato. In sostanza, la UAW non intende chiedere alcun ritocco verso l’alto della paga oraria dei lavoratori, puntando piuttosto sul diritto di ricevere una parte dei profitti, impennatisi nei primi mesi del 2011. Le retribuzioni, in definitiva, dovranno essere legate alla produttività e agli utili della compagnia, la quale potrà così trasferire le eventuali perdite agli stessi lavoratori nei periodi negativi.
Che quelle avviate lunedì non siano precisamente trattative tra due parti con interessi contrastanti è risultato d’altra parte evidente dal clima più che cordiale che ha caratterizzato la cerimonia di Auburn Hills. Le già deboli resistenze manifestate dalla UAW nel 2007, quando vennero indetti alcuni scioperi, difficilmente si ripresenteranno in questa occasione, anche perché le condizioni del salvataggio di Chrysler e GM da parte dell’amministrazione Obama nel 2009 prevedevano, tra l’altro, la rinuncia al diritto di scioperare.
L’erosione dei diritti dei lavoratori delle Big Three aveva subito un’accelerazione con i contratti sottoscritti nel 2007. In quell’occasione erano state fissate alcune condizioni la cui portata difficilmente può essere sottovalutata. Le compagnie automobilistiche, ad esempio, erano state esentate dall’obbligo di contribuire all’assistenza sanitaria dei lavoratori in pensione e, soprattutto, gli accordi ora in scadenza avevano creato un doppio sistema di trattamento economico per i dipendenti, con gli stipendi dei neo-assunti di fatto dimezzati (circa 14 dollari l’ora) rispetto a quelli assicurati a coloro che già facevano parte della forza lavoro.
La crisi economica del 2008 e la bancarotta forzata del 2009 portarono poi ad ulteriori concessioni, come la già ricordata clausola che proibisce gli scioperi e il ricorso obbligatorio ad un arbitrato in caso di questioni irrisolte tra azienda e sindacati. Quest’ultima condizione pare sia stata inserita negli accordi su insistenza di Sergio Marchionne, oggi CEO di Chrysler. Non è un caso perciò che Chrysler abbia annunciato di essere pronta a ricorrere proprio all’arbitrato nel caso di un improbabile stallo sulla questione dell’adeguamento degli stipendi all’inflazione.
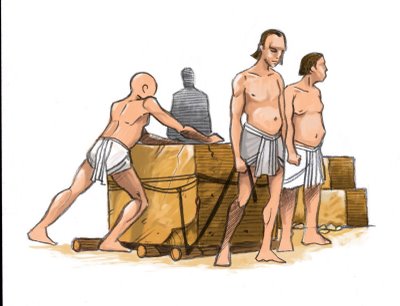 Secondo quanto pubblicato dalla stampa di Detroit, quando in grado di produrre utili, Chrysler offrirebbe ai propri dipendenti bonus nell’ordine di 4 / 5 mila dollari l’anno. In cambio, tuttavia, verranno richiesti nuovi sacrifici ai lavoratori: maggiore flessibilità, soppressione di alcune festività pagate e aumento della quota riservata alla copertura sanitaria proveniente dagli stipendi (attualmente il 7 per cento), così da mantenere appunto la competitività con i produttori rivali in territorio americano.
Secondo quanto pubblicato dalla stampa di Detroit, quando in grado di produrre utili, Chrysler offrirebbe ai propri dipendenti bonus nell’ordine di 4 / 5 mila dollari l’anno. In cambio, tuttavia, verranno richiesti nuovi sacrifici ai lavoratori: maggiore flessibilità, soppressione di alcune festività pagate e aumento della quota riservata alla copertura sanitaria proveniente dagli stipendi (attualmente il 7 per cento), così da mantenere appunto la competitività con i produttori rivali in territorio americano.
Il pacchetto proposto da Chrysler, su cui convergerà senza troppi problemi il sindacato, sarà da modello anche per le trattative con GM e Ford e servirà a non far lievitare il costo del lavoro nei prossimi anni. Tutte e tre le compagnie di Detroit hanno ormai raggiunto il misero livello di paga oraria dei loro competitori tedeschi, giapponesi e coreani che operano svariati impianti non sindacalizzati soprattutto nel sud degli Stati Uniti.
Il ridimensionamento del costo del lavoro è il fattore principale che ha contribuito al ritorno agli utili delle Big Three nell’ultimo anno e mezzo. Le tre aziende nel 2010 hanno fatto segnare profitti per un totale di 10,65 miliardi di dollari. Nel primo trimestre di quest’anno, inoltre, GM ha incassato 3,2 miliardi di utili, Ford 2,6 miliardi e Chrysler 116 milioni. Come confermano i dati ufficiali, l’aumento del fatturato e degli utili derivano in gran parte dalle performance in Nord America dove, secondo un recente articolo del Detroit Free Press, tra luglio e settembre Ford prevede di aumentare la propria produzione di 44 mila veicoli rispetto all’anno scorso.
Nella retorica dei vertici delle case automobilistiche e dei sindacati, insomma, il punto centrale delle trattative in corso è identico a quello sostenuto da trent’anni a questa parte, ovvero da quando è iniziato l’assalto ai diritti conquistati con fatica dai lavoratori nei decenni precedenti. Solo con le concessioni e i sacrifici, cioè, si potranno conservare i posti di lavoro, nonostante l’industria americana abbia visto svanire oltre un milione di posti nel settore automobilistico negli ultimi tre decenni.
In questa corsa verso la creazione di una forza lavoro a basso costo negli USA, il sindacato automobilistico americano ha giocato un ruolo di spicco. Assecondando sempre più il volere dei vertici aziendali, la UAW ha così voltato progressivamente le spalle agli interessi dei propri iscritti - scesi significativamente da 1,5 milioni nel 1979 a 390 mila nel 2010 - contribuendo ad affermare il “modello Detroit” nelle relazioni aziendali. Un modello che la stessa FIAT nei mesi scorsi ha imposto negli impianti italiani con il sostanziale accordo anche dei sindacati nostrani.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Alla fine di un lungo travaglio, giovedì sera si è concluso uno dei parti più dolorosi che l'Europa abbia affrontato nella sua storia unitaria. Finalmente da Bruxelles è arrivato un programma concreto per salvare la Grecia dalla bancarotta. Era ora. Anche in Italia possiamo tirare un lungo sospiro di sollievo. Dai nostri incubi si allontanano i mostri della speculazione e i fantasmi di un debito pubblico che rischiava di farci morire dissanguati.
Dopo ore di colloqui, i diciassette capi di Stato e di Governo dell'Eurozona si sono accordati sugli aiuti da destinare al Paese ellenico: 109 miliardi di euro. Ma non finisce qui, questi sono solo i fondi messi a disposizione da Ue e Fmi. C'è poi il tanto vituperato "settore finanziario" che, stando alle parole di Nicolas Sarkozy, nei prossimi 30 anni sosterrà la Grecia per una cifra pari a 135 miliardi.
L'intervento sarà "su base volontaria" (neanche troppo) e consisterà nello scambio di bond o nelle più oscure pratiche del "rollover" e del "buyback". In sostanza, i privati che già possiedono titoli di Stato di Atene sono chiamati a riacquistarli alla scadenza, sostituendoli però con obbligazioni di durata maggiore e dagli interessi meno redditizi.
Insieme a Irlanda e Portogallo (gli altri due Paesi destinatari di aiuti internazionali), la Grecia potrà poi beneficiare di più tempo per restituire i prestiti: dagli attuali sette anni e mezzo, le scadenze si dilateranno a un minimo di 15 anni, che potrà estendersi fino a 30. Il tutto con dei tassi d'interesse ben più bassi di quanto sperimentato finora, dal 4,5 al 3,5%.
 Ma la parte più interessante del nuovo piano arriva con l'entrata in gioco dell'Efsf, il Fondo Ue "salva-stati", nato appena un anno fa. I suoi poteri saranno estesi, arrivando a comprendere la possibilità di acquistare titoli di Stato (non solo greci, ma di tutti i "Paesi in difficoltà") anche sul mercato secondario (vale a dire le piazze dove girano le obbligazioni scambiate abitualmente, non quelle appena emesse, che invece costituiscono il mercato primario). Insomma, se ancora non siamo arrivati ai tremontiani Eurobond (titoli sul debito pubblico comunitario), poco ci manca.
Ma la parte più interessante del nuovo piano arriva con l'entrata in gioco dell'Efsf, il Fondo Ue "salva-stati", nato appena un anno fa. I suoi poteri saranno estesi, arrivando a comprendere la possibilità di acquistare titoli di Stato (non solo greci, ma di tutti i "Paesi in difficoltà") anche sul mercato secondario (vale a dire le piazze dove girano le obbligazioni scambiate abitualmente, non quelle appena emesse, che invece costituiscono il mercato primario). Insomma, se ancora non siamo arrivati ai tremontiani Eurobond (titoli sul debito pubblico comunitario), poco ci manca.
In realtà questo passaggio ha anche una fondamentale importanza politica. Affidando all'Efsf il compito di riempirsi di spazzatura, l'Europa solleva da questa gravosa responsabilità la Bce. Si tratta di una moneta di scambio. Lo scaricabarile sul Fondo salva-stati ha portato Jean Claude Junker, presidente dell'istituto di Francoforte, a lasciar perdere la crociata contro il coinvolgimento dei privati nel piano di salvataggio.
A ben vedere, l’hanno chiamato Piano Marshall più che altro per megalomania, o forse solo per nobilitare la miserabile condizione in cui si è ridotta la moneta unica ad appena dieci anni dalla sua nascita. Fatto sta che il paragone storico sembra un po' azzardato, se confrontiamo le prospettive dell'economia Usa nell'immediato dopoguerra a quelle dell'Ue nei primi anni Dieci del Duemila. Eppure, arrivati a questo punto, c'è veramente di che rassicurarsi.
Fino a poco prima del vertice comunitario, infatti, le cose sembravano aver preso una piega ben diversa. Al punto che quel cervellone di Jean Claude Junker, presidente dell'Eurogruppo, arrivando in mattinata a Bruxelles, aveva pensato bene di dichiarare urbi et orbi che la possibilità di un default greco non era da escludere. Parole che, come era ampiamente prevedibile, hanno avuto il solo risultato di far crollare d'un colpo le Borse europee.
Ma il buon Junker non aveva tutti i torti, almeno stando a quello che è successo nella notte berlinese tra mercoledì e giovedì. Al termine di un colloquio durato sette ore, il presidente francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela Merkel erano arrivati a un'intesa piuttosto preoccupante. Avevano previsto, infatti, un "default selettivo" (cioè limitato e controllato) del debito greco.
 Un vero rischio, soprattutto perché una scelta del genere avrebbe messo l'Europa del Sud in balia delle odiose agenzie di rating targate Usa. Il probabile filotto di downgrade sui debiti dei Paesi periferici dell'Eurozona avrebbe potuto scatenare un effetto domino difficilmente controllabile. Si sarebbe così potuta verificare l'ipotesi più temuta: l'estendersi della crisi debitoria anche a Spagna e Italia.
Un vero rischio, soprattutto perché una scelta del genere avrebbe messo l'Europa del Sud in balia delle odiose agenzie di rating targate Usa. Il probabile filotto di downgrade sui debiti dei Paesi periferici dell'Eurozona avrebbe potuto scatenare un effetto domino difficilmente controllabile. Si sarebbe così potuta verificare l'ipotesi più temuta: l'estendersi della crisi debitoria anche a Spagna e Italia.
A quel punto per noi italici sarebbe stato l'armageddon, considerando che già da settimane siamo nel mirino della speculazione internazionale. Per fortuna così non è stato. Questa versione posticcia del Piano Marshall per la Grecia ci ha davvero levato le castagne dal fuoco.
Se Atene è salva, improvvisamente anche la nostra situazione non desta più tante preoccupazioni. E' così soprattutto agli occhi degli speculatori, che dalla sera alla mattina non hanno più tutte le ragioni del mondo per scommettere contro di noi. Certo, qualcuno potrebbe continuare, ma se così fosse le ragioni non andrebbero più ricercate nel quadro internazionale, quanto nella nostra patetica condizione interna.
Difficilmente potremmo chiedere all'Europa più di quello che ha già fatto. Nel documento finale del vertice, i Paesi dell'Eurozona hanno perfino avuto lo stomaco di inserire un paragrafetto per complimentarsi con noi: "Apprezziamo il programma di bilancio presentato recentemente dal governo italiano, che assicurerà il ritorno del deficit sotto il 3% nel 2013 e il pareggio di bilancio nel 2014". Queste parole, insieme al piano per i nostri cugini greci e all'abbandono dell'idea francese di tassare le banche, hanno fatto sì che Piazza Affari chiudesse la settimana in testa alla classifica continentale, facendo segnare un roboante +3,76%. A questo punto, se cadremo ancora, sarà solo per colpa nostra.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Ilvio Pannullo
di Ilvio Pannullo
Tutto pare abbia avuto inizio in Grecia, un tempo culla della democrazia e patria del pensiero classico, oggi terra di sciacalli, periferia degradata di quel mondo occidentale che ha contribuito a forgiare. Ma a quanto ammonta realmente il debito pubblico della Grecia? Visto che potrebbe far saltare l'intera zona euro vale la pena di analizzare qualche numero: si tratta di 350 miliardi di euro.
È certo una bella somma. La quale però rappresenta soltanto il 3,7% del Pil dell'intera zona euro, esclusa quindi una grande economia come il Regno Unito. Non soltanto: il 43% di tale debito è in mano a creditori greci, che per metà sono banche. Quindi, se la matematica non è un’opinione, poco più di 150 miliardi di euro andrebbero espunti dal conto.
Dal totale vanno ancora tolti 7 miliardi di debiti verso gli Usa, 3 verso la Svizzera, circa 2 nei confronti del Giappone. Il debito greco verso la Ue (banche e Stati compresi) consistente soprattutto in obbligazioni e altri titoli, ammonta dunque a meno di 190 miliardi di euro, di cui circa 35 sono dovuti alla Bce. Ora, dal 2008 ad oggi i Paesi europei, Svizzera esclusa, hanno speso o accantonato oltre 3.000 miliardi di euro per salvare le proprie istituzioni finanziarie. Ed ora davvero tremano perché un'economia tutto sommato periferica è in difficoltà per ripagare, a rate, poco più del 6% di tale somma? È evidente che ci sia qualcosa che non va nell'intera faccenda.
Le cose che non vanno sono principalmente due. La crisi greca è in primo luogo un'anteprima di quel che potrebbe succedere ad altri Paesi, Italia compresa, se i governi europei non la smettono di subire le manovre del sistema finanziario, ivi comprese le agenzie di valutazione, e non provano sul serio a regolarlo, anche per evitare che ci piombi addosso tra breve una crisi peggiore di quella del 2008. Lo scenario comprende com'è ovvio il rinnovo potenziato di manovre speculative che i maggiori gruppi finanziari costruiscono scientemente per estrarne il maggior profitto possibile in forma di interessi e plusvalenze; il che implica, come insegnano i modelli di gestione del rischio, il far correre un rischio elevato non già ai gruppi stessi, bensì ai cittadini oggi greci, domani spagnoli o italiani.
Ma comprende anche una spinta selvaggia alle privatizzazioni, che essendo condotte sotto la sferza della troika Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea, consisteranno al caso in vere e proprie svendite di immensi patrimoni nazionali. L'Italia, dopotutto, ha ottomila chilometri di coste e centinaia di isole da mettere all'asta, più il Colosseo e magari l'intera Venezia; altro che la Grecia.
 Una seconda cosa che non va è la Bce. Il suo limite fondamentale, imposto dal trattato istitutivo dell’Unione Europea, sta nell'avere come massimo scopo statutario la stabilità dei prezzi, ossia la difesa dall'inflazione. Ciò spiega in parte la lentezza e la goffaggine con cui si è mossa a fronte della crisi greca. Ma un simile limite equivale a decidere per legge, poniamo, che il pronto soccorso del maggior ospedale cittadino si occupa soltanto di lesioni alla gamba sinistra. Le altre due banche centrali dell'Occidente, la Banca d'Inghilterra e la Fed, hanno tra i loro scopi statutari anche lo sviluppo e la crescita dell'occupazione.
Una seconda cosa che non va è la Bce. Il suo limite fondamentale, imposto dal trattato istitutivo dell’Unione Europea, sta nell'avere come massimo scopo statutario la stabilità dei prezzi, ossia la difesa dall'inflazione. Ciò spiega in parte la lentezza e la goffaggine con cui si è mossa a fronte della crisi greca. Ma un simile limite equivale a decidere per legge, poniamo, che il pronto soccorso del maggior ospedale cittadino si occupa soltanto di lesioni alla gamba sinistra. Le altre due banche centrali dell'Occidente, la Banca d'Inghilterra e la Fed, hanno tra i loro scopi statutari anche lo sviluppo e la crescita dell'occupazione.
Scopi che perseguono anche creando esplicitamente nuovo denaro: una funzione fondamentale che gli stati europei hanno ceduto alla Bce, ma che questa non sembra voler esercitare come, dove e quando ne avrebbero bisogno. Per questo motivo nella Ue cominciano a moltiplicarsi le voci favorevoli a un ampliamento degli scopi statutari della Bce.
La crisi greca potrebbe essere una buona occasione per passare dalle voci all'azione. Sempre che i governi non temano di disturbare la macchina di cui sono per ora a rimorchio. Diversamente sarà difficile glissare o tacciare di complottiamo quanti sono pronti a giurare che quanto sta accadendo è il tentativo di ridurre a discrezione gli Stati, un tempo sovrani ed ora schiavi del sistema finanziario e monetario. L’illogicità manifesta delle politiche europee non lascia, infatti, spazio a dubbi.
Il programma di salvataggio della Grecia su cui si è trovata la mediazione tra i paesi dell’area euro, ed essenzialmente tra la Germania e gli altri paesi, serve ad esempio solo per guadagnare tempo, ma non consente di andare alla soluzione dei problemi strutturali della Grecia. Le condizioni del prestito, seppur preveda tassi sensibilmente inferiori a quelli insostenibili ai quali la Grecia è in grado attualmente di trovare credito sul mercato, non è compatibile con il basso tasso di crescita al quale la Grecia è condannata nei prossimi anni dalla necessità di tagliare il suo deficit pubblico, dalla sua scarsa competitività internazionale e dalla probabile stagnazione della domanda interna europea. I mercati ne hanno consapevolezza e, quindi, le risorse che eventualmente verranno dedicate a tamponare la crisi rischiano di essere sprecate.
 Quel che appare evidente è che l’incertezza dell’azione europea riflette l’inesistenza di una strategia europea di uscita dalla crisi, come del resto non c’è stata una effettiva azione europea di contrasto alla crisi. Sono stati i singoli stati ad intervenire con una certa efficacia di fronte all’emergenza della crisi finanziaria ed a tentare di coordinarsi tra di loro, mostrando ancora una volta l’evanescenza politica delle istituzioni economiche europee. Ma quel che ha parzialmente funzionato nell’emergenza non funziona più nel momento in cui i singoli stati europei si trovano ad affrontare in modo non coordinato il mutamento profondo della geografia economica del mondo con cui devono misurarsi per uscire dalla crisi.
Quel che appare evidente è che l’incertezza dell’azione europea riflette l’inesistenza di una strategia europea di uscita dalla crisi, come del resto non c’è stata una effettiva azione europea di contrasto alla crisi. Sono stati i singoli stati ad intervenire con una certa efficacia di fronte all’emergenza della crisi finanziaria ed a tentare di coordinarsi tra di loro, mostrando ancora una volta l’evanescenza politica delle istituzioni economiche europee. Ma quel che ha parzialmente funzionato nell’emergenza non funziona più nel momento in cui i singoli stati europei si trovano ad affrontare in modo non coordinato il mutamento profondo della geografia economica del mondo con cui devono misurarsi per uscire dalla crisi.
L’idea tedesca di poter imporre forti cure di risanamento finanziario ai paesi europei in deficit negando al tempo stesso sia un aiuto finanziario sia un’espansione della sua domanda interna che consentirebbe di trainare la loro ripresa economica è inconsistente. Essa rappresenta il vero pericolo per la tenuta della moneta unica ed il principale ostacolo per affrontare i nodi istituzionali che rendono evanescente la governance economica dell’Europa. In sintesi, il mercato interno europeo è ancora troppo importante per poter immaginare che la crescita di tutti gli stati europei possa essere trainata solo dalla crescita economica extraeuropea.
Delle due l’una: o si trova un modo per ristrutturare i debiti sovrani (e di possibilità alternative ce sono; a mancare è come sempre una chiara volontà politica in questo senso da parte dei governi europei) o la ristrutturazione forzata dei bilanci continentali farà piombare l’Europa in una profonda recessione. Se, come tutto fa pensare, verrà scelta la seconda ipotesi c’è già chi ha proposto una soluzione: secondo il premio Nobel per l’economia, Joseph Stiglitz, l’unica possibilità sarebbe in questo caso rappresentata dall’uscita della Germania da Eurolandia e dalla conseguente svalutazione della moneta unica. Un fallimento epocale per il nostro continente, che segnerebbe la fine di ogni speranza per quanti sognano un’Europa politicamente unita e federale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Ancora mani nei capelli a Piazza Affari, che ieri ha lasciato sul campo più del 3%. Neanche a dirlo, maglia nera d'Europa. Come Willie il Coyote, gli operatori di Borsa hanno creduto di vedere una luce infondo al tunnel, ma era solo il fanale del treno che stava per travolgerli. Dopo i sospiri di sollievo e le pacche sulle spalle per la rapidità con cui è stata approvata la manovra finanziaria, oggi l'Italia ha dovuto fare i conti con il cinismo dei mercati. E ci siamo accorti che tutti quei miliardi di tagli e nuove imposte, almeno per il momento, non hanno ottenuto lo scopo desiderato.
A trascinare nel baratro il listino di Milano sono stati soprattutto i titoli bancari, che hanno fatto segnare perdite da incubo. E questo la dice lunga anche sul credito di cui godono a livello internazionale i famosi stress test della European Banking Authority, tutti superati (quasi) a pieni voti dagli istituti italiani. Proprio questo è il vero punto dolente. Si pensava che la promozione dei cinque maggiori istituti di credito italiani alle prove sulla solidità di capitalizzazione avrebbe finalmente spento la sete degli speculatori. Ci si aspettava un "rimbalzo", vale a dire una netta ripresa dopo le gravi perdite delle ultime sedute.
Così non è stato. E la ragione è tragicamente semplice. Quelle stesse banche sono stracolme di titoli di Stato italiani e questo non può che spingere a scommettere contro di loro. Non c'è stress test che tenga: l'Unione Europea non ha ancora messo in campo un piano minimamente affidabile per traghettare la Grecia verso la salvezza, dunque l'ipotesi che la crisi del debito si espanda ai Paesi periferici dell'eurozona è più che probabile. E fra questi Paesi, è evidente, i mercati puntano il dito contro di noi. Come in un reality show, siamo stati nominati. Sia perché abbiamo un debito pubblico mostruoso, sia perché appariamo totalmente alla deriva dal punto di vista amministrativo.
Il quadro è confermato dal continuo espandersi dello spread fra i Btp e i Bund decennali. Il differenziale di rendimento fra i titoli di stato italiani e tedeschi è schizzato ancora una volta verso la troposfera, superando i 335 punti base. Tradotto, questo significa che per convincere gli investitori a finanziare il nostro debito dovremo pagare degli interessi sempre più alti. A sua volta questi maggiori esborsi porteranno con sé un ulteriore aumento del debito. Insomma, un cane che si morde la coda. Con buona pace di Tremonti, ancora convinto che basti tirare delle righe più o meno a caso sulle varie voci di bilancio per far quadrare i conti.
 Ora sarebbe il caso che il superministro rendesse ragione del suo fallimento, anche se probabilmente nessuno sarà in grado di richiamarlo alle sue responsabilità, né dall'opposizione, né tantomeno dalla maggioranza. La velocità fulminea con cui è stata approvata la manovra aveva degli scopi precisi: rassicurare i mercati, allontanare gli speculatori, contenere la diabolica forbice dello spread. Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. Sono bastate poche ore per rendersene conto. Perciò tanto valeva prendersi più tempo per scrivere la legge e partorire un testo più assennato. Magari un provvedimento che, aldilà della pura aritmetica contabile, contenesse norme che in grado di farci crescere nel lungo periodo.
Ora sarebbe il caso che il superministro rendesse ragione del suo fallimento, anche se probabilmente nessuno sarà in grado di richiamarlo alle sue responsabilità, né dall'opposizione, né tantomeno dalla maggioranza. La velocità fulminea con cui è stata approvata la manovra aveva degli scopi precisi: rassicurare i mercati, allontanare gli speculatori, contenere la diabolica forbice dello spread. Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. Sono bastate poche ore per rendersene conto. Perciò tanto valeva prendersi più tempo per scrivere la legge e partorire un testo più assennato. Magari un provvedimento che, aldilà della pura aritmetica contabile, contenesse norme che in grado di farci crescere nel lungo periodo.
In ogni caso, è anche possibile che la realtà sia più semplice di così. Dire che i mercati hanno bocciato la manovra è forse un po' ingenuo. E' difficile pensare che tutti gli investitori internazionali si siano accuratamente spulciati le pagine della nuova legge fra la sera di venerdì e la mattina di lunedì. L'Italia non è stata bocciata perché le misure appena approvate in Parlamento appaiono inadeguate alla comunità finanziaria. Purtroppo la situazione è ben più grave. Continuiamo a ricevere attacchi semplicemente perché non siamo un Paese credibile. Il verdetto dei mercati non è tanto contro la singola legge, ma contro l'intero Governo.
Nessuno ritiene che il nostro Esecutivo abbia la forza per fare le riforme di cui l'Italia avrebbe davvero bisogno. In questo senso, l'ultima manovra rappresenta solo un'ulteriore conferma di cui forse non c'era neanche bisogno. Agli osservatori europei già sembra assurdo che la maggioranza di Berlusconi sia ancora in piedi, figurarsi se possono credere a un piano di rilancio. I nostri cugini del continente sono più attenti di quanto crediamo. Si sono accorti che il braccio destro di Tremonti è indagato per corruzione e che lo stesso superministro è in rotta sia col Pdl che con la Lega. Sanno anche che il ministro per le Politiche agricole è indagato per mafia, che non abbiamo idea di chi nominare alla Giustizia e siamo in forte imbarazzo sul nome da scegliere per il dopo Draghi al vertice di Bankitalia. Purtroppo, non gli sfugge nemmeno che il lunedì è meglio lasciare in pace il premier italiano, perché è impegnato in tribunale.
Da questo punto di vista é davvero significativa l'ultima copertina di Der Spiegel, uno dei periodici più autorevoli d'Europa, vero totem della stampa tedesca. In prima pagina, sotto il titolo "Ciao bella", c'è un'odiosa vignetta. Sul disegnino stilizzato dell'Italia sta in piedi il nostro primo ministro vestito da gondoliere. Sotto di lui ci sono due sirenette tutt'altro che innocenti, piuttosto simili a due personaggi tristemente noti a tutti noi. In mezzo, un po' in secondo piano, il dettaglio più inquietante. Un piatto di spaghetti con sopra una P38, richiamo evidente agli anni di piombo. Quasi a ricordarci che noi la chiamiamo seconda Repubblica, ma in fondo la cesura storica ce la siamo inventata di sana pianta. Governiamo ancora come quando c'era la lira.
