- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Piogge con andamento e intensità intermittenti, trombe d’aria e ondate di calore: cambiamenti climatici dall’entità ancora poco conosciuta che stanno mettendo a repentaglio le aree urbane italiane. Ma cause antropiche, scelte insediative e fenomeni di abusivismo ne hanno amplificato gli impatti.
Dal 2010 a oggi, nella Mappa del rischio climatico nelle città italiane, elaborata da Legambiente, sono ottanta i Comuni dove si sono registrati impatti rilevanti, quali allagamenti, frane, esondazioni, trombe d’aria, temperature estreme, danni alla infrastrutture e al patrimonio storico.
Centododici i fenomeni meteorologici: trenta casi di allagamento da piogge intense, trentadue casi di danni alle infrastrutture per temporali, otto casi di danni al patrimonio storico (fra questi, mura aureliane nella Capitale, archivio di Stato, biblioteca nazionale e Palazzo Reale a Genova), ventidue casi di eventi causati da trombe d’aria e venti da esondazioni fluviali.
Risultato: ventinove giorni di stop a metropolitane e treni urbani, di cui dieci a Roma, nove a Milano, otto a Genova, sei a Napoli e cinque a Torino; trentotto giorni di blackout elettrico da Nord a Sud con una frequenza costante e un apice il 4 febbraio 2012 in cui quattro Regioni si sono trovate al buio, con centoventimila e rotti utenze senza energia elettrica: novantacinquemila nel Lazio, circa settemila in Abruzzo, quasi seimila in Molise, più di dodicimila in Campania.
Individuare il rapporto tra accelerazione dei processi climatici e problematiche legate a fattori insediativi o infrastrutturali del territorio italiano è la nuova, urgente sfida per rispondere con nuovi modelli di intervento. Che non si riducano a intubare o deviare fiumi, alzare argini o asfaltare altre aree urbane. Perché, se è vero che la spiegazione può essere di natura idrogeologica, è altrettanto plausibile ricercare la causa degli effetti dei cambiamenti climatici nel modo in cui si è costruito e in cui sono stati gestiti il territorio e la rete di smaltimento delle piogge. Un esempio per tutti: la portata delle piogge che è caduta sulle province sarde di Olbia, Nuoro e Ogliastra è stata pari al quantitativo che dovrebbe cadere in sei mesi, ma la ragione dei danni (sedici morti, duemila sfollati, diecimila utenze senza elettricità) è da attribuire alla maniera nella quale si è edificato negli ultimi decenni. Idem per la provincia di Messina in occasione dell’alluvione dell’ottobre 2009, in Basilicata nel dicembre 2013, a Parma nell’ottobre 2014 e a Roma, dove le zone intorno ai fiume Tevere e Aniene, in cui si è gettato cemento abusivamente, sono a forte rischio allagamento.
Un esempio per tutti: la portata delle piogge che è caduta sulle province sarde di Olbia, Nuoro e Ogliastra è stata pari al quantitativo che dovrebbe cadere in sei mesi, ma la ragione dei danni (sedici morti, duemila sfollati, diecimila utenze senza elettricità) è da attribuire alla maniera nella quale si è edificato negli ultimi decenni. Idem per la provincia di Messina in occasione dell’alluvione dell’ottobre 2009, in Basilicata nel dicembre 2013, a Parma nell’ottobre 2014 e a Roma, dove le zone intorno ai fiume Tevere e Aniene, in cui si è gettato cemento abusivamente, sono a forte rischio allagamento.
Così Milano, Pescara, Genova e la Toscana. A significare che alcune zone sono più esposte al rischio di altre, innanzitutto per ragioni idrogeologiche: l’81,2 per cento dei Comuni è, infatti, a rischio di dissesto idrogeologico con quasi sei milioni di persone che abitano in quelle aree. E che rischiano di andare sott’acqua ogni autunno. E le spese per la corsa ai ripari si vanno a sommare, ogni volta, a quei sessantuno miliardi e mezzo di euro spesi dal 1944 al 2012 per danni provocati, appunto, da eventi estremi.
Urge arrivare all’approvazione del piano nazionale di adattamento che permetterebbe di passare dagli obiettivi generali agli interventi specifici, presenti nella programmazione 2014-2020 dei fondi europei. Perché una pioggia di soldi non vada sprecata. E centotrentotto vittime siano le ultime.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
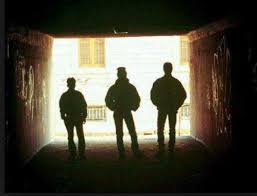 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Sono oltre venticinquemila i minori autori di reato segnalati dall’Autorità giudiziaria ai Servizi minorili per gli interventi socioeducativi e l’attivazione dei provvedimenti disposti nei loro confronti. Secondo quanto si legge nel Report dell’Istat - "I giovani nelle strutture minorili della giustizia" - redatto in collaborazione con il dipartimento per la Giustizia minorile del ministero della Giustizia, sono prevalentemente italiani e di sesso maschile, con un’età compresa fra i sedici e i diciassette anni, e risiedono principalmente in Sicilia e Puglia.
Mentre i minori stranieri, che sono quasi quattromila, abitano in Lombardia ed Emilia Romagna e provengono da altri Paesi europei, dalla Romania, dall’Albania, dall’Africa, vedi Marocco e Tunisia, dall’America e dall’Asia.
La maggior parte dei minori ha un solo procedimento penale a proprio carico, accusata soprattutto di reati contro il patrimonio - furto e rapina, ricettazione, danneggiamento - violazioni delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti, lesioni personali volontarie e di violenze private e minacce. Non trascurabile la percentuale di coloro che commettono violazioni del codice della strada e delle disposizioni sulle armi. Reati puniti, per quanto possibile, con misure alternative alla reclusione.
Sono in calo, infatti, gli ingressi negli istituti penali, le strutture più simili alle carceri per i detenuti adulti, con la differenza dell’insussistenza del problema del sovraffollamento - gli istituti affollati sono solo quelli di Treviso e Pontremoli -, in cui non è solo presente il personale educativo ma anche il corpo di polizia penitenziaria.
Nel 2013, i minori accolti sono stati quattrocentouno - centosettantasei stranieri – con una quota di giovani adulti superiore a quella dei minori di diciasette anni. Milleduecentocinquantatre quelli usciti per trasformazione della pena o in collocamento in comunità o per emissione in libertà oppure per l’affidamento in prova al servizio sociale. Che, sospeso il processo, svolge nei riguardi del minore attività di osservazione, sostegno, controllo ed elabora il progetto di messa alla prova. Esito positivo sempre più frequente: estinzione del reato. Un provvedimento che, nel 2013, ha visto un andamento crescente anche rispetto agli ingressi in comunità, strutture, perlopiù private, a causa del numero limitato di comunità ministeriali sul territorio italiano, nonostante sia la misura cautelare più applicata per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive e di controllo: si sono registrati milleottocentonovantaquattro ingressi a fronte di milletrecentocinquantaquattro uscite.
Esito positivo sempre più frequente: estinzione del reato. Un provvedimento che, nel 2013, ha visto un andamento crescente anche rispetto agli ingressi in comunità, strutture, perlopiù private, a causa del numero limitato di comunità ministeriali sul territorio italiano, nonostante sia la misura cautelare più applicata per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive e di controllo: si sono registrati milleottocentonovantaquattro ingressi a fronte di milletrecentocinquantaquattro uscite.
Il 63,7 per cento dei minori ospitati è in attesa di giudizio e la permanenza, per la maggior parte di loro, non è superiore a un anno, tranne per il 3,8 per cento delle ragazze che sono presenti da più di due anni. Un fenomeno che caratterizza le comunità, essendo a carattere non restrittivo, è l’allontanamento non autorizzato, pratica che coinvolge quattro minori su dieci.
Sono invece poco più di duemila (una media di diciotto al giorno e in diminuzione rispetto al 2012) i minori transitati, nel corso del 2013, nei centri di prima accoglienza, tipologia di servizio minorile in cui la permanenza non può superare le novantasei ore, a seguito di flagranza di reato. Tutti numeri che stanno a indicare la complessità che avvolge i percorsi di devianza minorile, caratterizzati, quasi sempre, da condizioni sociali profondamente disagiate. Cose da grandi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Ogni anno, in Italia, si formano quattromila nuove famiglie adottive, di cui tre su quattro per adozione internazionale. Tra il 2010 e il 2013, secondo quanto si legge nel documento redatto dal Miur, che stabilisce le Linee guida per favorire il diritto allo studio dei bambini adottati, sono stati accolti circa quattordicimila bambini con l’adozione internazionale e suppergiù quattromila con quella nazionale. Nel 2012, l’età media dei bambini era fra i cinque e i sei anni.
Un’età di ingresso particolarmente critica per la coincidenza con l’inserimento nel mondo dell’istruzione, in cui il confronto dei bambini con il sistema scolastico italiano si pone in maniera urgente. Strumento a favore dell’infanzia perché contribuisce alla crescita culturale e sociale del nostro Paese, la realtà dell’adozione presenta, nella fattispecie, una varietà di situazioni che possono variare da un estremo di alta problematicità a un altro di pieno adattamento.
Ma, sebbene non sia raro incontrare minori adottati portatori di un benessere psicologico e con performance scolastiche nella media, se non addirittura superiori, è innegabile che, per il fatto di aver sperimentato esperienze traumatiche prima dell’arrivo nella nuova famiglia, ce ne siano altrettanti che presentano fattori di vulnerabilità. Per un vissuto comune segnato dalla dolorosa separazione dai genitori biologici e, talvolta, dai fratelli, da solitudine, da lunghi periodi di istituzionalizzazione, da maltrattamenti fisici e violenze psicologiche e, non ultimo, da precedenti esperienze di adozione fallite.
Quelli provenienti da adozione internazionale, poi, devono fare i conti con un’ulteriore complessità: contesti completamente nuovi, differenze culturali e somatiche, cambiamenti linguistici, climatici, alimentari drastici che vengono affrontati lasciandosi alle spalle pezzi di storia incompresa. Integrare l’originaria appartenenza etnico-culturale con quella della famiglia adottiva e del nuovo contesto di vita rappresenta una grossa spinosità: un’ambivalenza verso la cultura di provenienza con un’alternanza di momenti di nostalgia a fasi di negazione.
Ma la loro prima lingua la perdono velocemente, imparando da subito le espressioni quotidiane e il senso delle conversazioni comuni, incontrando, piuttosto, delle difficoltà nell’espressione dei concetti più astratti, che sfocia in rabbia e in una gamma di emozioni negative. Emozioni che, è noto ormai, hanno un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria, rendendola, altresì, duratura. Perciò va da sé che, per il loro vissuto, molti bambini adottati possano avere problematiche nella sfera psico-emotiva tali da interferire con le capacità cognitive: deficit nella concentrazione, nell’attenzione, nella memorizzazione, appunto, nella produzione verbale e scritta e in alcune funzioni logiche. Solo sintomi che, però, sono gli unici menzionati nelle cartelle cliniche, omettendo le diagnosi.
Perciò va da sé che, per il loro vissuto, molti bambini adottati possano avere problematiche nella sfera psico-emotiva tali da interferire con le capacità cognitive: deficit nella concentrazione, nell’attenzione, nella memorizzazione, appunto, nella produzione verbale e scritta e in alcune funzioni logiche. Solo sintomi che, però, sono gli unici menzionati nelle cartelle cliniche, omettendo le diagnosi.
Senza considerare che, spesso, i bambini non vengono iscritti all’anagrafe al momento della nascita per cui l’età è presunta e, a volte, si rilevano ex post discrepanze di oltre un anno fra l’età reale e quella attribuita ai bambini, i quali, nel periodo precedente l’adozione, è probabile siano denutriti e con uno sviluppo psicomotorio tali da rendere complicata l’individuazione dell’età.
Alcuni arrivano da Paesi rurali, con strutture sociali fragili, un tasso di analfabetismo rilevante e di abbandono scolastico precoce. Quelli che arrivano nelle famiglie intorno ai dieci anni, poi, hanno un’età complessa di per sé, nella quale la strutturazione dei legami affettivi e famigliari si scontra con la fisiologica necessità di crescita e di indipendenza.
Il sopraggiungere della preadolescenza e della pubertà può essere problematico per la definizione della loro identità legata ai cambiamenti del corpo, ai rapporti con i coetanei e, soprattutto, con quelli di sesso diverso, e con il contesto sociale. Tutti fattori che possono interferire con le capacità di apprendimento. Di tutti. Anche (anzi, soprattutto) di coloro che dai genitori biologici non si sono mai separati.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Paesaggi scialbi, nuovi orizzonti di cemento, spazi. Fisici ma anche mentali. Capacità di trovare nuovi modi per superare, saltare, aggirare gli ostacoli che si trovano quotidianamente davanti, di aprire nuovi percorsi nell’ambiente circostante, di attribuire significati alternativi e senso ai luoghi marginali in cui si vive, di ricercare la bellezza dove manca: è l’immagine perfetta dello spirito di adattamento di una intera generazione nata e cresciuta ai confini delle metropoli, fatti di palazzi moderni, pochi servizi e scarsa manutenzione degli spazi pubblici. Dove mancano possibilità, speranza e futuro.
Descritti ne L’atlante dell’infanzia (a rischio) – Gli orizzonti del possibile, il dossier di Save the Children che fa un viaggio attraverso le città, le strade, i quartieri, le stanze e altri luoghi di vita dell’infanzia, partendo dal presupposto che le città, a seconda della loro conformazione, possono rappresentare o una minaccia per la loro salute oppure una straordinaria occasione di sviluppo. E cioè: la qualità delle abitazioni, la progettazione dei quartieri, la densità e l’allocazione del suolo, l’accesso agli spazi verdi e alle infrastrutture, le aree ricreative, le piste ciclabili, la pulizia dell’aria, l’inquinamento acustico e l’esposizione a sostanze inquinanti influiscono sul benessere dei minori.
Negli ultimi decenni, è cresciuta l’età in cui è permesso stare fuori casa da soli, è diminuita la varietà e la qualità complessiva dei luoghi pubblici nei quali ai bambini è concesso muoversi e sembra aumentare l’insofferenza degli adulti nei confronti dei giochi dei piccoli i quali pagano la scarsità degli spazi ludici con l’assenza di “occasioni di gioco libero, auto-governato e non gestito da adulti e da essi finalizzato”.
Deficitarie di parchi e giardini, piste ciclabili e aree pedonali, più presenti al Nord che al Centro-sud, le città offrono la strada come unico spazio possibile, sebbene, da un lato favorisca, appunto, la mobilità del bambino, dall’altro ne configura il suo filo spinato con effetti preoccupanti sulla salute. Il divieto di giocare in strada, infatti, ne limita l’autonomia, la possibilità di trovare nuovi amici, di sperimentare l’avventura e di attivare processi di crescita.
Così, la contrazione degli spazi dedicati mantiene in auge le classiche attività praticate nei vicoli, tipo nascondino, acchiapparella, mosca cieca, campana, il gioco dell’elastico, biglie, pallavolo. Gli ascensori delle palazzine delle periferie, i carrelli dei centri commerciali adiacenti sono stati introdotti nel repertorio delle cose con cui giocare per riscattare il nulla che li circonda. E le attività sulla strada sono sempre più destrutturate, non basate sul risultato ma aperte alla creatività e al valore del lavoro di gruppo. In questi contesti, però, gli operatori osservano la “precoce perdita della dimensione infantile e della sua necessaria spensieratezza” e la “contrazione dei tempi dell’adolescenza”. Crescere in contesti di marginalità urbana e disuguaglianza spaziale vuol dire partire da una oggettiva condizione di svantaggio: riduce gli spazi dei bambini di incontro con il mondo, le possibilità di apprendimento, le occasioni di nutrimento culturale e sociale. E in seguito al graduale processo di allontanamento dagli spazi pubblici e dalla strada, le case sono diventate, per la prima volta nella storia, il più importante habitat dell’infanzia, oltreché un potente indicatore di salute.
Crescere in contesti di marginalità urbana e disuguaglianza spaziale vuol dire partire da una oggettiva condizione di svantaggio: riduce gli spazi dei bambini di incontro con il mondo, le possibilità di apprendimento, le occasioni di nutrimento culturale e sociale. E in seguito al graduale processo di allontanamento dagli spazi pubblici e dalla strada, le case sono diventate, per la prima volta nella storia, il più importante habitat dell’infanzia, oltreché un potente indicatore di salute.
Settecento mila bambini vivono in appartamenti poco luminosi, un milione e trecentomila in abitazioni con problemi di sovraffollamento (per Eurostat, quando più di due bambini sotto i dodici anni o due adolescenti di sesso diverso, si trovano a dover condividere un’unica stanza), due milione e duecentomila in case umide, con tracce di muffa sulle pareti e sotto soffitti che sgocciolano. Le conseguenze, oltre che fisiche, sui minori che vivono negli alloggi situati nelle aree marginali delle città sono psichici: pochi arredi, ripetitivi e carenti per forma e varietà di colore, che dovrebbero avere un senso, invece, “sottraggono loro opportunità di manipolare e organizzare le proprietà visive dell’ambiente e di strutturare percettivamente e discriminare le sfumature di quel dato ambiente”.
Tanto più che lo spazio dove si cresce non è mai neutro, può, appunto, avere un ruolo di sviluppo oppure essere un potente fattore regressivo. Anche perché i bambini attribuiscono un’importanza strategica ai luoghi in quanto spazi di rapporto con gli adulti e con le proprie possibilità più intime, diventando lo spazio sociale necessario in cui affermare la propria identità. “C’è qualcosa che permea la polis, le famiglie e la scuola insieme: tutti sembrano incapaci di trovare modi di una presenza adulta non ingerente, discreta, che lasci a sé senza abbandonare”, ha detto Mario Rossi Doria, maestro di strada, che di politiche educative e insegnamento in quartieri difficili ne ha un certa infarinatura.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Violato, deturpato, abusato e trascurato. Eppure, per il territorio italiano, vengono stanziate ingenti risorse dedicate. Malamente utilizzate. Per esempio quelle comunitarie, destinate ai lavori pubblici importanti, che tornano periodicamente all’attenzione dell’interesse nazionale, vedi in occasione dell’alluvione di Genova e per la ricostruzione post sismica dell’Aquila.
Ebbene, secondo quanto riporta il 48esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, le risorse programmate nell’ambito delle politiche di coesione economica e sociale 2007- 2013 - finalizzate a promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile delle comunità - si aggirano intorno agli ottanta miliardi di euro, cui corrisponde, però, una spesa certificata pari a circa trentadue miliardi e poco più, con un avanzamento del 40,4 per cento. Di questi ottanta miliardi di euro programmati, ben quarantacinque sono relativi a interventi infrastrutturali, in soldoni opere pubbliche.
Ebbene, a un anno dalla chiusura del periodo di programmazione europea si è speso un quinto delle risorse a disposizione, cosicché rimangono da certificare alla Commissione europea ancora ventuno miliardi.
Pare che la criticità che penalizza la capacità italiana di utilizzare le risorse comunitarie e nazionali risieda nel lungo e complesso processo amministrativo e tecnico che sta alla base della realizzazione delle opere pubbliche. Non solo: i dettagli nei progetti di lavori che (se) vedranno la luce da lì a sette anni, si perdono in fiumi di retorica.
Di fatto, nessuno sa per certo quali effetti possano avere i progetti finanziati con i fondi strutturali ma, nonostante questo, tanto per dirne una, in cinque anni si sono finanziati oltre cinquecentomila corsi di formazione e innumerevoli altri progetti. Risultato: tutti cercano di massimizzare la somma che l’Italia riceve e nessuno sembra chiedersi se ne valga la pena. E se i soldi dedicati arrivino ai giusti destinatari.
Per esempio, per intervenire sulla gestione delle infrastrutture di base delle risorse idriche. Non consona agli standard di uno Stato avanzato, la grave condizione in cui versano gli acquedotti italiani ha pesanti effetti economici e ambientali, contribuendo al depauperamento della preziosa risorsa.
 Tanto per capirne la portata: rispetto alla totalità dell’acqua che viene messa in rete, più di un terzo sparisce, non viene consumata né fatturata, non giungendo all’utente finale. E così, le perdite delle reti acquedottistiche, tra il 2008 e il 2012, sono aumentate e caratterizzano l’Italia tra i grandi Paesi europei. Che, oltretutto, fa acqua pure sul fronte della raccolta e della depurazione: il 7 per cento del carico inquinante non viaggia nelle reti fognarie e il 21 per cento non viene depurato prima di arrivare ai corpi idrici di destinazione.
Tanto per capirne la portata: rispetto alla totalità dell’acqua che viene messa in rete, più di un terzo sparisce, non viene consumata né fatturata, non giungendo all’utente finale. E così, le perdite delle reti acquedottistiche, tra il 2008 e il 2012, sono aumentate e caratterizzano l’Italia tra i grandi Paesi europei. Che, oltretutto, fa acqua pure sul fronte della raccolta e della depurazione: il 7 per cento del carico inquinante non viaggia nelle reti fognarie e il 21 per cento non viene depurato prima di arrivare ai corpi idrici di destinazione.
E pensare che ogni anno, nel Belpaese, si investe pochissimo: trenta euro ad abitante contro gli ottanta della Germania, i novanta della Francia e i cento della Gran Bretagna. E gli investimenti delle politiche di coesione dovrebbero anche essere concentrati, tra gli altri, sulla voce efficienza energetica. Nel ciclo finanziario 2014-2020 saranno disponibili più di trentotto miliardi di euro per sostenere il passaggio a un’economia più ecocompatibile che guardi all’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
Allo stato, gli incentivi e i forti investimenti per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie del genere hanno portato a una crescita del settore, che nel 2013 ha raggiunto il 18 per cento del consumo nazionale. Un terzo del quale è stato coperto dalla produzione nel comparto elettrico.
Non senza contraccolpi. Se si calcola che i costi derivanti dall’incentivazione delle fonti rinnovabili sono coperti per ben 12 miliardi di euro annui dal pagamento della bolletta energetica delle famiglie italiane. Di più: penalizza il settore energetico nel suo complesso per la riduzione delle ore di utilizzo degli impianti. Si vedrà la luce nella semioscurità dei progetti, dei finanziamenti e degli incentivi?
