- Dettagli
- Scritto da Administrator

di Tania Careddu
“Sono stanco, la sera non riesco nemmeno a dormire da quanto sono stanco. Non voglio più lavorare così tanto, voglio vivere tranquillo e avere qualcuno che mi dice di andare a scuola. Io voglio studiare. Ho lavorato per quattro settimane dalle sette del mattino all’una di notte. Dormivo tre ore, guadagnavo centocinquanta euro a settimana. Vorrei guadagnare almeno duecento euro da mandare a casa. Se potessi esprimere un desiderio, vorrei fare lo chef e girare il mondo”. M., tredici anni, egiziano. Uno dei trecentoquarantamila minori tra i sette i quindici anni coinvolti nel lavoro minorile in Italia.
Paese fra quelli europei, stando a quanto si legge nel Dossier 2014 di Save the children ‘Piccoli schiavi invisibili’, nel quale è stato segnalato il maggior numero di vittime accertate e presunte. Quelle presunte sono ventottomila, coinvolte in attività definite a “rischio di sfruttamento”: in attività a conduzione famigliare, nel settore della ristorazione, dell’artigianato, nella vendita (anche ambulante), nell’edilizia (manovali, imbianchini, carpentieri), lavoro di campagna e maneggio degli animali. Sono soprattutto maschi e oltre il quaranta per cento ha avuto esperienze lavorative al di sotto dei tredici anni.
Gli stranieri rappresentano il 7 per cento e provengono soprattutto dall’Eritrea, dove i connazionali adulti approfittano della situazione di vulnerabilità o mancanza di conoscenze e informazioni per estorcere denaro in cambio di servizi, come accoglienza notturna, passaggio verso il Nord Italia, accompagnamento ai servizi sociali; dall’Afghanistan, in condizioni di forte rischio di sfruttamento quando questo diventa l’unico modo per guadagnare soldi necessari a proseguire verso la loro meta finale, e dall’Est Europa, sfruttati in attività illegali.
Partono anche dall’Egitto, perché stimolati dai racconti di viaggi portatori di grandi successi economici che ostentano una ricchezza mai ottenuta in Italia o dai post su Facebook che alimentano false speranze. Oppure per l’instabilità politica del loro Paese, la mancanza di principi e ideali o del senso di appartenenza al proprio Stato.
Per intraprendere il viaggio contraggono un grosso debito che dovrà essere ripagato con i soldi che potenzialmente il minore dovrebbe inviare alla famiglia una volta giunto nel Belpaese ed essere stato inserito nel mondo del lavoro, a qualunque condizione. Sfruttati: in piccole attività commerciali, prevalentemente a Roma, nei mercati generali o negli autolavaggi, dove lavorano per dodici ore consecutive a fronte di paghe irrisorie, pari a due o tre euro l’ora.
Sfruttati: in piccole attività commerciali, prevalentemente a Roma, nei mercati generali o negli autolavaggi, dove lavorano per dodici ore consecutive a fronte di paghe irrisorie, pari a due o tre euro l’ora.
Un lavoro cosi pesante da causare dolore fisico che cercano di alleviare con l’assunzione di farmaci oppiacei antidolorifici. Nei negozi di fiori, invece, o vendendo ombrelli per strada e fazzoletti ai semafori, è la sede di lavoro dei minori del Bangladesh. I quali, soprattutto nella Capitale e a Napoli, sono impiegati in lavori continuativi, spesso senza retribuzione.
Quelli più a rischio sono coloro che non hanno conoscenza, che vivono in condizioni di isolamento e dormono per strada senza possibilità di accesso ai servizi di base, compresi quelli sanitari. A volte, tutti loro, entrano nel circuito della giustizia per il coinvolgimento in attività illecite che hanno cominciato parallelamente all’acutizzarsi di problemi a scuola, culminati in bocciature o abbandoni: furti in appartamenti o in negozi, furti di auto e spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa dinamica: gli sfruttatori permettono di trattenere una parte del guadagno per dare loro una motivazione o una parvenza di autonomia. Per non sentirsi troppo sfruttati.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Una violenza endemica, di genere, che oltraggia i diritti umani. Profondamente segnato da culture patriarcali e da dinamiche di potere decisamente sfavorevoli al sesso femminile. Silente eppure frequente: il matrimonio forzato. Occuparsene, per capirlo, significa interrogare le culture, affrontare l’accesso delle donne ai beni sociali ed economici nelle diverse realtà culturali. Soprattutto in quelle caratterizzate da società “poco sviluppate”, in cui le tradizioni definiscono l’identità individuale e sessuale e dove le scelte del nucleo famigliare prevalgono prepotentemente su quelle soggettive.
Le quali, spesso, sono condizionate da un gioco di valori, dall’esperienza (poca), da un calcolo del rapporto costi/benefici, dalla consapevolezza (o meno) di sé e del proprio desiderio. O ancora: affrontare la profonda e strutturale differenza tra i sessi, fare i conti con una limitazione della libertà degli individui e una prevalenza di usi, costumi e sistema di valori collettivi che investe uomini e donne, considerare i radicalismi religiosi, spesso abbinati a una rigida gerarchia di norme codificate dalla tradizione.
Vuol dire tenere in conto del livello di povertà - fattore primario di rischio per i matrimoni (forzati, ovviamente) infantili, dove l’obbligo di sposarsi imposto alle minorenni origina dalla speranza che il matrimonio porti alla famiglia dei vantaggi finanziari o sociali - o dal valore della “purezza sessuale” fisiologica delle ragazzine.
In Italia, secondo quanto si legge nella pubblicazione del dipartimento per le Pari opportunità “Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre. Come costruire una stima del numero delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati”, non è possibile quantificare il fenomeno per la sua liquidità, la difficoltà di racchiuderlo in una definizione univoca e condivisa, la carenza di basi di rilevamento e di rappresentatività statistica.
 Si possono, però, considerare sia i casi di matrimoni forzati (isolati e sporadici) in cui agiscono fattori di costrizione tradizionali anche all’interno di famiglie native - dove si può rilevare un aumento dei matrimoni precoci, in particolare nel Sud Italia e in quelle piccole comunità in cui sia fortemente presente l’elemento del controllo della sessualità femminile e dell’onore familiare - sia le forme di conflitto che si generano nell’esperienza migratoria tra prime, seconde e terze generazioni di migranti.
Si possono, però, considerare sia i casi di matrimoni forzati (isolati e sporadici) in cui agiscono fattori di costrizione tradizionali anche all’interno di famiglie native - dove si può rilevare un aumento dei matrimoni precoci, in particolare nel Sud Italia e in quelle piccole comunità in cui sia fortemente presente l’elemento del controllo della sessualità femminile e dell’onore familiare - sia le forme di conflitto che si generano nell’esperienza migratoria tra prime, seconde e terze generazioni di migranti.
Le cui figlie vivono in bilico tra due culture: laddove i legami identitari sono più radicati, le pressioni riescono ad avere presa anche fra quelle ragazze che, vivendo nel Belpaese, sembrano aver conquistato autonomia di pensiero e libertà di scelta. I matrimoni forzati si “celebrano” più frequentemente fra i migranti del subcontinente indiano e dei paesi musulmani. Gli immigrati del Marocco e dell’Albania rappresentano le comunità maggiormente degne di interesse, perché si tratta di gruppi in cui la folta presenza di donne da una parte e di seconda generazione dall’altra sono componenti importanti per poterne intravedere il rischio.
La cui concretizzazione ha serie conseguenze: intrappolamento in situazioni di violenza da parte dei mariti, gravidanze forzate o precoci, ridotto accesso all’educazione, abbandono scolastico e sempre più scarse opportunità di impiego, compromissione dello sviluppo psicologico. “Io non voglio fare del male, io voglio essere libera”. H., vittima di matrimonio forzato.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Ventinovemilaquattrocento. Tanti sono i minori allontanati dalla famiglia di origine in seguito a un provvedimento del Tribunale per i minorenni. Di questi, stando ai dati emersi durante un convegno alla Camera dei deputati, per il lancio de ‘Il Manifesto #5buone ragioni per accogliere i bambini e i ragazzi che vanno protetti’, 14.991 si trovano in una comunità educativa e 14.397 in affido famigliare.
Di questi, 6.986 sono affidati a famiglie della stessa rete parentale e 7.411 vivono fuori del nucleo. Il 59,3 per cento sono maschi e il 37,3 per cento femmine e hanno, principalmente, fra gli undici e i diciassette anni, con il 6,8 per cento ha da zero a due anni.
Il 32 per cento di essi è straniero e il 51 per cento “non è accompagnato”, ossia è arrivato in Italia senza adulti di riferimento e si trova senza una famiglia sul territorio italiano, mentre i minori italiani sono 10.148. Finiscono in comunità per “inadeguatezza genitoriale” - che non si riferisce ai normali limiti umani nell’esercitare un ruolo così difficile come quello del genitore ma a un’incapacità grave di rispondere ai bisogni evolutivi e alle esigenze dei figli -, per maltrattamenti, incuria, abusi sessuali o violenza assistita. O anche - dove uno dei due genitori non è in grado di tutelare il minore di fronte alla violenza dell’altro - per problemi di dipendenza da sostanze tossiche di uno o entrambi i genitori o per problemi di rapporti all’interno della famiglia.
In un caso su tre, i minori sono stati sottratti temporaneamente alla loro famiglia in base a una “misura di protezione urgente” per maltrattamento conclamato, abbandono o per altre ragioni particolarmente gravi o impellenti. Va precisato che le difficoltà socioeconomiche, che spesso caratterizzano questi contesti, non costituiscono, da sole, motivo sufficiente per l’allontanamento. Che, nel 31 per cento delle situazioni, è “consensuale”, cioè stabilito con l’assenso dei genitori, e nel 69 per cento è di natura “giudiziale”, ossia effettuato dietro provvedimento delle autorità competenti.
La loro permanenza in comunità può durare pochissimo, per meno di tre mesi e fino a quattro anni, e solo il 10 per cento li supera. La dilatazione dei tempi è determinata da particolari situazioni. Tipo: un problema sanitario proprio o del genitore, la perdita di uno o di entrambi i genitori, la dipendenza del padre o della madre da sostanze psicotrope, o per i casi di “inadeguatezza genitoriale” di cui sopra. Nel frattempo, la maggior parte dei bambini mantiene rapporti regolari con le famiglie. Che sono 19.500, soprattutto monogenitoriali (aumentate dal 1998) in cui la metà dei padri è disoccupata mentre fra le madri lo è un terzo.
Nel frattempo, la maggior parte dei bambini mantiene rapporti regolari con le famiglie. Che sono 19.500, soprattutto monogenitoriali (aumentate dal 1998) in cui la metà dei padri è disoccupata mentre fra le madri lo è un terzo.
Fra gli ospiti delle comunità educative si contano anche 1.023 neo maggiorenni i quali, grazie a un provvedimento che garantisce loro una progettualità educativa che li accompagni al futuro, sono accolti, a volte gratuitamente, senza il sostegno delle amministrazioni locali. Mentre le comunità, per svolgere al meglio il loro lavoro, avrebbero bisogno di una retta giornaliera per ciascun bambino, compresa tra i centoventicinque e i centocinquantuno euro.
Ma, nella quasi totalità del Paese non si arriva a questa cifra. Tanto per fare un esempio: a Roma ammonta a sessantanove euro circa, e a Milano arriva a settantotto. I bilanci delle strutture sono in rosso: pesano una drastica riduzione delle risorse destinate e un ritardo corposo nei pagamenti.
In Campania, pur percependo la retta giornaliera più alta d’Italia, pari a centotrenta euro per minore (seguita dall’Emilia Romagna, nella quale, però, più del 70 per cento delle strutture lamenta bilancio negativo, e dal Veneto), gli educatori non ricevono lo stipendio da trenta mesi.
Molte comunità hanno serrato i battenti e altre sono in procinto di chiudere. Eppure in Italia i minori fuori famiglia sono meno numerosi che nel resto d’Europa: sono il tre per mille a fronte del nove per mille in Francia, l’otto per mille in Germania, il sei per mille in Gran Bretagna e il quattro per mille in Spagna. E dal 2007 a oggi non sono aumentati.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
S. è in mezzo a una strada, senza soldi e senza lavoro, allontanato dalla casa del padre perché ha sottratto la mamma dalla violenza di lui. C’è K, cittadino congolese, senza fissa dimora da cinque anni. C’è P., ragazza italiana orfana, con una situazione sanitaria poco chiara. Così come J., che dorme in un casottino al binario 16, senza famiglia, reduce da due delicate operazioni chirurgiche. E S., con problemi di natura psichiatrica, chiuso in un silenzio intoccabile. Sono alcune delle storie che transitano nelle stazioni ferroviarie italiane e intercettate dai servizi di accoglienza Help Center, un progetto di Ferrovie dello Stato in parternariato con Anci e Europe Consulting Onlus.
Diecimila metri quadrati di spazi ferroviari, in comodato d’uso gratuito, in dotazione alle organizzazioni del Terzo settore che operano per il supporto e l’orientamento alle persone in difficoltà che orbitano nelle aree di stazione. Quelle di Chivasso, Genova, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Pescara, Parma, Roma, Napoli, Foggia, Catania, Messina e Bari, le quali ospitano una marginalità che riflette quella presente nelle principali città italiane. Con criticità di ordine socioeconomico presenti nei contesti urbani, specie di grandi dimensioni.
La prima è la povertà sanitaria. Rilevata ovunque nelle stazioni per effetto di quella che viene definita una lenta ‘disaffezione alla cura’, interessa sia i soggetti senza fissa dimora sia quelli che, pur avendo una casa, stanno inesorabilmente scivolando in una deriva di marginalità a causa delle dinamiche di impoverimento che investono fasce sempre più ampie di popolazione.
L’impossibilità di una progettualità disincentiva dall’investimento per il miglioramento delle condizioni personali di vita, generando un’attitudine rinunciataria. Inoltre, la popolazione senza fissa dimora invecchia più precocemente e si ammala di tutte quelle patologie croniche che degenerano rapidamente: curarsi in strada è difficilissimo, riabilitarsi dopo un intervento chirurgico quasi impossibile, così come conservare un medicinale.
Seconda vulnerabilità: la perdita del lavoro, soprattutto negli utenti fra i quaranta e i quarantanove anni, che produce un malessere sociale esteso il quale ha conseguenze disastrose sulle persone più fragili e che porta con sé danni collaterali, quali depressione, rottura di legami affettivi, gioco d’azzardo patologico, usura. Altre criticità, la mancanza o il rischio di perdere il proprio alloggio e i tagli ai servizi, tanto da farli diventare inefficaci.
 Nel 2013, secondo il Rapporto stilato dall’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni italiane (ONDS), sono stati venticinquemila, di cui dodicimila per la prima volta gli utenti che hanno usufruito dell’assistenza fornita dagli Help Center, le cui porte si sono aperte settecentoventicinque volte al giorno e, ogni ora, circa sei persone si sono presentate per la prima volta.
Nel 2013, secondo il Rapporto stilato dall’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni italiane (ONDS), sono stati venticinquemila, di cui dodicimila per la prima volta gli utenti che hanno usufruito dell’assistenza fornita dagli Help Center, le cui porte si sono aperte settecentoventicinque volte al giorno e, ogni ora, circa sei persone si sono presentate per la prima volta.
La parte più rilevante dell’utenza, il 72,6 per cento di presenze, è costituita dagli immigrati, che sono tendenzialmente giovani e la loro permanenza in stazione è spiegata come una fase transitoria che fa parte del processo migratorio, mentre gli italiani, in aumento, rappresentano il 27,4 per cento. Raddoppia, rispetto al 2012, il numero degli over sessanta, con un’incidenza prevalente nelle aree metropolitane. Gli emarginati delle stazioni sono più uomini che donne e hanno tra i diciotto e i trentanove anni. Sono padri separati, disoccupati di lunga durata, pazienti psichiatrici.
La minore presenza delle donne in condizioni di disagio si spiega con considerazioni di carattere generale: prima fra tutte, la naturale capacità delle stesse di reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo, e secondo, poi, la maggiore attenzione che loro ripongono nella cura e nell’interesse degli affetti e dei rapporti che fungono da vera e propria rete di salvataggio in situazioni di difficoltà. Ma, uomini o donne, in tutte le vite di coloro che si rivolgono agli Help Center delle stazioni ferroviarie ci sono le ingiustizie sociali. Dallo sfruttamento lavorativo alle violenze sui figli, dalla malattia mentale all’abbandono. Solo il collante umano può far sperare e salvare. Anche dopo che lavoro, casa e salute saranno diventati beni comuni.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Silvia Mari
di Silvia Mari
La storia esce sulle pagine di Corriere Salute. Un giovane italiano decide di farsi leggere il DNA. In Italia dove la legislazione è più ferrea che altrove è ammessa l’indagine solo per seri motivi di salute. Il principio che sorregge questa regolamentazione risponde a un concetto chiave: conoscere i propri geni può avere effetti psico - emotivi di non facile gestione, può dare luogo a strumentalizzazioni immorali o a selezione di specie. Un rischio che può essere corso solo se intervengono ragioni in ordine alla prevenzione e a ad un utilizzo terapeutico che avendo a che fare con il diritto alla salute diventano supererogatorie.
La spesa tra sequenziamento e interpretazione dei dati è arrivata a 3.000 euro ed è evidente la prima criticità in cui cade il sistema sanitario laddove riconosce l’utilizzo per motivi di salute dell’analisi genetica e non ne prevede il pieno sostegno economico.
Sarebbe anche utile sapere quali sono, se ci sono, i centri pubblici deputati a questa particolare analisi non solo per i costi, ma anche per esser certi della veridicità e sicurezza dei risultati. Dal profilo genetico, infatti, si traggono numerose informazioni che hanno a che vedere strettamente con quello che un tempo si sarebbe letto solo in termini di casualità o di fatalismo.
Il dottor Razee è il medico esperto che spiega i risultati al giovane che ha voluto scoprire la verità nascosta nei propri geni. La beffa è che quello che scopre è meno di quello che si attende e che soprattutto nulla diventa un elemento dirimente per il suo futuro, nulla – soprattutto - è mutabile o arginabile con alcuna terapia e valgono per lui, dal test in poi, quelle norme di prevenzione primaria che i medici raccomandano un po’ a tutti. Scopre infatti di avere i geni dell’infarto, ma di averne altrettanti che lo proteggono tali da avere un rischio medio inferiore ad altre categorie. Scopre di poter soffrire di osteoartrite o degenerazione maculare.
L’aspetto di particolare attenzione in questa storia, che denuncia quanto la genetica non possa essere percepita come verdetto sulla vita di una persona, è che i medici che hanno lavorato all’analisi del genoma di questo italiano atipico, hanno avuto bisogno di mettere insieme altri due elementi: l’anamnesi familiare e le abitudini, nonché luoghi e ambienti, di vita.
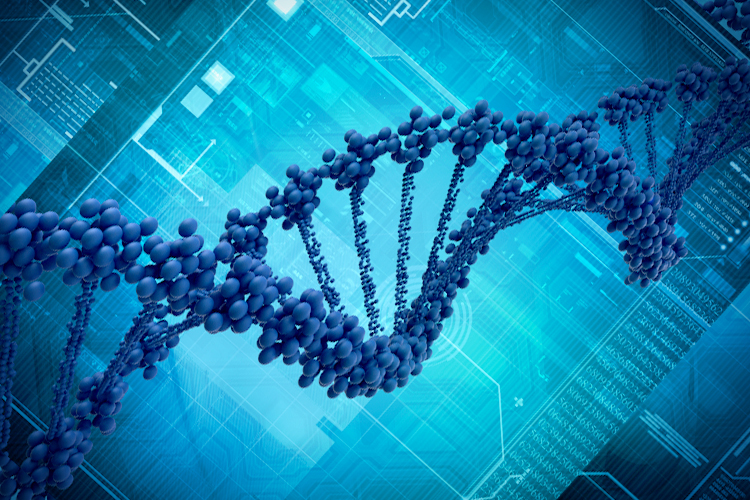 I geni infatti, per dirla in soldoni, non fanno tutto da soli e questo suscita una serie di interrogativi e di deduzioni. Modificare alcuni fattori epigenetici può davvero cambiare le sorti scritte nel DNA e in che misura percentuale? Nel caso delle sindromi predisponenti al cancro, ad esempio, sui tumori femminili sembrerebbe molto poco. Queste donne in età precoce sviluppano la malattia. Ma non tutte le mutazioni hanno lo stesso potere invalidante.
I geni infatti, per dirla in soldoni, non fanno tutto da soli e questo suscita una serie di interrogativi e di deduzioni. Modificare alcuni fattori epigenetici può davvero cambiare le sorti scritte nel DNA e in che misura percentuale? Nel caso delle sindromi predisponenti al cancro, ad esempio, sui tumori femminili sembrerebbe molto poco. Queste donne in età precoce sviluppano la malattia. Ma non tutte le mutazioni hanno lo stesso potere invalidante.
E laddove conoscere non corrisponde, per limiti della scienza, ad alcun antidoto o misura di autentica prevenzione possibile, a cosa serve davvero sapere? A soddisfare un’ansietà e un’ambizione di conoscenza propria della natura umana, come ben esprimeva Aristotele. A cercare di rendere possibile quel miracolo di ingegneria genetica ad oggi non disponibile che lascia tante persone, meno fortunate del protagonista di questa storia d’avanguardia, senza speranza e con la consapevolezza di avere una bomba ad orologeria dentro di sé.
Un meccanismo che aspetta un qualsiasi pretesto esterno per mettersi in moto. E che forse per altre ragioni ancora ignote del genoma o dell’esterno magari non si attiverà restituendo in cambio un’esistenza insopportabile e l’unica verità possibile: siamo e non siamo i nostri geni.
