- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
“Gli immigrati subiscono ancora discriminazioni in diversi ambiti della loro vita, soprattutto in campo sociale e lavorativo, che incidono pesantemente sulle possibilità dell’integrazione, dal momento che la condizione fondamentale perché l’integrazione abbia credibili chance di realizzazione è proprio che, almeno nelle dimensioni più importanti della vita civile, si riscontri una effettiva e verificabile uguaglianza di trattamento e di diritti tra italiani e stranieri”. Così dicono al Centro Studi e Ricerche IDOS, in occasione della presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2014 Rapporto Unar ‘Dalle discriminazioni ai diritti’.
In effetti, facendo un confronto statistico fra la condizione degli immigrati e quella degli italiani in alcuni settori di inserimento sociale e occupazionale, balza una differenza a svantaggio dei primi. Il primo di questi ambiti di discriminazione è l’accesso al mercato della casa: in media, gli stranieri sostengono, pro capite, un costo per l’affitto della casa che è superiore di un quinto a quello che sostengono gli italiani. Se a questo si aggiunge che la retribuzione media pro capite dei lavoratori dipendenti immigrati è inferiore di oltre un quarto a quella degli italiani, si capisce come la casa resti un bene primario di welfare proibitivo per gli immigrati.
Senza contare le molteplici forme di preclusione verso gli stranieri da parte dei proprietari con il 5,1 per cento di discriminazioni segnalate all’Unar. Inoltre, secondo i dati riportati nel Dossier, le quattromila compravendite effettuate dagli stranieri nel 2013 sono meno della metà rispetto a quelle degli anni precedenti la crisi e anche il volume finanziario si è ridotto a sette milioni e rotti di euro: ne è conseguita una maggiore canalizzazione nel mercato degli affitti e nei bandi dell’edilizia residenziale pubblica.
Il superamento della discriminazione è stato possibile solo in seguito all’intervento dell’azione giudiziaria, del ricorso alla normativa comunitaria e alla Corte di Giustizia di Lussemburgo. Secondo ambito sociale di comparazione tra italiani e stranieri: la scuola. E riguarda la massiccia canalizzazione degli studenti stranieri di scuola superiore in percorsi che puntano a un immediato inserimento nel mondo del lavoro piuttosto che a un proseguimento degli studi a livello universitario: sono appena il 20,6 per cento quelli che scelgono un liceo invece di un istituto tecnico o professionale a differenza del 43,7 per cento tra gli italiani (una percentuale più che doppia).
Il che pregiudica, per le nuove generazioni di origine straniera, la possibilità di competere nel mercato del lavoro per posti di più alta qualifica, perpetuando quel modello di “inserimento subalterno” in cui gli immigrati vengono relegati agli impieghi più dequalificati, poco retribuiti e precari che caratterizza l’occupazione straniera in Italia, sin dalle prime generazioni. E che rischia di ingessare la mobilità sociale degli immigrati anche nel ricambio generazionale. A conferma di ciò, il terzo ambito indagato, l’inserimento occupazionale.
Si ottiene che ben la metà dei lavoratori immigrati che ha iniziato il proprio rapporto di lavoro prima del 2013, lo ha visto terminare nel corso dello stesso anno perché licenziati, dimissionati o per mancato rinnovo del contratto alla scadenza, viceversa tra gli italiani, la quota è di venti punti inferiore; l’impiego dei lavoratori stranieri è maggiormente discontinuo e a tempo parziale secondo un modello lavorativo “a singhiozzo” correlato da ore non dichiarate o da impieghi totalmente senza contratto, con tutto ciò che comporta sia in termini di tutela previdenziale e infortunistica sia sulla permanenza regolare in Italia.
Si fatica, a livello amministrativo, a recepire che i bandi per i concorsi pubblici non possono essere riservati ai soli cittadini italiani o comunitari, non mancano le resistenze inverse e mentre il ministero della Giustizia ha ritenuto superata la legge sulla stampa circa il requisito della cittadinanza italiana per diventare direttore di una testata giornalistica, qualche giudice di merito non è stato in sintonia con questa apertura; in campo sportivo, molto resta da fare per eliminare le “discriminazioni istituzionali” che impediscono agli stranieri - inclusi quelli di seconda generazione - l’accesso al calcio professionistico. Eppure, nonostante tutte queste impari opportunità, loro continuano a svolgere un ruolo importante sul piano previdenziale, grazie alla giovane età che ne fa dei fruitori marginali del sistema pensionistico. Nel 2012 sono stati versati circa 9 miliardi di euro di contributi da lavoratori stranieri e, in futuro, secondo le stime di IDOS, l’incidenza degli stranieri fra quanti raggiungeranno l’età pensionabile sarà del 6 per cento nel 2025, quando tra i residenti stranieri pensionati saranno all’incirca uno ogni venticinque (tanto per avere la dimensione, oggi, tra gli italiani sono uno ogni tre).
Eppure, nonostante tutte queste impari opportunità, loro continuano a svolgere un ruolo importante sul piano previdenziale, grazie alla giovane età che ne fa dei fruitori marginali del sistema pensionistico. Nel 2012 sono stati versati circa 9 miliardi di euro di contributi da lavoratori stranieri e, in futuro, secondo le stime di IDOS, l’incidenza degli stranieri fra quanti raggiungeranno l’età pensionabile sarà del 6 per cento nel 2025, quando tra i residenti stranieri pensionati saranno all’incirca uno ogni venticinque (tanto per avere la dimensione, oggi, tra gli italiani sono uno ogni tre).
E invece, la presenza degli immigrati è percepita come una concausa della congiuntura negativa: la ricerca di un capro espiatorio di fronte a non incoraggianti momenti di crisi economica, che sembra contribuire a una crescita della xenofobia, rende necessario un costante monitoraggio dei rischi di conflittualità sociale così come un’azione di promozione delle pari opportunità per i “nuovi” cittadini che non saranno la soluzione dei nostri mali ma non ne sono neppure la causa. Anzi, possono essere di aiuto sul piano demografico, culturale, occupazionale e commerciale. Basti pensare alle loro cinquecentomila imprese portate avanti in questa fase di crisi.
Alla base della convivenza ci deve essere il concetto di pari opportunità: cittadinanza e benessere non possono essere intesi e vissuti in una forma escludente nei confronti degli ‘altri diversi’. E’ tempo di pensare in grande, di passare “dalle discriminazioni ai diritti”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
L’epilogo giudiziario della Corte d’Appello di Roma per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009 all’ospedale Sandro Pertini, sei giorni dopo l’arresto per detenzione di stupefacenti, lascia di sasso familiari, media e opinione pubblica. Ribaltata la sentenza di primo grado in virtù del secondo comma dell’articolo 530, che peraltro condannava soltanto i medici per omicidio colposo e lasciava immuni gli agenti di polizia penitenziaria.
“Per insufficienza di prove” - cosi recita la sentenza - vengono assolti tutti gli imputati, ma viene però lasciato irrisolto un omicidio, giacché Stefano non può essersi picchiato da solo e muore quando era sotto controllo medico, senza un colpevole che paghi.
La famiglia Cucchi, sin dagli inizi del procedimento legale, ben immaginando le difficoltà di individuare colpevoli e responsabilità, aveva mostrato le foto di Stefano sul tavolo dell’autopsia, contravvenendo a ogni naturale forma di protezione del proprio dolore. Il volto viola per le percosse, gli occhi gonfi, la schiena rotta, pelle e ossa di una morte per inedia. Così è accaduto ancora alla fine della lettura di quest’ultima sentenza. Gigantografie di uno scheletro pestato che rimangono con una spiegazione, ma senza colpevoli. Una conclusione grottesca.
L’impianto accusatorio per omicidio colposo e non preterintenzionale lasciava presagire questo epilogo. Cosi commenta l’avvocato Fabio Anselmo della famiglia Cucchi, che forse è il meno sorpreso di tutti. Tanto più vero in un paese di impunità garantita per chi indossa l’uniforme della legge. Lunga la lista di altri casi scandalosi, da Aldovrandi a Uva.
Per il pm Stefano fu picchiato nelle camere di sicurezza del tribunale, dove aspettava la convalida del suo arresto. Cosi lo vede anche suo padre quando entra in aula. In ospedale un concorso spietato di responsabilità lo condanna definitivamente a morte. Le sue richieste di vedere i familiari e di avere farmaci non vengono prese in alcuna considerazione e la protesta del giovane geometra per i suoi diritti negati si trasforma in una morte per inedia, sotto un lenzuolo in un ospedale pubblico italiano.
Per la III Corte d’Assise in ogni caso Cucchi morì per l’incompetenza e le gravi omissioni dei medici. Le percosse che pure furono immediatamente riscontrate già in una prima visita al Fatebenefratelli, cui fu sottoposto prima del processo, non erano tali - secondo la Corte - da indurlo a morire e la schiena spezzata, visibile anche in una delle foto dell’orrore, poteva risalire al passato e non a quei giorni. Oggi i legali dei tre agenti coinvolti parlano di percosse o avvenute prima dell’arrivo di Stefano in tribunale (quando era in mano dei carabinieri e quando già arrivò con tumefazioni e lividi e si disse al padre che era caduto nella stazione in cui si trovava) o successivamente. O forse prima e anche dopo, viene da pensare. O forse mai, come vuole lasciar credere quest’assoluzione plenaria della Corte D’Appello. Si prepara il ricorso in Cassazione e un’azione legale contro il Ministero della Giustizia. Anche di un ricorso alla Corte Europea se sarà necessario. E’ la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, ad annunciarlo. La sentenza ultima è lo smacco finale di perizie contraddittorie da parte della Corte di Primo Grado. Ad oggi sappiamo che il pestaggio c’è stato, un pestaggio mirato e pesante, come mostrano le foto, che porta Stefano a dover esser definitivamente ricoverato al Sandro Pertini.
Si prepara il ricorso in Cassazione e un’azione legale contro il Ministero della Giustizia. Anche di un ricorso alla Corte Europea se sarà necessario. E’ la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, ad annunciarlo. La sentenza ultima è lo smacco finale di perizie contraddittorie da parte della Corte di Primo Grado. Ad oggi sappiamo che il pestaggio c’è stato, un pestaggio mirato e pesante, come mostrano le foto, che porta Stefano a dover esser definitivamente ricoverato al Sandro Pertini.
Sappiamo anche che sta male e chiede aiuto, ha bisogno di incontrare familiari e di ricevere farmaci. Sappiamo che si spegne senza che nessuno faccia qualcosa per farlo mangiare e bere. La protesta di un uomo con le ossa rotte e lasciato solo, colpevole di detenere 29 grammi di hashish.
Ad oggi non si capisce, aldilà di questo lungo processo colabrodo, il perché picchiare, perché questo furore, questa violenza contro un ragazzo magro e inoffensivo. Perché ridurlo così? Ad oggi la giustizia non sa dire il nome di chi lo ha picchiato né di quanti. Hanno riconosciuto le colpe dei medici in primo grado, ma con quest’ultimo atto li mandano a casa con una bonaria riprovazione morale. Forse nemmeno. E ricordiamo, perché vale la pena rammentarlo in questa farsa delle contraddizioni, che questo è il paese in cui la legge vuole far vivere a tutti i costi coloro che non vogliono più vivere.
Ad oggi sappiamo anche, ahinoi, che l’unica vera ragione di questo scandalo giudiziario e morale è perfettamente quella che espresse il senatore Giovanardi quando, in un suo delirio tra i tanti altri, parlò di Cucchi come di una vittima dell’anoressia e della droga. Stefano era un geometra, un ragazzo semplice, non un figlio di papà, un ragazzo che consumava hashish probabilmente e che aveva avuto un passato di dipendenza.
Uno che si può pensare di picchiare a sangue indisturbati, chissà perché, magari per noia o per general generico odio sociale (Genova docet), uno cui può essere negato il diritto di visita di un familiare anche quando lo chiede dando in pegno e come scambio la sua stessa sopravvivenza, perché non ha più altro per chiedere di essere ascoltato.
Uno che non è nessuno, quindi, e che è stato persino un tossicodipendente. Figurarsi. Uno il cui diritto non può valere sulle uniformi che lo Stato stipendia con i nostri soldi per assicurare alla giustizia i colpevoli. E cosi, nella confusione tra poliziotti e medici, tra cadute accidentali alla stazione dei carabinieri e lividi in faccia la mattina dell’udienza, tutti si salvano tranne lui. Una giustizia che riconosce il misfatto ma non sa trovarne i responsabili è quasi una barzelletta. Soprattutto quando tutto questo avviene tra un tribunale e un ospedale, nelle mani dello Stato. Nel sogno di un paese normale chi commette un abuso nel nome dello Stato dovrebbe pagare doppiamente, ma così mai è stato.
Una giustizia che riconosce il misfatto ma non sa trovarne i responsabili è quasi una barzelletta. Soprattutto quando tutto questo avviene tra un tribunale e un ospedale, nelle mani dello Stato. Nel sogno di un paese normale chi commette un abuso nel nome dello Stato dovrebbe pagare doppiamente, ma così mai è stato.
Nel sogno di un paese normale non avremmo dovuto vedere i poster dell’orrore di un cadavere che sembra tornato da Auschwitz e che invece moriva cosi nella Capitale e in mano al braccio della giustizia. Una pena di morte studiata a tavolino. Questo è stato Stefano Cucchi. Chissà se su di lui avremo una parola dell’ultimo leader coraggioso rimasto, che si chiama Papa Francesco.
Non sapremo come andrà a finire la storia di Stefano. Ma sappiamo che l’ipoteca altissima che mette sull’irreprensibilità delle nostre forze dell’ordine e dell’amministrazione della giustizia è un prezzo che pagheremo tutti in termini di paura e di scoramento. E molti altri, dopo di lui, con la vita.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
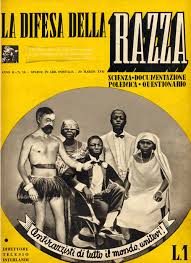 di Tania Careddu
di Tania Careddu
“Il fatto di essere zingaro è sufficiente perché l’individuo e il gruppo siano condannati”, scriveva nel 1987 Jean Pierre Liegeois, sociologo francese che da trent’anni ha orientato la sua ricerca sulla popolazione rom. Cosicché la canalizzazione della paura verso una determinata etnia si trasforma in odio razziale. Tanto che ogni due giorni nel nostro Paese, secondo quanto rilevato dall’Associazione 21 luglio, in una ricerca che ha monitorato centoventinove fonti di informazione cartacee e on line, raccogliendo i dati nel rapporto Antiziganismo 2.0, si registra un episodio di “discorso d’odio” grave che penalizza e stigmatizza indistintamente gli appartenenti alle comunità rom e sinte.
Quattrocentoventotto segnalazioni in un anno, il 92 per cento raccolte sui mezzi di informazione. La quale è pesantemente sbilanciata. Purché faccia scalpore. E la notizia sia “sensazionalistica e voyeristica, di solito riservata ai fatti di sangue che si ritiene possano appassionare il pubblico”, si legge nel Terzo libro bianco sul razzismo in Italia, a cura di Lunaria. Sono le pagine di cronaca, che sul mercato vende di più, infatti, a ospitare le notizie sugli stranieri o sui rom. Sovrarappresentati.
Tanto che il discorso mediatico sull’immigrazione si muove all’interno dell’ossessione per la criminalità procurata dagli immigrati. In una duplice ambivalenza: da un lato i media continuano a proporre il binomio straniero/criminale, indicando la strada attraverso la quale lo straniero assume la funzione di capo espiatorio dei problemi della società, e dall’altro solleticano i pregiudizi diffusi nell’opinione pubblica ma li orientano, anche, omettendo un’analisi puntuale degli avvenimenti.
Facendo largo a categorie stereotipiche, ipotesi suggestive non comprovate dai fatti. In barba al “rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile”, come richiederebbe la Carta dei doveri del giornalista. E bypassando il rispetto del “diritto alla presunzione di innocenza”.
Ma c’è poco da fare: il carnefice è sempre straniero e quand’anche fosse la vittima, il particolare della nazionalità, che campeggia sui titoli nel caso opposto, non è ritenuto così rilevante da essere citato. E quando non sono criminali, la loro presenza, per i media, è associata a situazioni problematiche, in linea, d’altronde, con l’agenda politica.
E’ la retorica dell’emergenza: allarme, invasione, ondata, sono alcune delle parole che descrivono gli sbarchi degli stranieri in Italia. E invasione uguale pericolo: in primis, sanitario, paventato da molti esponenti politici pur senza poter fare riferimento a dati reali, con conseguenti postume smentite di Asl, istituzioni sanitarie e, finanche, del ministero della Salute. Ma, nel frattempo, è allarme. Anche economico, vedi dopo l’avvio dell’operazione Mare Nostrum, spesso demonizzata dai politici di turno che “drammatizzano” il dibattito, allontanandosi da un’attenta analisi del fenomeno migratorio e delle sue reali dimensioni, manipolando, con l’interpretazione, i numeri e le cifre. Utilizzando un linguaggio stigmatizzante, con dei termini, tipo “clandestino”, che di sparire non hanno nessuna intenzione nonostante il disappunto espresso dalle Linee guida della Carta di Roma, e l’effetto che sortiscono: tendono a deumanizzare e a privare i migranti della loro identità.
Ma, nel frattempo, è allarme. Anche economico, vedi dopo l’avvio dell’operazione Mare Nostrum, spesso demonizzata dai politici di turno che “drammatizzano” il dibattito, allontanandosi da un’attenta analisi del fenomeno migratorio e delle sue reali dimensioni, manipolando, con l’interpretazione, i numeri e le cifre. Utilizzando un linguaggio stigmatizzante, con dei termini, tipo “clandestino”, che di sparire non hanno nessuna intenzione nonostante il disappunto espresso dalle Linee guida della Carta di Roma, e l’effetto che sortiscono: tendono a deumanizzare e a privare i migranti della loro identità.
Per non parlare degli insulti che sul web trovano terreno fertile tanto da superare quelli registrati nella vita pubblica: si parla di trecentocinquantaquattro casi di discriminazione in un anno, la maggior parte dei quali avvenuti nei social network. La mappa è variegata con gruppi di privati cittadini e pagine che si collegano a movimenti e siti web della destra radicale, dai nostalgici neonazisti fino a gruppi tematici contro l’immigrazione. Una saldatura perversa tra siti web, testate giornalistiche registrate e social network che ritoccano le notizie sui casi di cronaca quotidiana che coinvolgono gli stranieri. E si sa, l’odio in rete ha la violenza di un illimitato contagio. Realmente.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Partire. Arrivare. A volte, tornare. E’ questo il movimento degli italiani nel mondo. Un fenomeno sociale in continua trasformazione. Non addomesticabile, fatto di storie passate e di nuovi bagagli. Rotte migratorie storiche ma maggiore preparazione scolastica, qualificazione e professionalità, numeri sempre più incisivi, partenze non più solitarie ma di interi nuclei famigliari.
Sono 4.482.115 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, con un aumento di tre punti percentuali rispetto al 2013, e nell’ultimo anno a partire sono stati più di novantaquattromila.
Soprattutto giovani fra i diciotto e i trentaquattro anni (a dimostrazione del fatto che la scelta di espatriare è quasi sempre legata alla disoccupazione o a una realizzazione nel percorso di studi, vedi l’Erasmus), partiti dalla Lombardia, dal Veneto, dal Lazio, dalla Sicilia e dal Piemonte e diretti verso il Regno Unito, la Germania, la Svizzera e la Francia.
In generale, la metà dei nostri connazionali trasferitisi all’estero è di origine meridionale ma un terzo è partito dalle regione del Nord, principalmente dai grandi comuni. E in molte province italiane, in cima Macerata e Trieste con Fermo e Pordenone al seguito, si registrano più emigrate donne che uomini, le quali scelgono come destinazione l’Argentina. Il primo paese in assoluto a ospitare gli italiani emigrati. Anche se campani, pugliesi, sardi, siciliani e trentini preferiscono la Germania, laziali e veneti il Brasile, lombardi e valdostani la Svizzera e gli umbri la Francia.
Decrescono lievemente i minori iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero ma aumentano quelli registrati per nascita, figli delle precedenti generazioni emigrate. Mentre lievitano gli over sessantacinque: risiedono soprattutto nel Sud America e spesso vivono in una condizione economica di indigenza. Percepiscono, infatti, pensioni ridotte e inferiori a quelle che spetterebbero loro se vivessero in Italia. Non solo: risentono di una “povertà” culturale causata da un isolamento che li segrega, nella migliore delle ipotesi all’interno delle loro comunità, se non all’interno dei loro ristretti nuclei familiari. Una condizione che, sovente, viene confermata anche dai governi dei paesi ospitanti, vedi il caso dell’Australia: i bisogni degli anziani emigrati trovano risposte più adeguate dentro la rete familiare e, in particolare, nella relazione genitori anziani-figli adulti, i quali, a loro volta, considerano l’assistenza offerta dalle istituzioni solo un’alternativa secondaria.
Una condizione che, sovente, viene confermata anche dai governi dei paesi ospitanti, vedi il caso dell’Australia: i bisogni degli anziani emigrati trovano risposte più adeguate dentro la rete familiare e, in particolare, nella relazione genitori anziani-figli adulti, i quali, a loro volta, considerano l’assistenza offerta dalle istituzioni solo un’alternativa secondaria.
Non a torto, però, vista la carenza di idonei servizi di interpretariato, l’insufficiente informazione sull’accesso ai servizi, la mancanza di sensibilità culturale da parte degli erogatori dei servizi e di personale bilingue e culturalmente preparato.
E l’integrazione, dunque? Passa (anche) per la cucina, luogo di scambio e di negoziazione di identità: i migranti portano con sé le proprie abitudini alimentari e ne influenzano quelle dei paesi d’arrivo. E viceversa. E la cucina del Belpaese più di tutte.
Si, perché non è solo esportata da un gruppo risicato di professionisti dell’arte culinaria ma creata nei luoghi, inconsci e privati, raggiunti dagli immigrati. In una koinè che non snatura ma mescola e accomuna: i “macaroni” - italiani emigrati nel resto d’Europa nell’Ottocento, così chiamati a sancire la completa identificazione tra mangianti e mangiato - cucinano spaghetti with meatballs - il piatto più rappresentativo di questo processo. E che profuma di riuscita.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Sempre più tardi e sempre meno. E’ questa la tendenza alla genitorialità fra le coppie di oggi. I dati, emersi da un’indagine condotta dal Censis “Diventare genitori oggi”, parlano chiaro: l’età media delle donne a diventare madri è passata da circa ventinove anni nel 1995 a trentuno e rotti nel 2011. E, secondo il 46 per cento degli intervistati, ci si dovrebbe occupare della faccenda dopo i trentacinque.
Non solo. Una volta raggiunta l’età “giusta”, si fanno, anche, pochi figli: meno 3,7 per cento rispetto al 2012. Insomma, l’Italia è affetta da infertilità.
Le motivazioni sono, sempre più spesso, di matrice economica, vedi l’attuale crisi, e legate pure all’assenza di politiche sociali adeguate. Cioè, se ci fossero interventi pubblici, tipo sussidi, disponibilità di asili nido, sgravi fiscali, borse di studio, orari di lavoro più flessibili, possibilità di permessi per le esigenze dei figli, ci sarebbe, soprattutto fra gli intervistati dai trentacinque ai quarantanove anni, una maggiore propensione alla genitorialità.
C’è da giurarci? Non si potrebbe, piuttosto, pensare che l’esperienza della genitorialità, cosi come la interpreta la maggior parte del campione, parta da presupposti poco fecondi? Ossia: diventare genitori, per la stragrande maggioranza di questo, è definito principalmente come un aspetto cruciale della realizzazione individuale, cosicché il significato assunto dal figlio rispetto a sé stessi e al proprio vissuto personale risulta prevalente. Assente, o quasi (ahinoi), la versione che vede la nascita del proprio figlio come il supremo completamento (arricchimento, ndr) della dimensione di coppia.
E le cause, invece, dell’infertilità, dichiarata tale dall’Organizzazione mondiale della sanità, dopo dodici o ventiquattro mesi di rapporti mirati in assenza di concepimento? Lo stress, anomalie strutturali e problemi ormonali. Una dimensione, quella della fertilità, che attualmente appare profondamente modificata grazie agli effetti dei grandi progressi medici registrati ma che tuttora coinvolge problematiche di tipo etico.
L’influenza della Chiesa cattolica, e non soltanto per gli appartenenti alla fede, ne è un esempio: continua, infatti, a essere una zavorra sulla posizione degli italiani in merito e non solo (incide pesantemente, anche, su una quota significativa che rifiuta la procreazione fuori dal setting tradizionale).
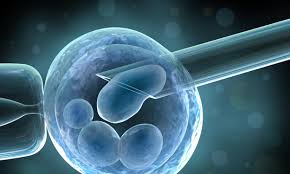 Ci si aggiungano, poi, le credenze popolari farcite di un bagaglio di conoscenze risicate, gli aspetti strettamente culturali che impattano sull’identità di genere e la scarsa (per non usare il superlativo) informazione. Si consideri che il 45,1 per cento degli italiani ne sa proprio poco e il 60 per cento di loro, laureati compresi, assolutamente niente. Per non parlare della procreazione medicalmente assistita (PMA). Roba da esperti. E da laici.
Ci si aggiungano, poi, le credenze popolari farcite di un bagaglio di conoscenze risicate, gli aspetti strettamente culturali che impattano sull’identità di genere e la scarsa (per non usare il superlativo) informazione. Si consideri che il 45,1 per cento degli italiani ne sa proprio poco e il 60 per cento di loro, laureati compresi, assolutamente niente. Per non parlare della procreazione medicalmente assistita (PMA). Roba da esperti. E da laici.
Di gameti esterni alla coppia non se ne parla per il 30 per cento del campione cattolico praticante. L’eterologa, infatti, è ben vista solo dal 40 per cento degli intervistati. E pensare che alla legge 40 del 2004 - la quale regolamenta la PMA - sono state, di recente, apportate delle modifiche, proprio circa il divieto posto dalla legge sulla fecondazione eterologa, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Poco conosciuta ai più, e, fra coloro che, invece, sanno di che si tratta, il giudizio non è positivo: applicazione diversificata sul territorio nazionale e limitazioni poste alla coppia. Loro, quelli che l’hanno letta, vorrebbero che si eliminassero le restrizioni sull’eterologa e che si intervenisse sul divieto alla diagnosi preimpianto. Che già, per le coppie alle prese con la procreazione medicalmente assistita, la strada non è in discesa: per l’80,5 per cento del campione la crisi economica è un deterrente specifico, e poi le difficoltà informative, il non sapere a chi rivolgersi, l’incertezza emotiva, la solitudine, l’isolamento e la chiusura in sé stessi.
