- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Alessandro Iacuelli
di Alessandro Iacuelli
Ci sono in Italia 5000 piccoli borghi al di sotto dei 5000 abitanti. Di questi, due terzi sono collocati lungo la dorsale appenninica e c'è chi ha scelto di viverci. Chi perché ci è nato, chi perché era emigrato e dopo anni è tornato a casa, chi perché ha scelto di allontanarsi da città sempre più congestionate, sovraffollate e invivibili. Questi borghi stanno scomparendo, sotto i colpi di una “modernizzazione”, di uno “sviluppo” che va in una direzione imposta e non condivisa.
A colpi successivi, governi ed enti locali li stanno spopolando, forzando la migrazione verso le squallide periferie delle grandi città. Progressivamente nel tempo, si delocalizza la scuola che c'era nel piccolo borgo, un'altra volta si chiude l'ospedale che serviva 10 o 20 di questi piccoli centri, e la carenza di servizi forza gli abitanti a migrare verso le grandi aree urbane.
E' un piano studiato a tavolino di spopolamento delle zone interne dell'Appenino, soprattutto quello centrale e meridionale, che rischia di sconvolgere la stessa geografia dell'Italia. Spostare sì, ma a quale scopo?
Anche se il mondo della politica non lo dice, appare fin troppo chiara una scientifica pianificazione di una nuova riorganizzazione del territorio della penisola. Le aree interne, secondo le intenzioni di chi ha governato e governa, trasversalmente all'arco costituzionale, vanno riusate a nuovi scopi non abitativi.
Così, dopo la Basilicata, è il turno dell'Irpinia di essere al centro di una nuova campagna di trivellazioni petrolifere nelle valli e sulle montagne. Pazienza se si va ad insistere su una zona dove si preleva acqua che va a dissetare un bacino di sei milioni di persone, il 10% degli italiani.
Contemporaneamente, dalle Marche e dall'alto Lazio fino alla stessa Irpinia, è tutto un fiorire di progetti di centrali elettriche, il più delle volte a gas, o ad incenerimento di rifiuti prodotti altrove, che vanno poi allacciate alla rete elettrica nazionale mediante elettrodotti ad alta tensione che sconvolgono il territorio, distruggono ed eliminano aree destinate all'agricoltura o all'allevamento, portano inquinamento elettromagnetico elevato in borghi medievali di 2000 abitanti, che fino a ieri non sapevano neanche cosa fosse l'inquinamento.
Ancora, come se non bastasse, i territori diventano destinatari di progetti di smaltimento dei rifiuti delle grandi città, dalle discariche, fino alle piattaforme per far sparire dalla vista i rifiuti industriali pericolosi. Per rendere realtà questo progetto di “modernizzazione” del Paese c'è un impedimento da superare: l'esistenza dei cittadini, visti sempre più come il peggiore ostacolo per una democrazia moderna. Pertanto, funzionale al grande progetto, è necessario forzare lo spopolamento, l'abbandono dei piccoli centri.
Per rendere realtà questo progetto di “modernizzazione” del Paese c'è un impedimento da superare: l'esistenza dei cittadini, visti sempre più come il peggiore ostacolo per una democrazia moderna. Pertanto, funzionale al grande progetto, è necessario forzare lo spopolamento, l'abbandono dei piccoli centri.
Certo, non si può deportare la popolazione con la forza, quindi la strategia adottata è quella di far sparire i servizi. Eliminare istruzione, sanità, uffici pubblici, negozi e centri commerciali, fabbriche e attività economiche e, quando la popolazione locale scende oltre un certo limite, viene rimosso anche il medico di base; il tutto per fare in modo che la gente decida da sé di andarsene altrove, togliendo il disturbo.
La terra e la gente dei piccoli paesi delle aree interne meridionali, dall’Irpinia al Salernitano, dalla Puglia alla Lucania, sono sotto attacco. I vecchi emigranti che erano ritornati vedono i figli e i nipoti fare le valige e abbandonare un territorio dove lo stato sociale e i servizi essenziali non sono più garantiti.
Mentre scompaiono presìdi scolastici e sanitari, piccoli tribunali e uffici postali, azzerando in pochi anni le conquiste ottenute dal dopoguerra, procede, di pari passo, l’aggressione a un territorio il cui destino sembra lo spopolamento e il degrado.
Terra, aria, acqua sono a rischio o già compromesse: discariche abusive e sversamenti diffusi, esplorazioni petrolifere in aree sismiche e ricche d’acqua, eolico selvaggio ed elettrodotti, aree di ricarica dei bacini idrici a rischio, depuratori inesistenti, emissioni fuori norma nei nuclei industriali, impianti a biomassa che successivamente diventano inceneritori e molto altro.
Da qualche tempo, gli abitanti di questi piccoli centri, soprattutto in Campania, hanno iniziato a dialogare tra di loro, da Torrita Tiberina a Castelvetere sul Calore, dando vita ad un “forum ambientale” dell'Appennino (http://www.forumambientale.org), dove mettono in comune le proprie esperienze e assieme concertano iniziative di resistenza. E' un movimento in crescita: ad ogni incontro il numero di partecipanti aumenta. Non per coscienza politica o ambientale, quella magari verrà dopo, ma per paura. Paura delle grandi aziende che gli rubano la terra e mettono centrali, inceneritori, impianti a biomassa che poi diventano chissà cosa.
E' un movimento in crescita: ad ogni incontro il numero di partecipanti aumenta. Non per coscienza politica o ambientale, quella magari verrà dopo, ma per paura. Paura delle grandi aziende che gli rubano la terra e mettono centrali, inceneritori, impianti a biomassa che poi diventano chissà cosa.
Paura di cosa c’è nell’acqua che bevono e fanno bere ai loro figli, delle microdiscariche vicino casa e dell’amianto che altri vanno a scaricare, paura degli elettrodotti che passeranno, di quelli che già ci sono e di tanto altro ancora.
Da questa paura, che si trasforma in partecipazione, sta nascendo un centro studi, una serie di iniziative sia di pressione politica, a tutti i livelli, sia di informazione verso la popolazione. L'obiettivo dichiarato è quello di spingere verso una revisione delle politiche territoriali, per rendere l'Appennino territorio di una nuova forma di sviluppo: dalla piccola agricoltura, al ripristino delle forme di allevamento, fino al turismo paesaggistico, il tutto condito dal recupero dei vecchi borghi storici e del riabitarli.
Un movimento dal basso di cui seguire progressi ed evoluzioni. Una speranza, per la bellezza dell'Appennino, la cui unica possibilità di resistere sta nel passare dalla rassegnazione alla consapevolezza e poi all’azione politica.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
Anche questo fine settimana si è caratterizzato per il solito canovaccio, visto che tutti i quotidiani aprivano con la conta dell’ultimo naufragio e le parole del sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. I soccorsi sono stati affidati all’impegno dei nostri uomini della Marina Militare ed è già partita la macchina umanitaria della Caritas e delle altre associazioni impegnate su questo fronte sempre aperto.
A poche miglia dalla Libia sarebbero morte, precipitate in mare, decine e decine di persone. Quaranta erano in acqua e solo un uomo, ancor più distante dalle coste italiane, sarebbe stato salvato. I gommoni su cui viaggiavano con un centinaio di persone ciascuno, si sarebbero ribaltati. All’appello mancano almeno altre cinquanta persone se non più. Sparite nel nulla e finite nello stesso cimitero che accoglie ormai da anni i più sfortunati di questa odissea del mare.
Sono migliaia le persone che nelle ultime settimane sono state tratte in salvo. Senza l’operazione “Mare Nostrum”, che rappresenta ben oltre e ben prima di qualsiasi normativa sull’immigrazione, un’azione umanitaria, nessuno probabilmente si sarebbe salvato. Un’azione che investe l’Italia per prossimità geografica con le terre dell’esodo, ma che restituisce all’Europa intera una veste di civiltà in una pagina storica di migrazione continua e disperata senza precedenti.
Palermo si prepara ad accogliere con ogni mezzo 700 migranti. Caritas e diocesi ospiteranno moltissime di queste persone, circa 400, specialmente minori, molti dei quali si scopriranno non accompagnati al momento dell’identificazione. Sarà così che, raccogliendo l’appello di Papa Francesco, conventi ed edifici religiosi per lo più vuoti e sigillati troveranno una loro nobile ragione d’uso e un senso di cristianità autentica da troppo tempo smarrito.
Si sono attivate parrocchie, ma anche strutture comunali, ex edifici scolastici e polizia municipale per i trasferimenti sul territorio di queste persone e tutta la cittadinanza è stata chiamata a mobilitarsi. Oltre l’assistenza immediata ci saranno poi presidi sanitari con equipe di medici e mediatori culturali per intercettare immediatamente ogni problema di tipo sanitario, sia per la tutela di queste persone che per la sicurezza collettiva. Anche se, come emerso nel dibattito dei giorni scorsi, la sindrome degli untori - cosi come viene percepito il rischio che i migranti portino malattie e infezioni - è fondata solo su pregiudizi di ordine culturale ben cavalcati da politici allo sbaraglio. Sono infatti persone cosi debilitate che contraggono virus di continuo e rischiano la vita arrivati sulle nostre terre.
Anche se, come emerso nel dibattito dei giorni scorsi, la sindrome degli untori - cosi come viene percepito il rischio che i migranti portino malattie e infezioni - è fondata solo su pregiudizi di ordine culturale ben cavalcati da politici allo sbaraglio. Sono infatti persone cosi debilitate che contraggono virus di continuo e rischiano la vita arrivati sulle nostre terre.
Il piano di soccorso messo in moto per gli sbarchi è nella sua eccezionalità straordinario, ma per esser portato ad un livello di maggiore efficacia ed efficienza politica sul lungo periodo ha bisogno di essere condiviso con il resto d’Europa, a partire dai centri di espulsione: dalla vergogna del nome alla nullità dell’efficacia. Spetta al governo dei giovani andare a reclamarne l’urgenza forse profittando proprio del semestre europeo che ci vede al timone.
Ma in un clima di continui detrattori e infangatori professionisti del nostro Paese, Mare Nostrum racconta quello che avviene nelle acque del mare a ogni ora del giorno e della notte. Questo coro di sforzi, di alleanza tra istituzioni, cittadini, militari, chiese e associazioni rappresenta almeno una bellissima pagina di umanità.
Città e famiglie di una regione d’Italia che sebbene patisca la crisi più di altre aprono le porte a stranieri e rifugiati, è un segno di coraggio. Un’autorizzazione alla speranza e anche una traccia splendente dell’anima cristiana dell’Europa. La stessa anima che non si vede nei 700 metri quadri di marmi della residenza del cardinale Bertone, uomo di Dio ma troppo lontano da questi uomini che vengono dall’inferno a chiedere aiuto.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Hanno fra i quattordici e poco più di diciotto anni. Sono per lo più di genere maschile e il 32 per cento di loro è di origine straniera, molto diversificata per cultura ed etnia. Minori di seconda generazione, minori non accompagnati. La maggior parte di loro ha un diploma di scuola media inferiore e proviene da famiglie molto numerose.
Sono gli adolescenti entrati nel circuito della giustizia minorile. I quali non sono più espressione unica di famiglie con disagio (solo) economico ma sembrerebbero essere giovani che vivono in famiglie disgregate.
E non perché i minori si trovino in situazioni di conflittualità con la famiglia ma piuttosto in una condizione di assenza. Assenza di relazioni, di spiegazioni e di risposte. O di angoscia dei genitori che non riescono a trasmettere la speranza di potercela fare. La delusione, la rabbia e il senso di abbandono sono fattori di rischio rispetto alla devianza degli adolescenti. Ma anche l’uso di sostanze stupefacenti, così come la le altre dipendenze, sono caratterizzanti stili di vita strettamente connessi al fenomeno.
La maggior parte dei minori, secondo quanto si legge nell’indagine Lavori ingiusti di Save the children, finanziata dal Dpartimento Giustizia Minorile, afferma di aver iniziato le proprie azioni illecite tra i dodici e i quindici anni. Questi giovani sentono di vivere in un contesto di diffusa a-legalità, dove si è contratta l’idea di uguaglianza e dove si soffrono le discriminazioni non legate alle qualità personali. Proprio nel periodo più delicato: fra i quattordici e i quindici anni si acutizzano le forme più evidenti di dispersione scolastica, fra bocciature e abbandoni. Per loro, a detta degli operatori dei Centri per la giustizia minorile, la scuola è un ambiente respingente ed espulsivo.
Certamente l’ambiente scolastico si dimostra carente di risorse (soprattutto umane) per gestire situazioni più complesse. Perché parrebbe ancora (anacronisticamente, ndr) rispondere a un canone educativo fortemente strutturato su obiettivi da raggiungere ma troppo distante dalle esigenze di tanti minori. Il vuoto scolastico si concretizza, poi, principalmente dopo l’età dell’obbligo. Difficilmente l’impegno degli studi costituisce l’occupazione principale né viene percepita come un investimento utile per formarsi e accedere a condizioni di vita diverse: i bisogni di vita personali e famigliari prendono il soppravvento. Sembrerebbero essere condannati a un destino ineluttabile, quello delle proprie famiglie, e a dover rispondere, appunto, a una mancanza di prospettive e alternative. Per sopravvivere alla complessità e al disorientamento sociale, si occupano solo dei bisogni primari.
Difficilmente l’impegno degli studi costituisce l’occupazione principale né viene percepita come un investimento utile per formarsi e accedere a condizioni di vita diverse: i bisogni di vita personali e famigliari prendono il soppravvento. Sembrerebbero essere condannati a un destino ineluttabile, quello delle proprie famiglie, e a dover rispondere, appunto, a una mancanza di prospettive e alternative. Per sopravvivere alla complessità e al disorientamento sociale, si occupano solo dei bisogni primari.
Come? Lavorando precocemente. Si, perché, dalle interviste svolte nei Centri per la giustizia minorile, emerge che la maggior parte di loro ha svolto un’attività lavorativa tra i quattordici e i quindici anni e i restanti hanno lavorato prima di compiere tredici anni. Per le proprie spese personali o per aiutare la famiglia.
Impiegati nella ristorazione, in cantiere, in campagna, nelle officine, nelle fabbriche, nei distributori di benzina. Per pochi soldi. Con orari estenuanti, condizioni di sicurezza inesistenti, rapporti con i datori di lavoro e con i colleghi spesso aggressivi e violenti. Esperienze che, oltre a essere illegali, si dimostrano discontinue, sottopagate e non qualificanti. Non di rado, irreversibili.
E, certamente, non sono un deterrente alle possibili attività illecite e devianti. Tipo reati contro il patrimonio, vedi furto o rapina, o reati contro la persona, per esempio lesioni volontarie, fortunatamente, sono sempre meno.
Negli ultimi cinque anni, infatti, stando a quanto riportato dal 2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e dal Centro Europeo di Studi Nisida, diminuiscono le segnalazioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile ai Servizi della Giustizia Minorile, cala il numero dei minori fermati e arrestati e il numero degli ingressi negli Istituti penali. Ad maiora.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
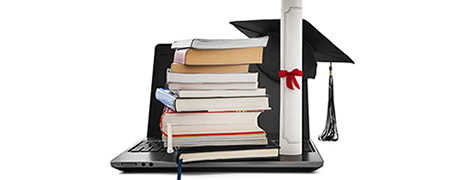 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Vivono tra esperienze di studio all’estero, tirocini formativi e lavori durante i corsi. E dietro, l’ombra della famiglia. Così, secondo il XVI Rapporto sul profilo dei laureati di Almalaurea, si muovono gli studenti universitari italiani del 2013. Con ordine: la probabilità di accesso agli studi universitari è il risultato di un processo causale in cui l’origine sociale ha un ruolo determinante. E cioè, gli studenti di estrazione elevata sono favoriti per quanto riguarda la possibilità di proseguire gli studi oltre l’obbligo scolastico, fino al completamento degli studi universitari.
Di più: il contesto socio-economico di origine ne influenza anche le preferenze disciplinari. Esempio: i laureati provenienti da famiglie più istruite hanno scelto frequentemente le discipline di medicina, giurisprudenza e farmacia. Completamente indipendenti, invece, dalle condizioni socioeconomiche della famiglia sono le motivazioni che spronano all’iscrizione all’università. Fattori culturali e fattori professionalizzanti alla base della scelta del corso di laurea, entrambi determinanti per la metà degli studenti, ma i secondi sono stati decisivi per i laureati in ingegneria, statistica, insegnamento e professioni sanitarie.
Al contesto familiare di provenienza è legata anche l’eventualità di lavorare nel corso degli studi universitari: all’aumentare del titolo di studio dei genitori, infatti, diminuisce la percentuale di laureati che hanno svolto un’attività lavorativa. La quale, negli ultimi anni, complici forse le crescenti difficoltà occupazionali legate alla crisi in atto, è andata sensibilmente contraendosi.
A rimboccarsi le maniche durante gli studi sono soprattutto i maschi; gli studenti delle facoltà di scienze umane e sociali e quelli del centro-nord, e circa la metà dei lavoratori-studenti, ha svolto un’attività coerente con gli studi in corso. Come ovvio, poi, al crescere dell’impegno lavorativo si associa una diminuzione della frequentazione delle lezioni. E lo spettro delle origini socio-familiari si aggira anche sulla partecipazione o meno ai programmi di studio all’estero: il livello di istruzione dei genitori interviene come fattore selettivo nei confronti della probabilità di accesso allo studio all’estero.
Esperienza che è più fattibile per gli studenti degli atenei dell’Italia nord orientale, destinazione Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, mentre quella meridionale e insulare si mantiene un’area in cui le reti di accordo sulla mobilità per studio sono meno diffuse.
 E il grado (elevato) di istruzione dei genitori influenza pure la possibilità di ottenere buoni risultati, insieme al genere (femminile), al diploma secondario liceale, ai buoni voti di diploma e alle forti motivazioni culturali nella scelta del corso di laurea. Fattore, quest’ultimo, che, insieme alla riuscita negli studi scolastici, al gruppo disciplinare e al lavoro durante i corsi universitari, determina la regolarità o meno negli studi.
E il grado (elevato) di istruzione dei genitori influenza pure la possibilità di ottenere buoni risultati, insieme al genere (femminile), al diploma secondario liceale, ai buoni voti di diploma e alle forti motivazioni culturali nella scelta del corso di laurea. Fattore, quest’ultimo, che, insieme alla riuscita negli studi scolastici, al gruppo disciplinare e al lavoro durante i corsi universitari, determina la regolarità o meno negli studi.
Dal 2001 al 2013, i laureati in corso sono più che quadruplicati mentre quelli fuori corso sono diminuiti e il ritardo alla laurea, complice il fatto che l’elaborazione della prova finale nell’università post riforma richiede un impegno di tempo inferiore, si è più che dimezzato. Un netto miglioramento anche se eterogeneo: irregolari gli studenti del gruppo giuridico e molto in regola quelli dell’area medica.
Tirando le somme, tra i laureati del 2013 si rileva una generale soddisfazione per l’esperienza universitaria. Apprezzati il corso di studio e i rapporti con i docenti, contestati l’inadeguatezza delle aule e delle postazioni informatiche. Con la laurea in mano, non tutti i dottori hanno intenzione di mettersi subito alla ricerca di un impiego. Che preferirebbero trovare fra quattro aree: ricerca e sviluppo, organizzazione e pianificazione, risorse umane e selezione, marketing e comunicazione. Magari anche fuori dal Belpaese.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Dal pater familias ai nuovi padri. Quelli degli anni Dieci hanno abbandonato il rapporto padre-figlio basato sull’autorità e sul giudizio, in vigore fino al periodo della Restaurazione, e si sono orientati, dopo l’industrializzazione con la sua buona dose di femminismo, verso una paternità che include anche la sfera affettiva, prima ad appannaggio delle madri.
E’ quanto si legge in uno studio effettuato da Eurispes, che dimostra come oggi la figura materna e quella paterna siano intercambiabili nella cura dei figli. Per cui è del tutto normale che un padre dia da mangiare ai figli, racconti loro le favole, li accompagni alle attività extrascolastiche, li faccia addormentare, li lavi, cambi loro i pannolini e li vesta, li segua nei compiti.
Una concezione moderna di padre anche se alcuni risultati emersi dalle risposte degli intervistati indicano il permanere di una resistenza a riconoscere che i padri sacrifichino la sfera lavorativa per occuparsi della prole. La “rivoluzione paterna” non è ancora approdata a una visione pienamente paritaria: quasi la metà del campione preso in esame si dice abbastanza convinto che ci siano attività legate alla cura dei figli più adatte alle mamme che ai papà.
Va da sé che alla sfera lavorativa e alla carriera professionale delle donne non venga attribuita la stessa rilevanza che viene riservata a quelle degli uomini. A fare questa considerazione sono soprattutto quelli che hanno un basso titolo di studio, i quali faticano ad accogliere alcuni cambiamenti avvenuti nella società contemporanea. In corrispondenza di titoli di studio più elevati, infatti, si nota una sempre maggiore sensibilità rispetto all’importanza di un’equa ripartizione delle mansioni, anche al fine di tutelare la posizione lavorativa della donna. Ma, definizione (grossolana) dei ruoli a parte, dall’insieme delle risposte emerge un quadro che dipinge i “nuovi padri” molto presenti nella vita dei figli, che offrono cure e beni materiali, che li aiutano a risolvere i problemi, lasciando loro poco spazio per affrontarli in prima persona, che ne indirizzano il percorso di vita, intervenendo nelle scelte fondamentali. Sono più protettivi ma anche più invadenti. Un punto di riferimento e una guida. Più aperti al dialogo e alla comprensione che in passato. Più amici che educatori. Più empatici e meno autorevoli. Anche se qualcuno, fra gli intervistati, li vorrebbe più punitivi e più autoritari.
Ma, definizione (grossolana) dei ruoli a parte, dall’insieme delle risposte emerge un quadro che dipinge i “nuovi padri” molto presenti nella vita dei figli, che offrono cure e beni materiali, che li aiutano a risolvere i problemi, lasciando loro poco spazio per affrontarli in prima persona, che ne indirizzano il percorso di vita, intervenendo nelle scelte fondamentali. Sono più protettivi ma anche più invadenti. Un punto di riferimento e una guida. Più aperti al dialogo e alla comprensione che in passato. Più amici che educatori. Più empatici e meno autorevoli. Anche se qualcuno, fra gli intervistati, li vorrebbe più punitivi e più autoritari.
Viene fuori, dunque, un’immagine di padre che non è più legata alla stabilità economica ma si focalizza sull’affettività e sull’interesse, sebbene argomenti intimi e profondi come la sessualità , il rapporto con gli amici e il consumo di sostanze stupefacenti non rientrano fra i temi della loro dialettica. Faticano, insomma, ad avere un confronto aperto con i figli. Nonostante tutto, però, difendono la loro paternità con le unghie e con i denti: preferiscono gestirla in maniera autonoma e sono abbastanza sicuri di questa loro identità. Più ricca, fatta di “tenerezza, empatia e vicinanza fisica”, maggiormente solida perché il rispetto da parte dei figli non viene dal timore della figura genitoriale ma da una forma di “stima”.
Tutto confermato anche per i single e i monogenitori, fuori però dalle dinamiche di gestione di cura e coinvolti, invece, in tanti casi, nelle aule di tribunale dove regna incontrastato lo stereotipo materno e viene mortificato il ruolo di padre, considerato solo un salvadanaio dal quale attingere un sostentamento economico. Invece, loro nella vita quotidiana di rapporto con i figli tirano fuori più “amore” e più “responsabilità” dei padri in coppia. Dostoevskij docet: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”.
