- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Siamo in un piccolo villaggio, in qualche posto tra il Nord D’Africa e il Medio Oriente. Qui sono le donne a dover portare l’acqua al villaggio, dove non c’è nulla: niente acqua, né elettricità o altro che assomigli alla modernità. Ma prendere l’acqua non è un’impresa così semplice. Bisogna arrivare sulla cima di una montagna, camminare a lungo sotto un sole che scotta. Agli uomini non interessa della difficoltà, se ne stanno al bar a bere e così Leila, una giovane sposa, propone alle donne di fare lo sciopero dell'amore: niente più sesso ed effusioni se gli uomini non porteranno l’acqua al villaggio.
È quanto racconta La sorgente dell’amore, nuovo film di Radu Mihaileanu, che ha deciso di raccontare una storia di donna da un punto di vista totalmente nuovo: uno sciopero diverso da quelli a cui solitamente si è abituati, ma probabilmente ben più efficace. Alcune donne negli anni hanno anche avuto aborti spontanei dovuti proprio alla fatica di portare secchi pesantissimi o cadendo sotto il peso dell’acqua raccolta. Leila, detta “la straniera” perché viene dal Sud, diventa la voce di tante donne che non accettano più di sopportare in silenzio un destino che è stato deciso per loro dagli uomini e da una serie di convenzioni.
Leila ha un coraggio diverso dalle altre, un fondo di libertà forte che è potente come l’amore del suo Sami che l’ha voluta per sposa nonostante la disapprovazione di sua madre Fatima. Ma Leila ha un’altra arma dalla sua parte: l’istruzione. Sa leggere e interpretare le Scritture, dove l’amore non è sottomissione, ma parità.
E così Leila comincerà la sua speciale rivoluzione, coinvolgendo anche le altre. Con l’aiuto di “Vecchia lupa”, madre di un Imam, la bella Leila riuscirà a coinvolgere le altre donne nello sciopero dell’amore. Radu Mihaileanu ha un’idea decisamente giusta, nonostante non riesca totalmente a portarla a compimento, come invece ha fatto con Il Concerto.
C’è un po’ di ovvietà in alcuni passaggi, nonostante ci sia originalità nel raccontare il rapporto uomo-donna nel mondo islamico partendo dall’idea di una forma di protesta differente dalle consuete. Partendo da un fatto di cronaca avvenuto in Turchia nel 2001, il regista di Train de vie racconta la difficoltà del dialogo tra i due sessi. Girato in dialetto marocchino, il film ha la forma di una commedia ‘orientale’, ma avremmo voluto forse maggiore profondità nel racconto, come il regista di origini rumene era riuscito a offrire in precedenti lavori.
La sorgente dell’amore (Belgio, Francia, Italia 2011)
regia: Radu Mihaileanu
sceneggiatura: Alain-Michel Blanc, Radu Mihaileanu
attori: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Hiam Abbass, Saleh Bakri, Sabrina Ouazani, Mohamed Majd
fotografia: Glynn Speeckaert
montaggio: Ludo Troch
musiche: Armand Amar
produzione: Elzévir Films, Europa Corp., Indigo Film
distribuzione: Bim



- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Gli ultimi Oscar del cinema hanno consacrato il cinema dei vecchi tempi. Quello addirittura che nel muto riusciva ugualmente a veicolare grandi storie e forti sentimenti. The Artist, film muto in bianco e nero scritto e diretto da Michel Hazanavicius e interpretato da Jean Dujardin e Bérénice Bejo, ha infatti fatto incetta di premi, tra cui l’Oscar al miglior film. E pensare che era dall’edizione del 1929 che un film muto non vinceva tale premio.
La bellezza di questo film, oltre all’ottima interpretazione dei due attori, è la capacità della musica di essere parte fondamentale del racconto. Siamo in una Hollywood del 1927. George Valentin è un grande divo del cinema muto, un giorno, alla premiere di un suo film, viene fotografato insieme ad una ammiratrice, Peppy Miller. La foto verrà poi pubblicata sulla prima pagina di Variety. Qualche tempo dopo Valentin ritrova la ragazza sul set di un suo film come comparsa e durante le riprese del film si sviluppa una forte attrazione tra i due, che però non si trasforma in altro.
L’avvento del sonoro, però, rivoluziona la carriera di Valentin e dopo le prime difficoltà ci saranno belle sorprese per l’attore. Un film francese, dunque, riesce a rivoluzionare l’Accademy e a ridare vigore al cinema hollywoodiano, spesso troppo preso da grandi budget e poca sostanza.
È sui volti degli attori, allora, che torna preponderante l’attenzione, in mancanza della parola. Sui loro corpi che danzano e si muovono sinuosi, un po’ Fred Astaire e Ginger Rogers, un po’ vecchi capolavori degli anni 20 e 30 dove la gestualità aveva un ruolo da protagonista, come ci ha insegnato bene Charlie Chaplin.
Ancora una volta si parla di un divo del muto che cade in disgrazia con l’invenzione del sonoro, come già nel capolavoro di Billy Wilder, Viale del Tramonto. Ma se nel film del 1950 l’attrice Norma Desmond cadeva vittima della pazzia e si macchia dell’omicidio del giovane amante, nel film di Hazanavicius il protagonista verrà salvato dall’amore di una sua fan.
Torna così anche il tema del divismo e lo si scardina al tempo stesso. Se Norma Desmond incarna una ex diva, un tempo acclamata come una dea e ora dimenticata, George Valentin riesce invece a non cadere nel dimenticatoio, grazie anche all’amore. Molto bella anche la figura del cagnolino che segue il suo padrone sulle note della musica.
Sebbene il film sia in bianco e nero, è però stato girato a colori e, per dargli un ulteriore aspetto che ricordasse i film muti degli anni venti, è stato girato con una frequenza più bassa dei fotogrammi per secondo: 22 invece dei consueti 24.
The Artist (Francia 2011)
regia: Michel Hazanavicius
sceneggiatura: Michel Hazanavicius
attori: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell, Missi Pyle, Penelope Ann Miller, Malcolm McDowell
fotografia: Guillaume Schiffman
montaggio: Tariq Anwar
musiche: Ludovic Bource
produzione: La Petite Reine in coproduzione con Studio 37 e France 3 Cinéma
distribuzione: BIM Distribuzione



- Dettagli
- Scritto da Administrator
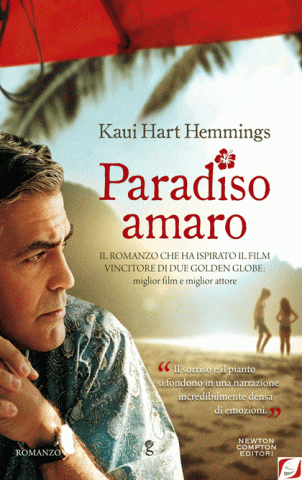 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
La bellezza mozzafiato di un posto come le Hawaii può nascondere una vita non altrettanto paradisiaca. Il nuovo film di Alexander Payne, Paradiso amaro (The Descendants), che vede protagonista un discreto George Clooney, racconta la storia di Matt King, discendente di una facoltosa famiglia hawaiiana, marito distaccato e padre assente. Quando la moglie Elizabeth entra in coma irreversibile, dopo un incidente nautico al largo di Waikiki, si ritrova a mettere in discussione la sua vita. Deve recuperare innanzitutto il rapporto con le figlie, la ribelle Alexandra e la piccola Scottie, fino all'amara scoperta che la moglie lo tradiva.
Paradiso amaro, che prende spunto dal romanzo di Kaui Hart Hemmings, “Eredi di un mondo sbagliato”, segna il ritorno alla regia di Payne, a oltre sei anni dal pluripremiato Sideways - In viaggio con Jack. Anche Paradiso amaro prometteva bene, dato che ha ottenuto cinque candidature ai premi Oscar 2012, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista, aggiudicandosi la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale.
Il regista riesca a bilanciare bene il drammatico con il comico, costruendo con capacità l’alternanza tra la risata e le lacrime. La tematica dell’abbandono, della perdita della persona amata va a scontrarsi con il sentimento travolgente della rabbia per aver scoperto il tradimento proprio da parte di quella persona che ora è la più debole e che ha bisogno di sostegno.
Sicuramente uno spunto interessante, che la sceneggiatura non manca di cogliere e portare avanti con capacità, nonostante ci siano momenti in cui la regia lascia intravedere delle lacune.
Quello che piace, è sicuramente l’utilizzo dell’elemento ironico, caro a Payne. Già in A proposito di Schmidt, con l’istrionico Jack Nicholson, aveva dimostrato il suo talento nel raccontare il decadimento di un uomo, la vecchiaia e la lotta contro il mondo utilizzando il difficile strumento della commedia che spesso non viene capito dai più, mentre ha la grandissima capacità di raccontare drammi veri attraverso toni più leggeri, ma mai scontati.
Paradiso amaro (Usa 2012)
regia: Alexander Payne
sceneggiatura: Alexander Payne, Nat Faxon, Jim Rash
attori: George Clooney, Judy Greer, Shailene Woodley, Matthew Lillard, Beau Bridges, Robert Forster, Rob Huebel, Patricia Hastie, Michael Ontkean, Mary Birdsong, Milt Kogan, Amara Miller, Nick Krause
fotografia: Phedon Papamichael
montaggio: Kevin Tent
produzione: Ad Hominem Enterprises
distribuzione: 20th Century Fox



- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
“Attraverso la commedia si possono affrontare, a volte anche meglio del genere drammatico, temi importanti e anche difficili, come quello dei padri separati. Il film non prende le parti di nessuno, non va contro le donne e non patteggia per gli uomini, ma cerca di dare una lettura a una questione di grande attualità”. Parola di Carlo Verdone, che alla prima del suo nuovo film, Posti in piedi in Paradiso, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, annuncia così il tema del suo ultimo lavoro. Ulisse, interpretato dallo stesso Verdone, Fulvio, un sempre bravo Pierfrancesco Favino e Domenico, i cui panni sono vestiti dal “colorito” Marco Giallini.
Sono tre padri separati costretti a versare quasi tutto quello che guadagnano in alimenti e spese di mantenimento per ex mogli e figli. Un tempo stimati professionisti (Ulisse un produttore musicale di successo, Fulvio un critico cinematografico affermato e Domenico proprietario della più grande agenzia immobiliare di Roma), vivono ora in grandi difficoltà economiche e si ritrovano a sbarcare il lunario come possono.
Ulisse si è stabilito nel retro del suo negozio di vinili, legato a un passato che non esiste più, e arrotonda le scarse entrate vendendo “memorabilia” su e-bay. Ha una figlia, Agnese, che sta a Parigi con la madre Claire, un’ex cantante che lo incolpa del mancato successo.
Fulvio, dopo aver tradito “epistolarmente” la moglie Lorenza con la donna del suo capo, si è ritrovato, oltre che senza famiglia, anche senza un lavoro, costretto così a scrivere di gossip. Con i pochi soldi che riesce a racimolare raccontando i fatti altrui, si paga una stanza presso un convitto di religiose. Anche lui ha una bambina, di tre anni, che non vede quasi mai a causa del pessimo rapporto con l’ex.
Domenico, in passato ricco imprenditore, è oggi un agente immobiliare che dorme sulla barca di un amico e, per mantenere ben due famiglie, fa il gigolò con le signore di una certa età. Ha un rapporto conflittuale con i due figli più grandi ed è perennemente in ritardo con gli alimenti da versare alla sua ex moglie e all’ex amante Marisa, da cui ha avuto un’altra figlia di cui non ricorda nemmeno il nome. La sua figura è certamente quella più biasimabile, nonostante alla fine si provi anche per lui un po’ di tenerezza.
Le tre vite s’intrecciano in modo del tutto casuale. Durante la ricerca di una casa in affitto, Domenico realizza di avere incontrato due poveracci come lui e propone a Ulisse e Fulvio di andare a vivere insieme per dividere le spese di un appartamento. Un rapporto quasi studentesco, nonostante i tre abbiano da un pezzo superato i vent’anni. Inizia così una convivenza sgangherata, che li porterà a una forzata amicizia la quale si rivelerà in qualche modo benefica.
Una sera, dopo uno dei suoi incontri di lavoro a suon di viagra, Domenico si sente male. Preoccupati, Ulisse e Fulvio chiamano il pronto intervento. Arriva Gloria, interpretata da una “svampita” Micaela Ramazzotti, una cardiologa che, mollata su due piedi qualche ora prima dall’amante, si presenta ai tre in uno stato pietoso. Trucco sbafato, stato d’agitazione e attacchi d’ansia creano una figura alquanto caricaturale che spaventa un po’ i tre. Tra lei ed Ulisse, però, scocca presto la scintilla. Insomma un incontro perfetto tra due disastri nelle relazioni sentimentali. Anche Fulvio ha un incontro folgorante: con Gaia, una starlette tanto bella e attraente quanto superficiale. Tra di loro le cose non potranno funzionare e presto la storia finirà.
Intanto la situazione economica dei tre amici peggiora sempre di più e dopo una serie di avventure tragicomiche e di tentati furti, bisogna fare i conti con le proprie responsabilità. In loro aiuto arriveranno i figli. I giovani, infatti, sono la forza trainante, sembra dire Verdone, coloro che risolleveranno le sorti dei padri. Nuove vite, allora, potranno ridare vigore a esistenze grigie.
Nonostante il trauma della lontananza dai rispettivi padri e un rapporto spesso tormentato, saranno loro la chiave di volta che consentirà a Ulisse, Fulvio e Domenico di riprendere in mano la propria vita e di intravedere finalmente uno spiraglio di “Paradiso”. Anche se probabilmente senza posti a sedere.
Verdone riprende un po’ della sua verve in quest’ultimo lavoro, riacquisendo la capacità di essere un bravo caratterista, nonostante la storia sia un po’ “fiacca” soprattutto nel finale, ampiamente edulcorato. Certamente non mancano le battute divertenti, che strappano la risata, e la bravura degli attori copre qualche sbavatura di regia e sceneggiatura.
Posti in piedi in Paradiso (Italia 2012)
Regia: Carlo Verdone
Sceneggiatura: Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Maruska Albertazzi
Attori: Carlo Verdone, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Diane Fleri, Nicoletta Romanoff, Nadir Caselli, Valentina D'Agostino, Maria Luisa De Crescenzo, Giulia Greco, Gabriella Germani, Roberta Mengozzi
Fotografia: Danilo Desideri
Montaggio: Antonio Siciliano
Musiche: Gaetano Curreri, Fabio Liberatori
Produzione: Aurelio De Laurentiis & Luigi De Laurentiis
Distribuzione: Filmauro



- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Il fantastico, il 3D e il digitale sono gli ingredienti scelti da Martin Scorsese per il suo nuovo film, Hugo Cabret. Mondi nuovi, quelli scelti dalla sapiente mano registica dell’autore di capolavori come Taxi Driver, ma usati in maniera differente rispetto a chi “padroneggia” tecniche ultra innovative. Il tocco cinefilo, la passione per l’universo cinematografico, sono ben visibili nella trama come nell’uso del racconto e della macchina da presa.
Hugo Cabret è un orfano che ha scelto la stazione del treno come sua dimora. Ci vive in gran segreto, tentando di passare inosservato agli sguardi delle centinaia di persone che ogni giorno la frequentano. Parigi, e più precisamente Montparnasse, è lo scenario in cui si staglia la vita di questo giovane ragazzo degli anni trenta.
Del padre orologiaio conserva un automa rotto che si ostina a voler riparare e con l’aiuto dell'eccentrica Isabelle scoprirà bene presto che questo robot cela segreti che riportano a galla vicende del passato. Ricordi e avvenimenti che coinvolgono anche il padrino di Isabelle, Georges Méliès, il quale si rivela essere uno dei più grandi autori della storia del cinema, mentre credeva di essere stato dimenticato da tutti.
L’avventura è l’ingrediente giusto per la storia di questo ragazzino, che entrerà in contatto con un anziano e misterioso gestore di un negozio di giocattoli, finendo risucchiato in una magica e misteriosa esperienza.
Il soggetto del film è tratto dal libro “La straordinaria invenzione Hugo Cabret”, di Brian Selznick, edito da Mondadori. Scorsese guarda il nuovo mondo del cinema attraverso i grandi occhi azzurri di Hugo (interpretato da Asa Butterfield) che nascosto tra le mura della stazione, scruta con attenzione e qualche risatina, i passeggeri che danno vita a tante gag, in una Parigi del passato che si trasforma quasi in un palcoscenico teatrale con vari siparietti.
Atmosfere sospese tra sogno e realtà, dove il passato si fa rivelatore di verità sconosciute, facendo scoprire a Hugo anche il magico fascino del cinema. Un cinema fatto di tecnica e di ingranaggi, tanto che la chiave a forma di cuore che trasforma tutti i personaggi del film e dà vita all’automa è il simbolo di un modo di concepire sia la vita che la settima arte. Il mondo è così una macchina in cui ogni parte ha una funzione.
Alcune scene del film sono state presentate in anteprima durante la sesta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Presenti all'evento, focalizzato soprattutto sulla tecnica 3D utilizzata, l'autore del libro, la scenografa ed il giovane protagonista Asa Butterfield. Il 15 gennaio 2012, in occasione della premiazione dei Golden Globe, Hugo Cabret ha fatto guadagnare a Martin Scorsese il premio come miglior regista ed è ora in corsa per i Premi Oscar 2012 con 11 nomination.
Hugo Cabret (Usa 2011)
regia: Martin Scorsese
sceneggiatura: John Logan
attori: Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloe Moretz, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, Emily Mortimer, Johnny Depp, Christopher Lee, Michael Stuhlbarg, Helen McCrory, Jude Law, Richard Griffiths, Frances de la Tour, Angus Barnett, Eric Moreau
fotografia: Robert Richardson
montaggio: Thelma Schoonmaker
musiche: Howard Shore
produzione: GK Films
distribuzione: 01 Distribution



