- Dettagli
- Scritto da Administrator
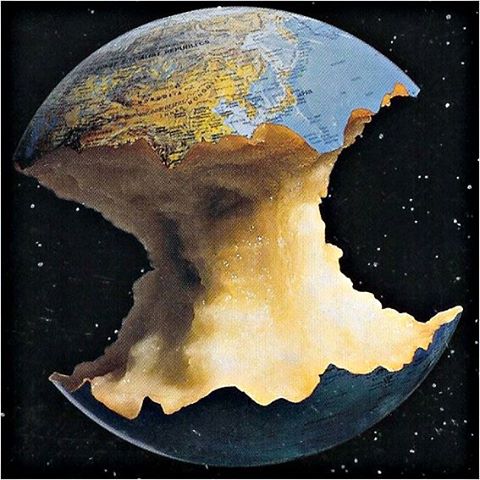 di Jacopo Risdonne
di Jacopo Risdonne
13 Agosto 2015: la Terra è ufficialmente in rosso. In meno di otto mesi abbiamo già esaurito le risorse naturali dell’intero anno. E andremo a saccheggiare quelle del futuro. In pratica, secondo il Global Footprint Network, siamo in debito ecologico e ci sarebbe bisogno di una Terra e mezzo per sostenerci a questi ritmi. Ben fatto. L’Earth Overshoot Day - questo il nome della ricorrenza - segna il giorno in cui la domanda annuale di risorse dell’umanità eccede ciò che la Terra è in grado di rigenerare nello stesso anno.
Proprio come le banche tracciano le uscite e le entrate, il Global Footprint Network (GFN) misura la differenza tra la nostra domanda di risorse naturali e servizi ecologici e quanto il Pianeta possa metterci a disposizione.
Secondo il bollettino emesso dagli esperti, consumiamo più legna di quanto ne producano le foreste, mangiamo più animali di quanto il loro ciclo riproduttivo riesca a farne nascere, emettiamo anidride carbonica nell’atmosfera ad un ritmo tale da ostacolare il suo naturale assorbimento. In soldoni, stiamo vivendo oltre il limite.
E se nulla cambia - avvertono gli scienziati - nell’arco di qualche lustro non avremo più la possibilità di ritornare sui nostri passi, ma solo di voltarci e contemplare ciò che è stato. Pertanto, “non è solo una data simbolo, ma un allarme importante”, sentenzia il climatologo Luca Mercalli. Tuttavia, pochi sembrano preoccuparsene.
Siamo giunti al primo overshoot nel 1970 (il 23 Dicembre), e da allora abbiamo macinato giorni su giorni sul calendario. Negli ultimi 15 anni la data dell’Earth Overshoot Day è avanzata a marce forzate: nel 2000 consumavamo il capitale naturale i primi di Ottobre, mentre l’anno scorso il 19 Agosto eravamo già in debito ecologico. Per soddisfare la domanda umana servirebbero 1.6 Terre. Nel 2030 potremmo arrivare a consumarne due: missione tutt’altro che impossibile, proseguendo alla stessa stregua degli ultimi decenni.
L’Italia, nel suo piccolo, ha fatto peggio della tendenza globale, conquistando un primato invidiabile: mentre l’allarme mondiale è scattato il 13 Agosto, quello per l’Italia non si è lasciato desiderare. Abbiamo esaurito il capitale naturale dello Stivale in soli 4 mesi, il 5 Aprile scorso.
In termini concreti, per soddisfare questi ritmi avremmo bisogno di 3.8 Italie. In Europa non abbiamo rivali in questo campo: anche se Svizzera e Regno Unito sono temibili (con una necessità rispettivamente di 3.5 e 3.0 volte le risorse disponibili entro i propri confini territoriali). Tuttavia, se può consolare, nel resto del mondo spiccano i dati del Giappone, che necessiterebbe di 5.5 Giapponi per supportare i suoi bisogni.
Un altro Giovedì nero, dunque - dopo quello del crollo della borsa di Wall Street - si insedia e si fa spazio tra le folte pagine della storia. Forse la notizia non attrae tanta attenzione quanto quella dei noti fatti del ’29 o di uno stato precipitato in un deficit finanziario, ma il resoconto pubblicato dal Global Footprint Network potrebbe avere effetti ben più duraturi e difficili da rovesciare. “In alcune aree del pianeta - secondo gli scienziati del GFN - le implicazioni dei deficit ecologici possono essere devastanti, condurre alla perdita delle risorse, al collasso degli ecosistemi, all’indebitamento, alla povertà, alla carestia ed alla guerra”.
I governi ignorano che le ripercussioni di decisioni politiche che mettono ai margini l’assioma ‘le risorse naturali sulla Terra sono limitate’ possono riverberarsi sulla performance economica a lungo termine; i governi palesano acute forme di miopia non considerando che la riduzione della loro dipendenza dalle risorse coincide con i loro interessi. A fronte di tutto ciò, comunque, non mancano casi di stati che, in vari modi, si stanno attivando per rimediare alle scelleratezze del passato. A tal proposito, è calzante il caso delle Filippine, degli Emirati Arabi e del Marocco. Ammirevoli, inoltre, sono i risultati della Danimarca, la quale ha tagliato le proprie emissioni di CO2 del 33% dagli anni ‘90.
A fronte di tutto ciò, comunque, non mancano casi di stati che, in vari modi, si stanno attivando per rimediare alle scelleratezze del passato. A tal proposito, è calzante il caso delle Filippine, degli Emirati Arabi e del Marocco. Ammirevoli, inoltre, sono i risultati della Danimarca, la quale ha tagliato le proprie emissioni di CO2 del 33% dagli anni ‘90.
Se fosse stata imitata dal resto degli stati questo articolo avrebbe avuto un’altro taglio ed un altro spirito; si sarebbe parlato di overshoot solo il 3 di Ottobre (secondo i calcoli del GFN). Ma questa è un’altra storia; la realtà dei fatti, ad oggi, é un’altra. La morale, al di là di tutto, è tanto chiara e limpida da sembrar degna di una delle favole di Esopo: ridurre il calco della nostra impronta ecologica sulla Terra non è un miraggio od un’utopia.
Come un geco che perde la sua coda, dunque, la Terra è in grado di auto-risanarsi e rigenerarsi. Tuttavia, questo processo richiede tempo. E noi, come è noto, non sappiamo attendere. Come in preda ad istinti dionisiaci sembriamo marionette sotto il controllo di impulsi irrazionali. Ci stiamo spingendo oltre i confini della ragione, rinnegando ogni legge non scritta che vede l'uomo come l'essere vivente razionale per antonomasia. Ci ostiniamo a schiacciare con indomabile forza e sordida avarizia il piede sull'acceleratore.
Con insaziabile voracità estraiamo capitale naturale da una miniera dalle ricchezze finite, da un pozzo dalle risorse limitate. Da oggi stiamo chiedendo al nostro Pianeta ciò che non può darci. Non stiamo dando alla coda il tempo di ricrescere.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Finalmente diminuiscono. Non sono, certamente, quanti quelli del 1991, in seguito al provvedimento di amnistia - l’ultimo del dopoguerra - ma nemmeno più di sessantotto mila come nel 2010. Sarà stata la paura per la condanna da parte della Corte europea che sul punto era intervenuta nel 2013, sta di fatto che il trend crescente del numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani ha subìto una battuta d’arresto.
Dal 2012 le riforme messe in campo e consolidate di recente sono state latrici di una situazione di minore affollamento. Che, invece, i riordini legislativi precedenti non hanno per niente agevolato. La riforma dell’Ordinamento penitenziario , nel 1994, e la preclusione all’accesso alle misure alternative, la legge Bossi-Fini sull’immigrazione, nel 2003, le leggi sulle droghe e sulla recidiva, nel 2009, hanno fatto lievitare la popolazione detenuta.
Anche se va meglio, a oggi, comunque, sono tremila e duecentotrentadue i detenuti oltre capienza massima. Vuoi perché l’area delle misure alternative al carcere, sebbene sia maggiormente applicata, non ha sostituito quella di reclusione, vuoi per la particolare condizione di tanti detenuti stranieri, i quali, nonostante ricevano un provvedimento di espulsione continuano a rimanere in carcere perché non viene eseguito (e la condizione di espulsi non consente loro di accedere ai permessi e agli altri benefici fruibili dai detenuti non extracomunitari).
Sono in calo gli stranieri: dopo l’introduzione da parte della Corte di giustizia dell’Aja della disapplicazione del reato di inottemperanza all’obbligo di espulsione del questore, sono calati al 32,6 per cento, quattro punti in meno rispetto al 2010. E però, forse perché l’Ordinamento penitenziario è stato approvato quando la loro presenza non era percentualmente significativa da giustificare un trattamento particolare, si notano ancora situazioni di grande criticità.
E non solo per loro. Visitando quaranta istituti penitenziari, gli operatori dell’Associazione Antigone hanno segnalato gravi carenze. In tema di dignità, per esempio. Mancano i beni essenziali: dall’acqua corrente potabile a Tempio Pausania al vitto insufficiente di Frosinone. Al Pagliarelli di Palermo sono obbligati a portare le maniche lunghe fino all’arrivo dell’estate, stabilito secondo l’arbitrio della direzione.
Le otto ore fuori dalla cella, previste dal ministero della Giustizia in nome della dignità, non sempre trascorrono in occupazioni dotate di senso: a Isernia le attività sono del tutto convenzionali e poco utili ai fini del reiserimento sociale. O in tema di diritto al lavoro: a parte due realtà d’eccellenza, Massa Carrara e Lodè Mamone in Sardegna, in cui lavorano all’aperto praticamente tutti i centoquaranta detenuti, al Bancale di Sassari lavorano per pochi soldi, poche ore a settimana o per pochi giorni al mese; a Enna e a Brindisi, a lavorare sono meno del 15 per cento.
Così, alla resa dei conti, a fine 2014, lavorava in carcere poco più di un quarto dei reclusi. Non va meglio sul fronte del diritto all’istruzione, fattore di emancipazione da scelte di criminalità: a Sassari Bancali non sono presenti convenzioni con istituti di istruzione superiore cosicché quelli interessati sono obbligati a chiedere il trasferimento alla casa circondariale di Alghero. A parte il caso specifico, la politica dei trasferimenti non tiene conto dei bisogni di continuità, evadendo il diritto alla territorialità della pena. Che tutelerebbe anche i legami affettivi. Il cui mantenimento è un diritto, lontanissimo dall’essere garantito per l’assenza di una modifica normativa. Dunque, gli istituti attrezzati con aree colloquio per famiglie sono ancora in minoranza, dando luogo a file chilometriche di parenti. Una carenza che altera i (già complessi) rapporti. Di persone già vulnerabili socialmente e in condizioni psichiche molto precarie. Disagio molto diffuso tra la popolazione carceraria che richiederebbe la presa in carico (latitante) da parte dei Dipartimenti di salute mentale, per non lasciare soli gli operatori penitenziari.
Dunque, gli istituti attrezzati con aree colloquio per famiglie sono ancora in minoranza, dando luogo a file chilometriche di parenti. Una carenza che altera i (già complessi) rapporti. Di persone già vulnerabili socialmente e in condizioni psichiche molto precarie. Disagio molto diffuso tra la popolazione carceraria che richiederebbe la presa in carico (latitante) da parte dei Dipartimenti di salute mentale, per non lasciare soli gli operatori penitenziari.
Tanto per dirne una, a Tempio Pausania, lo psichiatra è presente in istituto solo per quattro ore a settimana per moltissimi detenuti. E dire che sarebbe necessario, considerato che i suicidi, in tutte le case circondariali della Penisola, sono stati ventiquattro nei primi sei mesi del 2015 su un totale di cinquantasette detenuti morti in carcere.
E poi, ritardi nelle visite specialistiche o nei ricoveri ospedalieri, mancato rispetto della privacy o della terzietà del ruolo del medico. Troppi ancora gli ergastolani, e in crescita rispetto al passato, e troppo pochi i permessi premio: in sei mesi, tre soli permessi ogni dieci detenuti. La durezza delle pene non ha nessuna efficacia deterrente. Serve una cura, per i cinquantaduemila e settecentocinquanta detenuti. E non solo per loro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
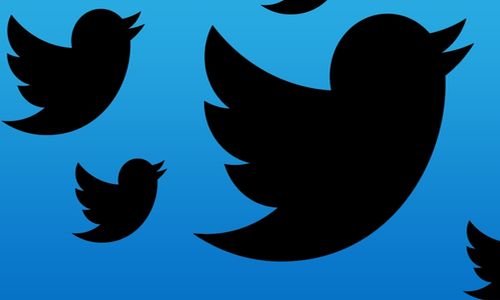 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Il periodo difficile di Twitter continua, sulla rete come a Wall Street. Giovedì scorso il titolo dell'uccellino azzurro è scivolato a 25,92 dollari, scendendo sotto il prezzo dell'Ipo datato novembre 2013 (26 dollari), per poi chiudere la settimana ancora peggio, a quota 25,87 dollari. Quello del social network sul listino americano è un volo con molte turbolenze, visto che nel corso della loro pur giovane storia in Borsa le azioni erano arrivate a toccare un massimo di 69 dollari, quasi tre volte il prezzo attuale.
Da allora, il tonfo è stato di circa 65 punti percentuali. Un'escursione di questa ampiezza significa che il valore della società è schizzato in breve a 41,5 miliardi - raggiunti poco dopo l'Ipo - per poi ridiscendere in picchiata fino ai 17,6 miliardi di oggi.
A livello tecnico, il -6% di giovedì si spiega anche come reazione all'ondata di acquisti arrivati nei giorni scorsi da parte di alcuni alti dirigenti (in prima fila l'attuale amministratore delegato ad interim e cofondatore dell'azienda, il 38enne Jack Dorsey), che hanno comportato un'impennata della quotazione pari al 10%, cui ha fatto seguito una pioggia di vendite. Da metà giugno, ovvero da quando Dick Costolo ha lasciato le redini dell'azienda a Dorsey, la flessione è stata del 28%.
La precarietà della leadership è un problema urgente per Twitter, che ha bisogno di tornare ad avere una guida solida. Voci di alcuni giorni fa parlavano di una conferma di Dorsey, che dovrebbe essere affiancato da Adam Bain nel ruolo di presidente e direttore operativo e da Even Williams - l’altro cofondatore - in qualità di numero uno del consiglio d'amministrazione.
A questo triumvirato dovrebbe essere affidato il compito di risolvere il problema numero uno in casa Twitter, ovvero lo stallo della crescita degli utenti. Il campanello d'allarme è scattato poche settimane fa con la pubblicazione dei dati del secondo trimestre, chiuso con un rosso di 137 milioni di dollari e soprattutto con 304 milioni di utenti ogni mese (contro gli 1,44 miliardi di Facebook), pressoché lo stesso numero della fine di giugno 2014.
In realtà le difficoltà dell'azienda erano già note da tempo, ma ciò non ha impedito ai suoi manager di destinarsi laute remunerazioni in azioni, che hanno avuto il loro peso sui conti del 2014, chiusi con una perdita netta di 578 milioni di dollari (ma anche con ricavi da 1,4 miliardi). Per uscire da questa spirale, Twitter ha bisogno di trovare un equilibrio fra due poli opposti: la necessità di riportare il numero degli utenti su una traiettoria di crescita - in modo da aumentare gli introiti pubblicitari - e la volontà di non snaturarsi, conservando quell'aura elitaria che lo distingue dagli altri social network.
Per uscire da questa spirale, Twitter ha bisogno di trovare un equilibrio fra due poli opposti: la necessità di riportare il numero degli utenti su una traiettoria di crescita - in modo da aumentare gli introiti pubblicitari - e la volontà di non snaturarsi, conservando quell'aura elitaria che lo distingue dagli altri social network.
Una strada praticabile è stata individuata nel fantomatico Project Lightning. Il nuovo servizio, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno, punta ad aiutare gli utenti a muoversi all'interno delle centinaia di notizie che compaiono ogni giorno sui loro profili. Twitter svolgerà un vero e proprio lavoro di selezione editoriale, con giornalisti che dovranno compilare liste tematiche scegliendo le notizie, le foto e i video giusti per guidare gli utenti nel caos degli eventi globali.
In questo modo si dovrebbe superare anche quello che secondo molti analisti è il principale freno all'ulteriore crescita di Twitter, ovvero la cesura fra gli utenti celebri, che vantano migliaia di followers, e i comuni mortali, incapaci di allestire una rete con molti collegamenti. I primi sono sempre più seguiti e animano le discussioni, mentre i secondi vengono spesso ignorati dalla massa. E cinguettare nel vuoto non fa piacere a nessuno.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Povertà estrema: combinazione di penuria di entrate, sviluppo umano insufficiente ed esclusione sociale. Così il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite definisce la condizione di individui a basso reddito per i quali è stata debole (quando non insufficiente) la rete di sicurezza sociale. Comunemente (e anacronisticamente) chiamati barboni, sono persone multiproblematiche, con un passato difficile, fatto di alienazione dal proprio contesto e, spesso, finite a dormire nelle stazioni ferroviarie per la natura neutrale di queste, di accoglienza anonima da un lato e di non fissità dall’altro.
Ma la reinterpretazione in termini di un nuovo potenziale di questo non luogo, basata sulla correlazione tra la dimensione della mobilità e quella del disagio, operata dagli Help Center, sportelli di orientamento sociale che nelle aree ferroviarie li prendono in carico e li avviano verso percorsi di recupero, ha offerto agli ‘utilizzatori’ più marginali delle stazioni, la possibilità di una seconda opportunità.
Undici mila e settecento metri quadrati in comodato d’uso gratuito da parte di FS Italiane a disposizione per andare incontro a chi chiede di ricominciare in una ‘nuova comunità’. Dal ricovero delle persone anziane malate e con problemi psichiatrici che, come si legge nel Research paper 2014 dell’Osservatorio Nazionale Disagio Sociale (ONDS), “da vent’anni continuava a dormire, mangiare e sopravvivere sotto la pensilina in testa al binario uno di Roma Termini dove parte il Freccia Rossa”, fino all’individuazione degli spazi e degli immobili dove accogliere centinaia di rifugiati politici: è il lavoro dei quindici Help Center da nord a sud dello Stivale.
Una nuova modalità di intervento sociale, essendo luoghi pubblici ad alta frequentazione e principale porta di accesso alla realtà urbana, rappresentano un ‘barometro sociale’ che, oltre a misurarli, anticipa anche il verificarsi di fenomeni che investiranno la nazione: è il caso delle nuove povertà e dei flussi migratori. Nel 2014 hanno accolto trentuno mila e settecentodue utenti, di cui diciassette mila e centottantaquattro al primo ingresso.
Sono soprattutto maschi, di un’età compresa tra i trenta e i trentanove anni, e tra i diciotto e i ventinove, riducendosi il numero di utenti più anziani. Gli italiani sono i più numerosi ma gli stranieri sono in crescita, soprattutto gli extracomunitari. Centodiciannove le nazionalità: rumeni, marocchini, tunisini, afghani, polacchi, nigeriani, peruviani, pakistani e ucraini. Sono in transito, verso un futuro migliore. Con un bagaglio di speranza e volontà, chiedono da mangiare, lavarsi e dormire. Ma solo per poco. E tra questi e i ‘veri’ senza dimora, italiani o stranieri che siano, si assiste a continui attriti: agli occhi di questi ultimi, i primi occupano uno spazio di cui si sentono in qualche modo proprietari.
E tra questi e i ‘veri’ senza dimora, italiani o stranieri che siano, si assiste a continui attriti: agli occhi di questi ultimi, i primi occupano uno spazio di cui si sentono in qualche modo proprietari.
Sebbene siano quasi tutti centri diurni a cui chiedono accoglienza e, solo più raramente, fanno richiesta di orientamento al lavoro e di segretariato sociale, per i senza dimora sono il loro punto di riferimento e la loro immagine di progettualità (che quelli in transito rifuggono e frustano).
Ricevono beni e supporto materiale, vestiti e medicinali. Seguono corsi di formazione, di informatica e di inglese. Di italiano per gli stranieri. Un nodo fondamentale, la formazione ma, prima di tutto, si deve costruire la fiducia nel rapporto con le persone che chiedono aiuto.
Da sapere: i clochard classici sono ormai una percentuale esigua e sono, invece, tantissime le persone che conservano un minimo di risorse, personali o familiari. Le loro storie seguono una trama comune: la perdita del lavoro, alla quale segue lo sfratto, la ricerca di una soluzione nel gioco, di sollievo nell’alcol, fino alla separazione e alla rottura dei legami che tengono lontani dalla strada.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
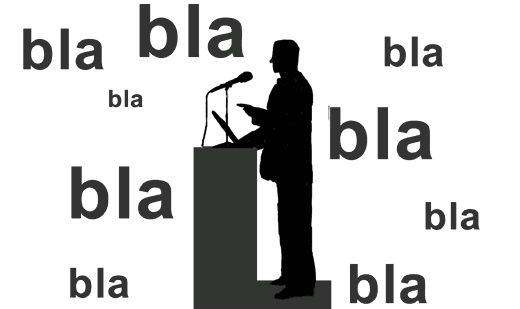 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Sessantacinque con poco più di milleottocento membri. Nati, benché presenti già negli anni cinquanta, fra il 2000 e il 2009, i think tank sono strutture politiche in cui trovano dimora le principali funzioni (un tempo) appartenenti ai partiti politici. Condividendo idee sulla cosa pubblica, i pensatoi si dividono in due categorie: per l’organizzazione di eventi e seminari e per la promozione di attività editoriali. Con due forme giuridiche: quarantotto fondazioni e diciassette associazioni.
Sebbene svolgano attività di stampo culturale, non si può ignorare la forte componente politica: la presenza di alcune figure ricorrenti e la palese interconnessione fra svariate strutture, il tipo di attività svolta e la composizione del management, oltreché la collocazione geografica (essendo ubicate le sedi principalmente a Roma, città dei palazzi del potere), rendono agevole la ricostruzione di un orientamento politico.
Premettendo, secondo quanto si legge nel minidossier di Openpolis ‘Cogito ergo sum’, che il 13,85 per cento dei pensatoi è di natura bipartisan che giustifica le buone intenzioni di condividere non tanto un’ideologia ma una comune battaglia su temi specifici, vedi di medicina o di difesa nazionale, per il resto, centrodestra e centrosinistra se li spartiscono. Giustificandoli con l’intento di fare ricerca, non sono, però, gli esponenti del mondo accademico a costituire la fetta più grossa: sono solo cinquecentocinquantaquattro versus cinquecentocinquantassette politici. Fra i restanti, imprenditori e manager, dirigenti pubblici, giornalisti, avvocati e pochi scrittori.
Con un’interconnessione fra le diverse strutture ‘parapolitiche’: il 66 per cento dei think tank ha almeno un membro in un altro pensatoio e venti persone compaiono in almeno tre. Quindi: duecentoquarantadue i collegamenti fra le organizzazioni, trecentosettantaquattro i membri condivisi. A destare attenzione, però, non è solo il dato numerico: esistono collegamenti rilevanti a livello qualitativo. Ossia, chi ha un incarico apicale in una struttura è molto probabile che ne avrà uno simile in altre.
Un vero e proprio network, con radici molto profonde: ogni pensatoio ha, in media, nove membri in altre strutture, collegandosi così, sempre in media, ad altre sei realtà. Tanto per avere un’idea: Italianieuropei è il think tank con più rappresentanti in altri pensatoi e la Fondazione Italia Usa è quella con più collegamenti con altre organizzazioni. Come mai? Perché le persone (con posizioni apicali in numerose realtà) che creano questi legami hanno incarichi di vario tipo: di management, di rappresentanza e di ricerca.
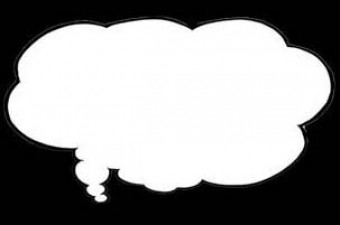 I collegamenti fra incarichi pubblici e think tank e il crescente ruolo politico di queste realtà - è innegabile che la principale forza propulsiva per la nascita della struttura e il più solido punto di riferimento sia, nella stragrande maggioranza dei casi, un politico -, è d’obbligo cercare di capire quale sia il loro peso economico.
I collegamenti fra incarichi pubblici e think tank e il crescente ruolo politico di queste realtà - è innegabile che la principale forza propulsiva per la nascita della struttura e il più solido punto di riferimento sia, nella stragrande maggioranza dei casi, un politico -, è d’obbligo cercare di capire quale sia il loro peso economico.
Con tutto il rispetto per la non trasparenza, considerato che non sono soggetti pubblici, i pochi elementi di bilancio rintracciabili sui siti internet, rendono complessa l’operazione. Si è comunque potuto scoprire che solo cinque organizzazioni hanno pubblicato una forma più o meno aggiornata del proprio bilancio. I più solerti e precisi, Symbola e Human Foundation, con i dati del 2014 del proprio budget. E Fondazione Open, l’unica ad aver reso noto, seppure con delle limitazioni, l’elenco dei suoi finanziatori con l’importo esatto donato. Urge una riflessione.
