- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Morire di fame: nel 2015, non è più la locuzione per indicare la povertà. Lo è maggiormente al passo coi tempi, vivere di stenti. Si, perché, stando ai dati riportati nel dossier Povertà plurali della Caritas, il disagio economico non può essere riconducibile solo alla carenza di alimenti tout court (sebbene l’Italia si collochi all’ottava posizione nella classifica europea e presenti valori percentuali sopra la media). Negli ultimi tre anni, infatti, non si registra un particolare aumento di richieste di viveri (anzi), bensì di aiuti economici.
E non si faccia ricorso (di default) alla congiuntura finanziaria negativa: la povertà, nel Belpaese, è una costante storica. Con tendenza alla cronicizzazione. Tant’è che, nell’ultimo decennio, ha subìto un vero e proprio processo di “normalizzazione sociale”. Un consolidamento del disagio, insomma, che è ancora più grave del disagio materiale.
Sebbene questo sia, ovviamente, l’ambito più problematico della deprivazione: dai bisogni occupazionali - scenario in cui si sconta sia la strutturale assenza di una misura universalistica di contrasto alla povertà sia il deficit contestuale della rete dei servizi sociali - ai disagi abitativi. Dai problemi familiari a quelli di salute; da quelli legati all’immigrazione a quelli connessi alla giustizia; da quelli relativi all’istruzione a quelli legati alla vulnerabilità delle dipendenze.
Oltreché vestiario e accesso alla mensa, coloro che necessitano d’aiuto chiedono sussidi economici da impiegare per il pagamento delle utenze, delle tasse, delle spese sanitarie e delle rate del mutuo. Per chi ancora ha una casa. Ma sono sempre più numerosi i nuclei famigliari che vivono una situazione di anomalia alloggiativa, con transitorietà residenziale e potenziale precarietà socio-relazionale. Soggetti a sfratto o a ipoteca. In alloggi spesso collocati in territori segnati da criminalità e degrado, da carenza di servizi e di collegamenti logistici. In abitazioni “strutturalmente danneggiate”, di “ridotte dimensioni” o poco luminose. Il 41,4 per cento delle persone che presentano un “mix di bisogni”, è di cittadinanza italiana, con un peso sempre più marcato nel corso degli anni, il 58 per cento straniera, principalmente romena e marocchina, presente soprattutto nel Settentrione e nel Centro.
Il 41,4 per cento delle persone che presentano un “mix di bisogni”, è di cittadinanza italiana, con un peso sempre più marcato nel corso degli anni, il 58 per cento straniera, principalmente romena e marocchina, presente soprattutto nel Settentrione e nel Centro.
Italiani mediamente meno giovani, over quarantaquattrenni, degli stranieri, fra i quali prevalgono gli under quarantacinque. Sposati e genitori, con in tasca una licenza media inferiore (fra gli stranieri è più alto il peso dei diplomati e dei laureati). E tantissimi disoccupati, pensionati e casalinghe, soprattutto del Mezzogiorno.
“Un Paese con una composizione demografica nella quale è rilevante la percentuale di anziani e una condizione giovanile problematica, insieme a forti diseguaglianze che concentrano le ricchezze solo su alcuni percentili di popolazione, la redistribuzione globale in atto, il rallentamento della crescita di alcune aree continentali e un’innovazione tecnologica che non produce occupazione” fa pensare a un contesto in cui la presenza della povertà e dell’esclusione sociale sarà un tratto di fondo dello scenario. Dicono gli esperti. Poveri di speranza.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Quasi ottomila persone in più mancano all’appello nei primi sei mesi di quest’anno. Quelle ancora da ritrovare, dal 1974, sono trentunomila e trecentosettantadue, delle quali poco più di tredicimila maggiorenni e diciottomila e duecentottantasette minorenni; milleduecentonovantotto over sessantacinque, centosettantasette gli italiani all’estero. Scomparsi.
Nella maggior parte dei casi volontariamente. Il dato deve contestualizzarsi, sul piano socio-economico, nell’ambito della forte crisi finanziaria che, dal 2007 a oggi, sta interessando tutta l’Europa.
E’ vero che le scomparse si sono (successivamente) rivelate fughe dai creditori e dal disagio economico. Ma è altrettanto dimostrabile che è il frutto (in Italia, senza ombra di dubbio) di una profonda decadenza della “costellazione valoriale”.
Ovvero, la crisi della coesione sociale, la crescente rilevanza dei localismi, la difficoltà delle istituzioni di garantire una rete (oltreché una copertura economica) e la protezione sociale delle famiglie, stanno influenzando i comportamenti delle persone. Come dire che la crisi economica slatentizzi una “crisi del rapporto con l’altro, del desiderio”, della resistenza e della resilienza. Chiamando in causa non più e non solo aspetti sociologici ed economici ma, chiaramente, psicoanalitici.
Perché a parte i casi che riguardano la maggior parte degli ultrasessantenni, spesso affetti da disturbi neurodegenerativi, le persone che scompaiono sono soggetti indubbiamente vulnerabili. Che rispondono con la fuga alla pressione insopportabile o a crimini odiosi. Vedi il femminicidio. Sono infatti duecentottantadue, delle quali duecentoquarantaquattro rintracciate, le donne scomparse, dal 1974 a oggi, in seguito a questo tipo di reato.
Cinquemila e trecentosessantaquattro sono quelle delle quali non si hanno più notizie, nel 2014: più di mille quelle ancora da ritrovare, di cui cinquecentoventisette minori straniere, allontanatesi dai centri di accoglienza o dalle case famiglia. Sparite insieme a circa diciottomila altri minorenni, della fascia d’età fra i quindici e i diciassette anni. Per le suddette ragioni o per sottrazione da parte di uno dei due genitori, e non solo. Sperando che a queste non si aggiunga la scomparsa derivante da Gameof72, un gioco (?) su facebook che, partito dalla Francia, sta spopolando in tutta Europa: gli adolescenti si sfidano a vicenda a sparire, senza lasciare alcuna traccia e senza poter comunicare con nessuno, per un lasso di tempo che arriva fino a settantadue ore.
Per le suddette ragioni o per sottrazione da parte di uno dei due genitori, e non solo. Sperando che a queste non si aggiunga la scomparsa derivante da Gameof72, un gioco (?) su facebook che, partito dalla Francia, sta spopolando in tutta Europa: gli adolescenti si sfidano a vicenda a sparire, senza lasciare alcuna traccia e senza poter comunicare con nessuno, per un lasso di tempo che arriva fino a settantadue ore.
Altro capitolo rilevante, i cadaveri non identificati: millequattrocentoventuno – trentasei in più nell’ultimo semestre - dei quali settecentossessanta sono corpi di migranti recuperati sulle coste italiane. Il diritto ad avere un nome può, oltre che restituire dignità alle vittime, essere un tassello nella lotta per tutti i diritti umani. Così dice la XIII Relazione 2015 del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
Il tema delle unioni civili e’ in agenda da tempo. In agenda, ma non nel programma recita come in una litania il Ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi. Sa troppo di passato per un turbo governo che tiene a mostrare gli attributi della velocità e della freschezza giovanile e che sul testo Cirinnà é costretto alla liturgia della prima Repubblica, nel non avere tempi chiari da poter pubblicizzare agli elettori per l’approvazione dell’ atteso DDL.
Alla festa dell’IDV di Firenze la Ministra, invocando questioni di civiltà e diritto, dichiara possibilità di apertura verso altre forze politiche, qualora sulle Unioni Civili il Nuovo Centro Destra tradisse il patto di maggioranza. Ma Pier Ferdinando Casini da Palazzo Madama é già pronto a invocare il dogma della coscienza personale per sgombrare il campo dalle interpretazioni.
A ruota la replica di Alfano che annuncia barricate in aula per non far passare l’adozione di bambini da parte delle coppie gay. Per essere precisi e per non cadere nella solita confusione dei dibattiti politici televisivi si sta parlando della stepchild adoption, vale a dire della possibilità da parte di uno dei partner della coppia omosessuale di adottare i figli dell’altro o dell’altra. Una possibilità normativa finora inesistente, che consentirebbe di tutelare minori che ad oggi vivono già questa condizione senza però disporre di alcuna tutela legislativa.
E’ sempre sui temi etico-morali, quelli che non ammettono scantonamenti facili, che i governi posticci all’italiana mostrano le proprie crepe. E questo perché nel contesto socio-politico non si è ancora giunti ad una maturità e ad una coscienza critica che faccia della collettività e non del supremo valore di coscienza dei singoli, il lume della ragione politica.
La triade Boschi, Zanda (capogruppo PD) e Schifani (Ncd) é ferma e tutto quel che ha prodotto é un ennesimo slittamento sine die. Per la prima volta il premier Renzi a questa frenata, cosi omogenea al passato, decide di starci senza lanciare scomuniche politiche o rivendicare atti di forza e di rottura per dare modernità e slancio al nostro Paese.
Una novità che non sorprende. Una incoerenza di metodo che tradisce le corvee che Matteo Renzi deve onorare al mondo cattolico da cui viene e che fin li lo ha portato senza alcuna investitura elettorale. Una questione di numeri e di fatti contro cui poco può opporre la “retorica del fare”. Il governo é anche arte di mediazione, certamente. Ma suona male e suona vecchia questa resa all’etica da un governo che si presenta come macchina della modernità. Dove il diritto e i diritti diventano finalmente il centro della politica.
Il governo é anche arte di mediazione, certamente. Ma suona male e suona vecchia questa resa all’etica da un governo che si presenta come macchina della modernità. Dove il diritto e i diritti diventano finalmente il centro della politica.
E’ questo il bollino di civiltà che ci renderebbe moderni e pienamente europei. Cosi, tanto per ricordarci che é il Parlamento Europeo a chiederci di adeguare le nostre leggi. Di non lasciare vuoti normativi che pagano nella vita di ogni giorno cittadini di fatto discriminati.
Sarebbe interessante capire dal premier delle sfide e del coraggio quanto ancora, sui diritti civili, rimarremo in buona compagnia della Grecia, di Cipro e di alcuni paesi dell’Est Europa. Se insomma sia solo la riforma del Senato il paradigma della modernità.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
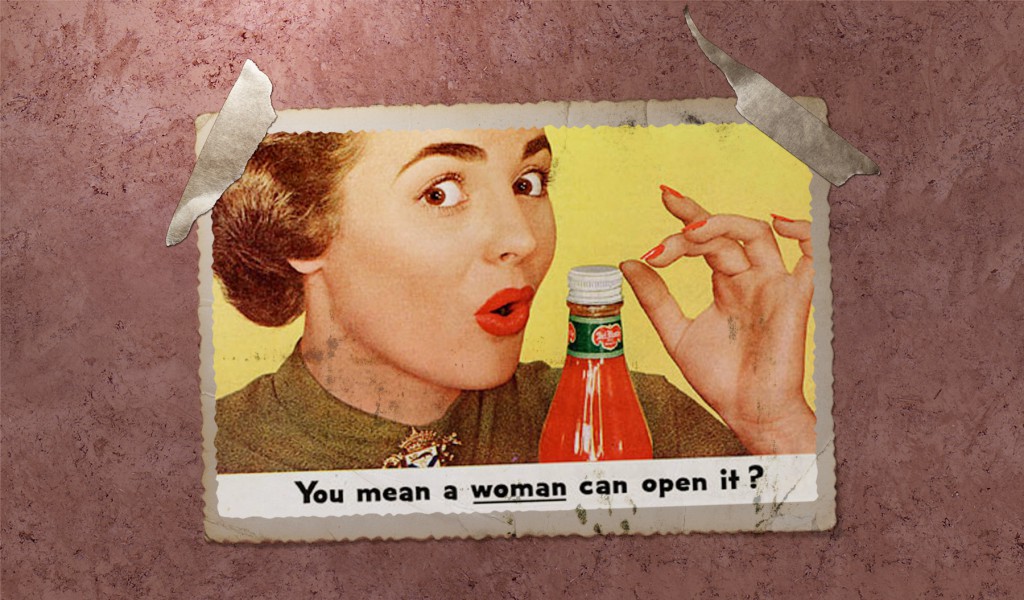 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Uno dei pochi indicatori in crescita nel Belpaese? La violenza sui minori, soprattutto sulle bambine e sulle adolescenti. Dalle tremila e trecento violenze del 2004 alle cinquemila e trecento, dieci anni dopo. In questo modo: i casi di omicidio volontario sono passati da ventisette a trentaquattro; quelli di “abuso dei mezzi di correzione o disciplina” dai centoventinove ai duecentottantonove; quelli di abbandono dei minori da duecentotrentaquattro a quattrocentoquattro.
E ancora: gli atti sessuali con minorenni, sono passati dai trecentosessantaquattro a quattrocentotrentotto; quelli di violenza sessuale aggravata da duecentosessantadue a trecentosettantuno; quelli legati a materiale pedopornografico con settanta bambine coinvolte nel 2014 e tredici dieci anni addietro; e da settecentocinquantuno a millequattrocento e rotti, i maltrattamenti in famiglia.
Che è il contesto più pericoloso. Non solo perché è quello in cui si consuma ogni tipo di violenza più che altrove. Ma anche perché è lì che si muovono i primi passi del pensiero. E di un sentire comune. Che, ancora oggi, nelle nuove generazioni ha il suono (rumore) di stereotipo. Donna uguale madre, oggetto sessuale o femme fatale, quando non è stupida, isterica, distratta. Sottomessa all’uomo pater familias, e inserita nel mondo del lavoro a discapito del suo ruolo di madre. Un’idea che rimanda a una condizione di subalternità, con ricadute nella violenza fisica e psichica, in linea con una visione di essere (umano) senza identità.
E sebbene le evidenze dei dati riferiscano della violenza come di un fenomeno trasversale, gli adolescenti intervistati da Terres des hommes, che ha condotto la ricerca nelle scuole italiane su un campione di milleseicento ragazzi e ragazze dai quattordici ai diciannove anni, sembrano sottostimarlo. O, nella migliore delle ipotesi, ridurlo a un fatto privato. Che riguarda poche famiglie “senza educazione e molto povere”. O riconducibile a una manciata di uomini “vittime di una momentanea perdita di controllo”. Dando alla violenza, una connotazione socio-economica. E poco, troppo poco, psichica.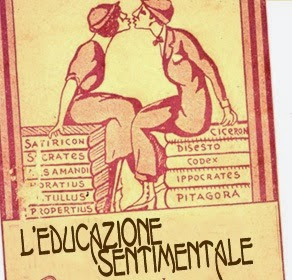 Emerge, con amarezza, che i ragazzi non sono ancora (?) pronti a una reale uguaglianza di genere. Anche perché ammettono di avere la consapevolezza di essere immersi in un sistema che tende a “rinforzare gli stereotipi e la violenza di genere”, frutto dell’anacronistica cultura della "costola dell’uomo".
Emerge, con amarezza, che i ragazzi non sono ancora (?) pronti a una reale uguaglianza di genere. Anche perché ammettono di avere la consapevolezza di essere immersi in un sistema che tende a “rinforzare gli stereotipi e la violenza di genere”, frutto dell’anacronistica cultura della "costola dell’uomo".
E però, chiedono di essere aiutati a superarla. Sia con l’introduzione di “ore di educazione per la prevenzione della violenza sulle donne e per il rispetto dell’identità di genere”, sia con l’inserimento di Internet a scuola come “strumento di apprendimento” e come “oggetto di insegnamento”.
Una richiesta conseguente all’esperienza di sexting. Che vorrebbero fare in libertà, pensando di essere in grado di “proteggere la propria privacy” o fidandosi ciecamente della rete, ma di fronte alla quale inorridiscono quando vedono “le proprie immagini a sfondo sessuale circolare, senza il proprio consenso, on line o sui cellulari altrui”: la sentono “grave quanto subire una violenza fisica”.
In un’Italia che reagisce e si oppone (chapeau), con mozioni parlamentari - ultima quella contro i matrimoni forzati e precoci - e attraverso campagne contro le mutilazioni genitali femminili, quello che deve cambiare radicalmente è il pensiero comune. Troppo comune.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Tutti alla ricerca di un’identità. Di migliori e più umane condizioni di vita e di lavoro. Da un’Italia che, da sempre, è terra di saluti e di accoglienza, di ritorni e di addii. Ma, sempre, per i quattro milioni e seicentotrentasei e rotti cittadini italiani residenti all’estero, con la memoria nella valigia, come elemento portante, legame forte del divenire, nella certezza che conoscere la propria storia serva a capire il presente.
Di emigrazione, caratterizzato, nell’ultimo decennio, da una serie di fattori e situazioni nazionali e internazionali che hanno condotto a un profondo cambiamento nelle caratteristiche della mobilità in generale, e di quella del nostro Paese, in particolare.
Affetto da schizofrenia: che, da una parte, si è sempre più confermato quale meta strutturale per tanti immigrati, mentre, dall’altra, in una delle più lunghe recessioni economiche e occupazionali della storia, vede giovani, famiglie e anche anziani, partire. Storicamente dalle regioni del Sud, ma, attualmente, anche dal Nord: pur restando la Sicilia, la prima regione di origine degli italiani all’estero, seguita dalla Campania, dal Lazio e dalla Calabria, il confronto con i dati delle precedenti edizioni del Rapporto Italiani nel mondo, redatto da Migrantes, pone in evidenza una marcata dinamicità delle regioni settentrionali, specialmente della Lombardia e del Veneto.
Verso l’America e l’Europa. Meta preferita dai Millennials, già a partire dagli studi universitari, intesa come luogo di scambio, in cui hanno la possibilità di mettersi alla prova e di spendere le proprie competenze. Sono ‘migranti’ istruiti, i più istruiti dal Secondo dopoguerra a oggi, ma anche i più penalizzati. Bravi ma senza prospettive nel loro Paese natìo.
Nel quale, qualora facesse capolino l’opportunità di una buona e concreta occasione lavorativa, tornerebbero: sono gli Expat. Giovani in movimento della stessa generazione dei Millennials, promotori di innovazione sociale, pronti a frasi apprezzare nelle aziende estere o intenzionati a dare vita a una attività propria. Che vivono l’emigrazione come una possibilità, una carta da spendere. E sebbene la partenza li investa di un bagaglio di nostalgia, resistono e desistono dal tornare a casa.
 E cosi vanno a ingrossare le file degli emigrati italiani che hanno contribuito con le loro conoscenze, la loro destrezza, la genialità e il talento a rendere migliori diversi luoghi del mondo. E che, nonostante il momento poco propizio per il Belpaese, sono esempio di dedizione, sacrificio, professionalità e ingegno.
E cosi vanno a ingrossare le file degli emigrati italiani che hanno contribuito con le loro conoscenze, la loro destrezza, la genialità e il talento a rendere migliori diversi luoghi del mondo. E che, nonostante il momento poco propizio per il Belpaese, sono esempio di dedizione, sacrificio, professionalità e ingegno.
Dai vecchi mestieri che hanno esportato all’estero - tipo il minatore, lo spazzacamino, il barbiere, il viticoltore, il ramaio della Valle del Noce, il vetraio di Altare, il gelatiere, il ristoratore, il suonatore d’arpa o il riquadratore di Sala, fino ad arrivare all’attualissimo calciatore - arriverà un giorno in cui la decisione di partire deriverà totalmente da una scelta e non da un obbligo?
