- Dettagli
- Scritto da Administrator
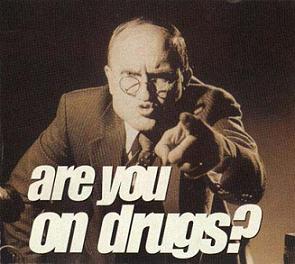 di Rosa Ana de Santis
di Rosa Ana de Santis
La relazione annuale presentata dal Sottosegretario Giovanardi a Palazzo Chigi, in conferenza stampa, parla chiaro. Dal 2008 al 2009, il numero dei consumatori di droghe è sceso drasticamente, del 25,7%. Da 4 milioni del 2008 ai 2.924.500 del 2009. Una matematica che renderebbe gli onori al Dipartimento Antidroga e al neuroscenziato che lo guida, Giovanni Serpelloni, e che soprattutto giustificherebbe sempre meglio la poltrona del riciclatissimo Giovanardi.
Le cause di questo calo, il cui calcolo matematico sembra quanto meno azzardato, starebbero nella politica di prevenzione, nella diffusione dei drugtest ai lavoratori (non ai parlamentari per carità), e nella crisi economica generale. Ma è proprio questo picco verso il basso che non sembra corrispondere ai dati reali, all’esperienza e alle testimonianze delle comunità e dei Sert.
Non a caso si è levata da più parti la richiesta di conoscere il metodo d’indagine e di rilevamento statistico con i quali il rapporto è stato confezionato. Anche perché, una percentuale così significativa, o sfida le leggi elementari della statistica oppure ci dice che un’intera popolazione era tossicodipendente. Vengono in mente i sondaggi di Pilo sugli esordi del premier. Ma come fanno i calcoli nelle stanze del Sottosegretario?
Eroina, cannabis e cocaina si dividono il podio delle droghe e il governo sembra aver fatto, per l’ennesima volta, una scelta di mera propaganda, con un plus di cinismo per l’occasione. Intanto la crisi economica non ha eliminato le droghe, ma ha semplicemente spostato i consumatori abituali verso il più economico alcool. Una peste che colpisce sempre di più i giovanissimi e le ragazze adolescenti in numero crescente. Quasi sempre ragazze con disturbi alimentari che utilizzano l’after hour per sballare senza cibo e a pochi euro.
Una cosa che sembra non occupare troppo i pensieri di Giovanardi che, da sempre, segue ossessivamente chimica e effetti neuronali degli spinelli. E’ noto. Bisognerebbe, inoltre, rammentare al Sottosegretario che non è mai la ragione dei soldi a spegnere una dipendenza. L’esperienza del tabacco e delle sigarette e dei ripetuti aumenti di Stato lo dimostra da tempo. Potremmo pensare a qualche buono psicologo da inserire nello staff del Dipartimento.
Come non parlare poi delle comunità che, dopo i tagli del governo, sono in pratica sul lastrico. Deve essere lo stesso metodo che porta il governo a sbandierare la sicurezza mentre toglie i finanziamenti ai poliziotti. Un vizio riconoscibile e mirabilmente mistificato.
A dire la verità, un risultato concreto Giovanardi lo ha portato nel mondo della droga. Ha abbassato la dose personale, alterando il discrimine tra consumo personale e spaccio e ha reso punibile penalmente quel ragazzo che portasse in tasca 5 grammi di hashish al pari di uno spacciatore vero. Inoltre, portando la soglia della cocaina a 1,6 grammi (una quantità ben più alta di quella che si spaccia abitualmente), una droga che a Giovanardi fa meno paura delle “canne”, finisce per trattare lo spacciatore che si mette in tasca pochi euro di spinelli con quello che guadagna 500/600 euro dalla coca. Un’equazione stupida, quanto pericolosa, che riempie le carceri di niente.
 Forse perché nel mondo di Giovanardi il cocainomane, vestito da ricco, che fa affari dal lunedi al venerdi, che frequenta locali e circoli di lusso e che ipocritamente nasconde il vizietto, è socialmente più accettabile del ragazzo che frequenta i centri sociali e che non nasconde di farsi uno spinello ogni tanto. E’ questo il messaggio che avrebbe dovuto dare in conferenza stampa. L’unico che arriva chiaro dalla comunicazione del sottosegretario.
Forse perché nel mondo di Giovanardi il cocainomane, vestito da ricco, che fa affari dal lunedi al venerdi, che frequenta locali e circoli di lusso e che ipocritamente nasconde il vizietto, è socialmente più accettabile del ragazzo che frequenta i centri sociali e che non nasconde di farsi uno spinello ogni tanto. E’ questo il messaggio che avrebbe dovuto dare in conferenza stampa. L’unico che arriva chiaro dalla comunicazione del sottosegretario.
Anche se i numeri fossero attendibili, la spiegazione della crisi economica basta da sola a suscitare ilarità e ad essere una confessione spassionata della propria nullità politica. L’opposizione e i radicali in testa chiedono chiarimenti sull’origine dei dati. Ministeri, Istat, Centri di Ricerca indipendenti è la risposta di Giovanardi. A noi basterebbe il mondo delle comunità di recupero e la voce delle persone che lavorano seriamente con il disagio giovanile a rendere ridicolo l’incubo ricorrente di Giovanardi sullo spinello e ad offrirci un quadro ben più serio sui nuovi riti dello sballo e sulle età sempre più basse di iniziazione.
Strano il mondo del sottosegretario Giovanardi. Dove un tossicodipendente diventa, di fatto, un detenuto; dove Morgan ha il potere si scatenare campagne politiche ma dove un ragazzo sorpreso con uno spinello di troppo rischia il carcere. Un mondo, per chi non lo ricordasse, dove Giovanardi potè affermare che Stefano Cucchi è morto per anoressia e per droga. Non di botte e di abbandono terapeutico.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana de Santis
di Rosa Ana de Santis
La battaglia legale è stata intrapresa dal giudice della Corte Federale Distrettuale di New York, Robert W. Sweet, e la sua sentenza invalida sette brevetti relativi ai geni BRCA1 e BRCA2, responsabili di un’ altissima predisposizione al cancro del seno, delle ovaie e di altre neoplasie. Se la sentenza venisse accolta e confermata, il business sul genoma, che ha finora riempito le casse di Myriad Genetics, la società che possiede i brevetti, crollerebbe d’un colpo.
Ma la vera portata rivoluzionaria della sentenza non è solo questa. Per la prima volta, proprio nella terra che fa affari sulla salute delle persone, verrebbe ufficializzato uno stop invalicabile a tutela dell’identità genetica. Non si potrebbe fare più speculazione sulla mappatura del genoma e questo, oltre a dare maggiori garanzie ai pazienti, non soffocherebbe la ricerca scientifica come invece sta accadendo.
L'American Civil Liberties Union, la Public Patent Foundation e un gruppo di pazienti, portatori delle mutazioni genetiche a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, hanno iniziato da tempo a mettere in discussione l’idea che il dna e quindi la natura umana - questo il passaggio argomentativo fondamentale della sentenza - potesse essere trattata come prodotto commerciale da brevettare e vendere.
La difesa della società dei brevetti - Myriad - poggia invece sulla tesi seconda la quale per isolare i geni dal corpo è necessaria una procedura tecnica e artificiale che mette le condizioni affinché il dna ottenuto non sia equiparabile al corpo e all’organismo vivente così come si presenta in normali condizioni naturali.
Un artificio legale che ora sembra scricchiolare sempre di più. “Un trucco” come lo definisce il giudice Sweet nella sua lunga sentenza, che ha fatto perdere di vista finora che quale che fosse l’intervento tecnico messo in campo dai ricercatori, il dna fosse natura e identità naturale di ogni individuo e che, esattamente al pari di ogni parte del corpo, non potesse essere trattato al pari di un prodotto commerciale.
Forse lo stesso buon senso che ci porta a considerare turpe sul piano dei sentimenti morali vendere una parte del corpo per trarne guadagno. Sbagliato per chi lo fa e per chi ne beneficia. Ma nel caso dei geni c’è qualcosa di più grave e di più insidioso. Intanto il dato evidente è che i brevetti vedono i pazienti vittime e non attori di questa commercializzazione della natura, obbligandoli a un test costoso, che rimane precluso quindi a molti e che crea per questo iniquità sul piano della prevenzione e delle terapie sperimentali. Non da ultimo il brevetto sancisce un controllo del dna e un’occasione dorata di affari che rende indisturbata e clandestina qualsiasi manipolazione e decisione che vada dall’ingegneria genetica, alla medicina alla farmacologia. E magari qualsiasi interruzione di ricerca.
Il 20% dei geni, dagli anni Ottanta ad oggi, è stato brevettato. Pochi passi di correzione genetica sono stati fatti, mentre - guarda caso - sui test genetici predittivi sono nate industrie miliardarie. Molti ricercatori dell'Università dello Utah, che detiene i brevetti insieme alla Myriad Genetics, vedono in questa sentenza la più corretta interpretazione del loro lavoro e della conoscenza genetica.
I brevetti sui geni impongono, legge alla mano, a tutti i paesi e a tutti gli scienziati che volessero fare ricerca di pagare lautamente la Myriad Genetics che considera il BRCA1 e il BRCA2 proprietà privata a tutti gli effetti. L’Europa ha sfidato questo limite a partire dal 2004 revocando il brevetto dal momento che nessun servizio sanitario europeo aveva pagato alcunché alla Myriad.
Il Parlamento Europeo è schierato contro la società statunitense ma la questione è ancora sospesa e la sentenza attesa su brevetti sanerà questo limbo in modo definitivo. In prima linea in questa battaglia ci sono l’Istituto parigino Curie e il servizio sanitario francese. L’Europa può vantare di aver scoperto altre mutazioni patologiche sugli alleli dei geni incriminati, ma non per questo ritiene di doverne cedere di diritto la proprietà intellettuale alla Myriad.
In Italia e in tutti i Paesi Europei i test genetici si fanno, e sempre di più, in centri oncologici altamente specializzati. Ma in punta di diritto possiamo affermare che il tutto avviene nell’illegalità. Dovrebbero, infatti, essere pagate somme salatissime alla Myriad Genetics. Quelle che con buona probabilità pochissimi centri sanitari e ancor meno pazienti potrebbero permettersi. Quanto costa questo brevetto in termini di vita è facilmente immaginabile. Solo i più ricchi potrebbero avvalersi di protocolli sperimentali di difesa per il cancro in agguato. Un’idea che desta poco scandalo in un paese come gli USA, dove si cura solo con la carta di credito in vista, ma non appartiene alla civiltà del Vecchio Continente.
Per questo il Parlamento Europeo è insorto e appoggia questa importante battaglia intrapresa dal giudice Sweet. In ballo c’è il futuro di tantissimi giovani, delle future generazioni e dei nuovi nati e soprattutto una lezione di civiltà. Se il dna avrà un padrone, su tutti ci sarà un indiscriminato potere di vita e di morte. Non più scritto nel fato, nella casualità di natura o nel patrimonio della scienza, ma nelle stanze di qualche famelica multinazionale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Valerio Di Stefano
di Valerio Di Stefano
L'entusiasmo seguìto all'istituzione delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) per i cittadini, dopo l'annuncio trionfalistico del Ministro Brunetta e gli immancabili “disguidi tecnici”, dovuti a fantomatiche e non ben meglio precisate richieste di accesso in quantitativi massicci, pare essersi spento dopo la fiammata iniziale, rivelando una serie di contraddizioni e inefficienze che non fanno altro che ampliare il divario tecnologico e dei diritti del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La Posta Elettronica Certificata, in realtà, è da anni ampiamente disponibile, in forma capillare, ai cittadini, sia pure a pagamento. Non costituisce, dunque, di per sé, una novità. Probabilmente il “nuovo” ostentato era la gratuità della risorsa per il cittadino. Ma anche quest’aspetto si sgretola al confronto coi fatti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini", in vigore dal 6 maggio 2009, prevede che ogni cittadino che lo desideri e ne faccia richiesta possa ottenere una casella di posta elettronica certificata gratuita e senza oneri (art. 2).
Del resto, non poche perplessità aveva destato il comma 4 dell'articolo 3 dello stesso testo, che prevedeva letteralmente: “La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano” .
Dunque, con la richiesta della assegnazione di una casella di posta elettronica certificata il cittadino non solo dimostrava di volersi dotare di uno strumento, ma accettava anche che tutto ciò che veniva inviato dalla Pubblica Amministrazione rivestisse carattere di ufficialità (una comunicazione da una casella di PEC a un'altra, come è noto, ha il valore legale della classica raccomandata con ricevuta di ritorno). Con l'aggravante (naturalmente a carico del cittadino), che i documenti inviati alla Pubblica Amministrazione richiedono spesso la firma digitale, di cui nella quasi totalità dei casi il cittadino è sprovvisto, per poter dimostrare l'identità di chi formula una determinata richiesta o fornisce un determinato documento.
In breve, anche se il cittadino usa la PEC per rivolgersi al proprio Comune per richiedere un intervento dei Vigili Urbani, qualunque altra Pubblica Amministrazione diversa dal suo comune può notificargli qualunque documento via PEC (ad esempio, un atto giudiziario, una comunicazione da parte del fisco e quant'altro). Tutto questo in nome di una supposta trasparenza e abbattimento di costi e tempi di gestione a beneficio di tutti.
Il risparmio sui costi, appare evidente, è tutto a beneficio della Pubblica Ammistrazione che, già dal 2009, con l'introduzione della legge n. 2, deve comunicare con i suoi dipendenti attraverso la PEC. Il che non significa solo che il dipendente del Comune di Vibo Valentia possa e debba ricevere qualsiasi comunicazione dal suo ente di servizio nella casella PEC di Stato, ma anche - e soprattutto - che se lo stesso dipendente di Vibo Valentia dovesse incorrere in una contravvenzione del Codice della Strada nel territorio del Comune di Orgosolo, il Comune di Orgosolo è tenuto a notificargliela via PEC.
Ed è qui che il sistema comincia ad andare in tilt: nella Pubblica Amministrazione manca personale, risorse e know-how per gestire il baraccone inutile che il Ministro Brunetta ha costruito su un sistema di comunicazione indubbiamente utile (anche se costituisce un'anomalia del tutto italiana). Non si tratta di ripetere che basta una casella di posta elettronica tradizionale, come succede in qualsiasi altro Paese dell'Unione, perché è evidente che la necessità di certificare il messaggio e il mittente sono sacrosante; si tratta di rendere effettivamente chiaro e trasparente il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione che, in questo momento, appare assolutamente squilibrato a favore di quest'ultima.
Perché se il settore pubblico può interfacciarsi con il cittadino, non sempre (anzi, quasi mai) è vero il contrario. L'art. 34 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, aggiungendo il comma 2-ter all'art. 54 del D. Lgs. n. 82/20905 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, che dispongono di propri siti, sono tenute entro il 30 giugno 2009 a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito web un indirizzo di posta elettronica certificata, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta che riguardi il codice digitale della pubblica amministrazione.
 A quasi un anno dall'entrata in vigore di quel provvedimento si continua ad assistere a una vera e propria diserzione da parte degli Enti Pubblici all'obbligo previsto. Comuni, Scuole, Istituzioni Pubbliche, Università, Ministeri, Tribunali, Uffici che dispongono di un sito web, difficilmente forniscono la loro casella di posta elettronica certificata, che il cittadino deve andarsi a cercare, se esiste, su altre risorse (www.indicepa.gov.it).
A quasi un anno dall'entrata in vigore di quel provvedimento si continua ad assistere a una vera e propria diserzione da parte degli Enti Pubblici all'obbligo previsto. Comuni, Scuole, Istituzioni Pubbliche, Università, Ministeri, Tribunali, Uffici che dispongono di un sito web, difficilmente forniscono la loro casella di posta elettronica certificata, che il cittadino deve andarsi a cercare, se esiste, su altre risorse (www.indicepa.gov.it).
Un caso eclatante, in questo senso, è quello del sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (www.istruzione.it) che continua gelminianamente a fornire un indirizzo di posta elettronica tradizionale per i contatti con il pubblico senza dare nessuna garanzia che i messaggi siano stati effettivamente ricevuti.
Il collasso finale del sistema si verifica alcuni giorni fa, quando, tra l'indifferenza della stampa e dei mezzi di informazione, lo stesso Ministero dell'Economia blocca alcune disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione digitale, tra cui gli articoli 10 e 20 bis. Secondo il Ministero, l'assegnazione di un recapito di Posta Elettronica Certificata ad ogni cittadino per i contatti con l'Amministrazione Pubblica, avrebbe un significativo impatto sull'organizzazione delle Amministrazioni stesse.
In parole povere, il cittadino avrebbe tra le mani un'arma che la P.A. non sarebbe minimamente in grado di gestire (ogni Amministrazione avrebbe l'obbligo di protocollare qualsiasi comunicazione). Basti solo pensare alla paralisi che si avrebbe se ogni impiegato comunicasse, come sarebbe suo diritto, la propria condizione di malattia. Potrebbe farlo in qualunque ora (comprese quelle notturne), avrebbe un’immediata ricevuta della propria mail valida a tutti gli effetti legali e non avrebbe nessun altro obbligo, se non quello di recapitare successivamente la certificazione medica.
Se il personale addetto alla segreteria non controlla la PEC perché l'ufficio apre solo pochi minuti prima del turno del dipendente, o perché - si veda il caso - non è capace di gestire il sistema, tutto crolla miserevolmente: il dipendente risulta assente, lo si chiama a casa con ulteriore aggravio di costi per accertarsi che sì, aveva dato regolare comunicazione, ma spesso non si è in grado di sostituirlo (si prenda in considerazione l'assenza di un insegnante in una scuola).
Dulcis in fundo, l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di comunicare tra loro con la PEC, prevedere “ulteriori oneri finanziari e organizzativi“, per cui le pubbliche amministrazioni potranno continuare a comunicare tra di loro tramite telefono, raccomandata tradizionale, posta e fax a spese dei cittadini, in uno sperpero di denaro pubblico che ha come unica giustificazione l'incapacità di interfacciarsi con la tecnologia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
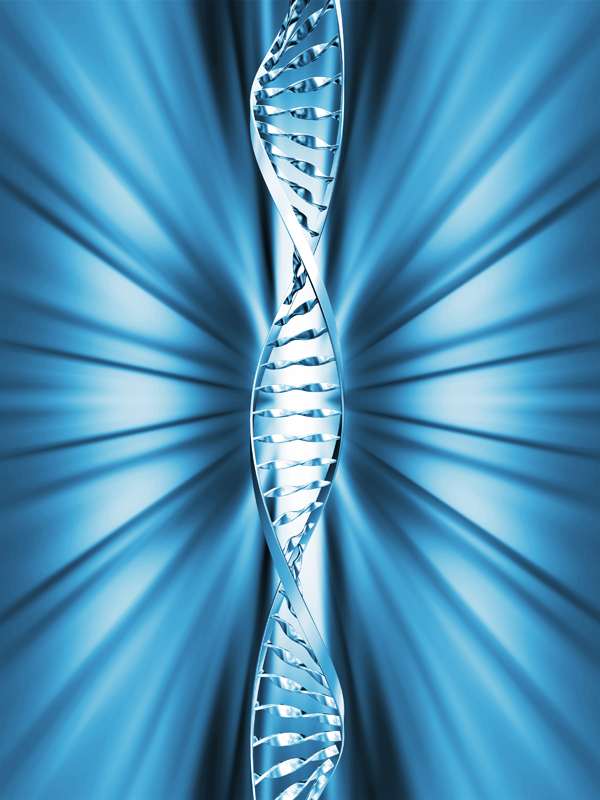 di Rosa Ana de Santis
di Rosa Ana de Santis
Il 16 maggio é dedicato ai malati di cancro. Una giornata per parlare di loro e di una malattia che non molti anni fa era innominabile, infarcita di una mistica del male e di un simbolismo che parlava solo di morte, quasi allegoria di una colpa e di una condanna senza scampo. Le storie dei pazienti raccontano invece non di un’esistenza interrotta, ma di una vita capovolta e mutata in profondità.
La malattia oncologica, proprio per la modalità della sorveglianza, per l’incertezza della prognosi e per la variabile altissima della risposta individuale alle terapie, richiede uno sforzo di convivenza con la malattia che può anche durare anni e che può trasformare la patologia clinica, anche quando fosse scomparsa dal corpo, in una condizione dell’animo e in uno stato mentale. Il cancro come un virus dei pensieri, perché è l’incontro eccellente, senza mediazioni e diplomazie, con le domande fondamentali della vita.
La sensazione di precarietà esistenziale che scatena la diagnosi diventa spesso l’origine però di una nuova disponibilità alla vita in cui l’interiorità, le relazioni e i sentimenti diventano la finalità del quotidiano, i primi strumenti di guarigione e gli ingredienti fondamentali del futuro. I percorsi, com’è ovvio, sono diversi. I numeri dello studio realizzato dall'Associazione di volontariato Aiscup-Onlus, dall’Idi-Irccs di Roma e dall'Ospedale Sant'Andrea, dicono che il 54% dei malati di cancro ritiene molto importante la spiritualità nella propria vita. Dove spiritualità non è necessariamente religione o fede confessionale, ma cura di sé, forza della mente, interiorità. La problematizzazione psico-emotiva della nuova condizione di vita, diventa strumento per sopportare meglio la sofferenza e per rivendicare la dignità della malattia.
Il rifiuto dell’estraniazione dalla società e l’ostinazione a recuperare canoni normali di vita hanno bisogno - indica il risultato dello studio - di questo motore spirituale. Lo studio ha riguardato 220 pazienti chemioterapici dell’Idi. Più donne che uomini e molte di loro giovani. La maggior parte ha dichiarato di desiderare una vita serena, una ridotta percentuale ha elaborato un rifiuto della fede e molti di questi pazienti si definivano già credenti prima della malattia. Lo studio ora si spingerà ad analizzare il rapporto tra malattia e spiritualità in paesi caratterizzati da una cultura religiosa che non sia cristiana e sarà esportato ai centri oncologici di Gerusalemme e di Teheran.
Spiritualità nella malattia non significa preghiere: vuol dire piuttosto mettere al centro l’umanizzazione delle cure, l’integrazione tra medicina e psicologia al fianco del paziente e l’attenzione continua alla non esclusione della persona ammalata nel sistema sociale e nel mondo del lavoro. Solo tutti questi elementi aiutano il paziente a elaborare la malattia come un passaggio, una battaglia da vincere, una condizione in cui non si aggiunga all’invalidità fisica la depressione di un’esclusione sociale.
I diritti sul posto di lavoro, lo snellimento della macchina burocratica in cui s’imbatte un paziente quando entra in ospedale, la creazione di corsie di prenotazioni preferenziali, l’esenzione e il riconoscimento dell’invalidità, è tutto quello che la politica deve fare per queste persone. Il cancro è una malattia sempre più diffusa nelle società occidentali, per longevità della popolazione, per diffusione di dannosi stili di vita, cattive abitudini e soprattutto fattori d’inquinamento spesso colpevolmente tollerati. Una sempre più accurata conoscenza inoltre del dna e dell’identità genetica permette ormai di elaborare una mappatura precisa e quasi individuale di rischio e predisposizione ai tumori. Tutto questo impone l’obbligo di trattare il cancro come una malattia certamente grave e seria, ma di normalizzarla. Il cancro è curabile anche quando non è guaribile in modo definitivo. Non è fuori dalla vita e non è la bestia nera.
Le terapie sono sempre più personalizzate e la clinica pone sempre più attenzione allo studio e al contenimento degli effetti collaterali. La percezione di sé - e quindi l’immagine del proprio corpo nella fase chirurgica e in quella delle cure - non sono più considerati dettagli ininfluenti, ma condizioni importanti per la guarigione. L’estetica, ad esempio, nelle patologie oncologiche femminili non è più interpretata come un vezzo o un aspetto coadiuvante, ma è messa al centro della stessa chirurgia. Tantissime testimonianze raccolte dall’AIRC documentano come dopo la diagnosi di cancro si possa, pur con tutta la fatica immaginabile, recuperare normalità.
Spiritualità nel cancro non è necessariamente risposta al perché sia accaduto. Non è necessariamente fede. Né è un percorso risolto di significato e di disegno provvidenziale. Più semplicemente è la trasformazione di un fatto occasionale e grave in un cambiamento anche interiore della vita e, spesso, nel raggiungimento di un’esistenza più raffinata, meno elementare e di maggiore autocoscienza. Nessuna didattica della sofferenza, ma la convinzione che l’esistenza sia naturalmente fatta di questi improvvisi incontri con il dolore e che l’ostinazione di vivere non sia altro che la saggezza della normalità messa accanto alla velleità dei sogni.
Soltanto per questo, per parlare di cancro, di cura e di corpo, non si può non parlare di spirito. Le persone vanno curate tutte intere, il loro mondo, i pensieri, le relazioni e i desideri vivono insieme a loro questo assedio e vivono pensando al giorno in cui saranno liberi. La guarigione inizia anche così, anche quando non può essere scritta su nessuna cartella clinica. Il 16 maggio è dedicato a queste storie di straordinaria normalità.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Impegnati sulla volata scudetto o sulla nazionale geriatrica in partenza per il Sudafrica, quasi distratti dall’ampliarsi quotidiano della lista della cricca del mattone a buon mercato, ci capita di non riuscire a concentrarci sulla cronaca nera. Succede, del resto, quando il governo e i media vanno d’accordo e quando non c’è bisogno di utilizzare la cronaca dei delitti peggiori in chiave elettorale. Eppure, le ultime settimane sono state ricche, tristemente ricche, di episodi di violenza e di follia, di uomini che uccidono donne.
Eravamo abituati al clima estivo quale ambientazione dell’esplosione di follia familiare. Psicologi televisivi e intrattenitori, improvvisatisi giornalisti, negli ultimi anni avevano sempre scoperto nel clima torrido, nella solitudine delle vacanze fallite o in qualche altra scempiaggine, la molla scatenante delle devianze criminali sopite. Adesso invece, che la bella stagione non è ancora alle porte, quando tutte le concause sono ancora in attesa, la furia omicida, i comportamenti criminali in famiglia sono all’ordine del giorno. Da nord a sud, sposati o separati, con figli o senza, occupati o disoccupati, va in scena ovunque il filmino postmatrimoniale orrido, quello che ha un solo soggetto: la violenza sulle donne.
E non si tratta di violenza sessuale occasionale, di stupro addebitabile al maniaco o all’extracomunitario di turno, che invece di trasudare dolore e indignazione, risulta buono per rimpolpare la dose di xenofobia, questa tutt’altro che latente. Non lo troverete nei titoli dei giornali, ma sono italiani, italianissimi, gli assassini di donne di questa primavera infame. E non assassinano - o tentano di assassinare - incolpevoli quanto ignote donne indifese: sono i loro mariti o ex-mariti, fidanzati o amanti, persino parenti di primo o secondo grado.
La famiglia, dicono quelli che ne hanno almeno due, é sacra e indivisibile. E’ dove si edifica la struttura sociale del paese, il luogo della costruzione identitaria. Proprio per questo detiene diritti che le relazioni prive di timbro nemmeno si sognano. E se al timbro si lega il diritto, proprio per evitare che quei diritti possano averli un domani, si fa in modo che quei timbri non trovino liceità. Probabilmente difettiamo in etica teologica, ci ostiniamo a credere che la famiglia sia solo uno dei luoghi - e non l'unico - dove sia possibile costruire la rete di affetti con la quale si vive. La famiglia, insomma, come una possibilità, non come l'imprescindibile.
D’altra parte gli addetti alla diffusione dei sani valori e all’arricchimento del profilo pedagogico del Paese non brillano. La Chiesa che intima divieti all’amore egualitario mentre permette l’obbrobrio della pedofilia nelle sue chiese, si accompagna ai difensori della famiglia in servizio permanente effettivo, che insultano ed offendono in ogni modo le donne. Una moda oscena e bestiale, una vendetta conclamata contro i diritti che le donne hanno saputo conquistarsi quando ancora tra la società e la politica esisteva un legame. L’odio per l’indipendenza, l’odio per l’orgoglio, sembra essere, in compagnia dell’odio per “l’altro”, il senso compiuto della cristianità d’inizio millennio. Non sarà proprio un caso, quindi, se gli ultimi 3 anni, gli omicidi in Italia sono cresciuti del 16 per cento. Dei seicento omicidi all'anno di cui si "fregia" il Belpaese, circa la metà sono tra gente che si conosce e, la metà di questi, all'interno di nuclei familiari.
Il nord ricco non uccide diversamente dal sud povero. Anzi, colpisce semmai come i peggiori massacri siano avvenuti, in questi ultimi anni, proprio nelle villette monofamiliari, simbolo del benessere conquistato oltre che del gusto pessimo, e nei piccoli centri, spacciati ad ogni piè sospinto come l’alternativa dello spirito alla invivibilità della metropoli tentacolare. Pare proprio, invece, senza voler nemmeno lontanamente proporre una lettura sociologica d’accatto del fenomeno, che proprio nel nord, indicato per la qualità dei servizi, e proprio nei piccoli centri, indicati per la qualità della vita, la furia criminale all’interno delle famiglie si scatena con maggiore efferatezza.
Ci sarebbe bisogno di capire cosa c’è nel nostro modello di società che davvero non funziona più. Ci sarebbe bisogno di correre in soccorso della realtà, di uscire fuori dalle case d’ipotetici grandi fratelli e da quelle delle casalinghe disperate in formato televisivo. Bisognerebbe cacciare la Tv anche dall’urna elettorale, di ricominciare a scrivere e a parlarsi senza cercare il carburante dell’odio. Ricordiamo con nostalgia un paese solidario, dove le lotte per l'uguaglianza e per l'allargamento dei diritti di tutti prevaleva, anche sul piano morale, all'individualismo sfrenato e all'ostentazione del privilegio. Forse da quella nostalgia si dovrebbe ripartire.
Per farlo, servirebbe ricominciare ad indagare la realtà nella quale viviamo, in un sistema arcaico ed iniquo che opprime tutti, chi più chi meno. Per scoprire magari che quest’Italia, che si sveglia sentendosi diversa da tutto e s’addormenta scoprendo di aver paura di tutti, il filo dell’unità e dei valori deve assolutamente recuperarlo. Perché l’ha perso da un pezzo. Da quando cioè, quindici anni fa, scelse di diventare più furba, invece che più giusta.
