- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
La musica di Ramin Bahrami torna ad allietare la scena concertistica italiana, aprendo la stagione dell’Araba Fenice di Terni. Si mette in moto il “Vortice delle Passioni”, con una serie di appuntamenti che percorreranno il solco artistico che affonda nel fertile terreno della promozione, dello sviluppo e della conoscenza del repertorio pianistico. Opening Concert, domenica 10 novembre all’auditorium Gazzoli, alle ore 17.30, con il geniale pianista iraniano, che eseguirà uno splendido programma dal titolo: “Il Viaggio in Italia”, con musiche composte da Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti.
Bahrami è al momento considerato uno dei migliori esecutori al mondo delle opere del grande Bach. Un amore verso la sua musica che nasce in Bahrami fin dalla tenera età di 5 anni, quando ascoltò per la prima volta le Variazioni Goldberg eseguite da Glenn Gould. Da quel giorno la vita di Bahrami non fu più la stessa e non soltanto per le gravi ripercussioni che ebbe la sua famiglia con l’avvento della dittatura degli Ayatollah, ma anche per la fortuna di aver trovato l’amorevole accoglienza dell’Italia, il paese che lo accolse a soli 11 anni e che poi lo consegnò nella mani di quello straordinario insegnante che fu Piero Rattalino al Conservatorio di Milano.
Il suo legame con Bach, il suo amore verso questo autore, è stato per lui motivo di salvezza, di libertà, di crescita umana e intellettuale. Un connubio profondo fra compositore e esecutore, raro, unico, talmente originale da poter accomunare a tutt’oggi Bahrami al fianco dei più grandi esecutori della storia del pianoforte come Gould, Rosalyn Turek, Alexis Weissenberg, tutti profondi conoscitori ed interpreti della musica di Johann Sebastian Bach. Lo racconterà personalmente il 9 novembre, in un incontro con gli amanti della musica, dove il musicista iraniano parlerà del suo nuovo libro “Come Bach mi ha salvato la vita”.
Bahrami possiede una vena musicale originale e unica, un suono cristallino pieno di equilibrio e di personalità. Non è un caso che nella prefazione del suo primo libro, lo stesso Piero Rattalino scrive: “Ramin Bahrami scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello, Glenn Gould, senza veramente assomigliare al modello. Io gli ho insegnato a sopportare il morso, ma non l’ho domato e spero che continui ad essere com’è”.
Il programma che affronterà Bahrami a Terni, come già detto, sarà un’alternanza fra le opere di due geniali musicisti che furono anche coetanei. Scarlatti e Bach nacquero ambedue nel 1685 e scomparvero a breve distanza: Bach nel 1750, Scarlatti nel 1757. Il programma propone un ideale “Grand Tour” d’Italia, alternando le sonate di Scarlatti a composizioni di Johann Sebastian che, anche se meravigliosamente diverse, sono accomunate da una identica ispirazione, quell’ “italienischen gusto” nel quale il musicista napoletano era nato e di cui il musicista tedesco si era nutrito, soprattutto in età giovanile.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Capitolo del grande romanzo russo, I fratelli Karamàzov, di Fëdor Dostoevskij, La leggenda del Grande Inquisitore viene riletto in teatro dal bravo Umberto Orsini che veste il doppio ruolo di narratore e inquisitore, fra memoria e finzione, nostalgia e sofferenza, aprendo la stagione teatrale al Secci di Terni. Azzeccata si rivela la scelta iniziale di rendere, solo con i movimenti del corpo e i gesti, quello che, successivamente, verrà spiegato attraverso le parole. Una sperimentazione, quella di Orsini, che riesce a pieno, rendendo il testo diretto.
Maglia scura e voce profonda, Orsini offre un’interpretazione interessante del famoso racconto dello scrittore russo, quello che, nel romanzo, Ivàn Karamàzov espone al fratello Aleksej, ambientandolo in Spagna ai tempi della Santa Inquisizione.
La parole fede e quella libertà predominano la scena, come se si volesse chiedere al pubblico che cosa sia l’una e cosa l’altra, mettendo al centro forse l’idea di una fede che si fonda proprio sulla libertà, criticando i grandi movimenti come il positivismo o il cattolicesimo. L’Inquisitore si rivolge a Cristo, che è tornato sulla terra, mettendolo di fronte al fatto che gli uomini non sanno che farsene del libero arbitrio, demandando ad altri le decisioni, perché è solo così che realmente si sentono liberi.
La regia è affidata a Pietro Babina, il quale non manca di originalità e sceglie di asciugare il testo e di affidare alle parole finali di Orsini il succo filosofico del racconto, che può essere apprezzato e compreso anche al di fuori del contesto del romanzo.
“Vivo da quarant’anni col Grande Inquisitore di Dostoevskij - afferma Orsini - da quando cominciai ad occuparmene in occasione dello sceneggiato che alla fine degli anni Sessanta fu realizzato da Sandro Bolchi per la Rai tv e che fu seguito da più di venti milioni di persone per otto settimane di seguito. Interpretavo il fratello Ivan e per anni mi sono sentito dire da generazioni di spettatori che venivano ad incontrarmi nei camerini dei teatri: “Ma quell’Ivan Karamazov! Ma cose così perché non ne fanno più? Sentendo nella loro voce un rimpianto e soprattutto una memoria sorprendenti”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
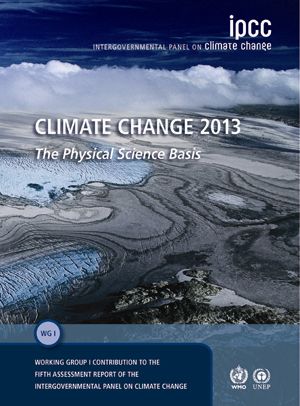 di Liliana Adamo
di Liliana Adamo
La potenza schiacciante dei media al servizio di un ben congegnato depistaggio sul clima; si chiama Global Warming Policy Foundation, raccoglie un manipolo di scettici sul cambiamento climatico (con Lord Lawson, in testa), che, a loro volta, occultano i veri mandanti, i fondamentalisti del libero mercato (e i loro alleati politici), referenziati dall’Heartland Institute, potente gruppo di pressione con sede a Chicago. Gli stessi che hanno orchestrato una campagna tesa a screditare pesantemente i risultati del Gruppo Intergovernativo, meglio conosciuto con la sigla IPCC.
Nel suo Quinto Rapporto di Valutazione (The Physical Science Basis), reso pubblico il 27 settembre scorso, l’IPCC ha fornito la sua versione sull’evoluzione dei cambiamenti climatici: “Il riscaldamento del clima terrestre si aggrava per colpa in gran parte dell’uomo. La temperatura della terra aumenterà da 0,3 a 4,8 gradi centigradi, entro il 2100. I primi dieci anni del nostro secolo sono stati i più caldi dal 1850…”.
E, mentre si teneva la presentazione ufficiale del documento a Stoccolma, Londra si convertiva a fulcro universale dell’agnosticismo climatico, per controbatterne le tesi e fomentare i media. Giusto per rubare la scena al gruppo Intergovernativo, ecco che, nello stesso giorno, è stata indetta una mega conferenza stampa, una sorta di duello a distanza.
Ciò che i media non hanno comunicato è la brigata d’ultraliberisti (chi manovra i fili dell’Heartland), che rimunera un gruppo di scienziati in pensione affinché producano falsi dossier confutando sia l’esistenza sia gli effetti del global warming, orientando un massiccio movimento d’opinione a livello internazionale.
Primi attori nella conferenza stampa londinese, Fred Singer e Robert Carter, hanno dato il meglio di sé sfoggiando una visione diametralmente opposta a quella presentata dai veri ricercatori sul clima. La BBC non si è lasciata sfuggire l’occasione e ai due ha predisposto un tour presso gli studi del Broadcasting House con interviste a go go; addirittura, il tempo stimato per questi incontri è risultato molto più lungo rispetto a quello dedicato alla presentazione del famoso Rapporto sul Clima, redatto dall’IPCC: McLuhan docet.
Gli artefici della BBC (come quelli dell’ITV News at Ten, del Daily Telegraph, per rimbalzare fino al Time), hanno finto d’ignorare che gli stessi Carter e Finger si sono guadagnati l’attuale popolarità quali autori di una campagna d’affissioni che accomuna l’Unabomber, al secolo Ted Kaczynski a Charles Manson, dichiarandoli entrambi proseliti del riscaldamento globale (sic).  Inconsapevoli anche che lo stesso professor Carter (un geologo australiano, specializzato in paleontologia, stratigrafia, geologia marina e scienze ambientali, chiamato dai suoi detrattori “climate misinform-er”), presta la sua opera (contributi a siti web e opuscoli) al “Consiglio consultivo Accademico” della londinese Global Warming Policy Foundation di Lord Lawson (di cui è membro), al contempo è portavoce dell’Heartland Institute di Chicago, in un pacchetto "all inclusive".
Inconsapevoli anche che lo stesso professor Carter (un geologo australiano, specializzato in paleontologia, stratigrafia, geologia marina e scienze ambientali, chiamato dai suoi detrattori “climate misinform-er”), presta la sua opera (contributi a siti web e opuscoli) al “Consiglio consultivo Accademico” della londinese Global Warming Policy Foundation di Lord Lawson (di cui è membro), al contempo è portavoce dell’Heartland Institute di Chicago, in un pacchetto "all inclusive".
Il professore ha fatto la sua fortuna in propagande soppesate con piani marketing d’azione, coadiuvato dalle migliori menti (giunte ormai all’età della pensione), raccattate qua e là dopo una modesta carriera nelle varie università d’oltreoceano.
L’intera congerie non potrebbe neanche presentarsi a tv e giornali se non fosse attentamente coordinata da potenti mezzi e alleati politici, che la usano per screditare e travisare i risultati del Gruppo intergovernativo d’esperti.
I giorni londinesi dell’attacco frontale ai risultati dell’IPCC, hanno dimostrato come una piccola cricca rastrellata sotto l’egida di skeptical science, sia stata in grado d’utilizzare reti politiche, legami familiari e simpatie ultraliberiste, in una sorta di rassicurazione che, lungi d’essere tale, palesa l’intento a deviare e falsare il dibattito pubblico in un paese, il Regno Unito, notoriamente sensibile alla difesa dell’ambiente e a soluzioni che contrastino il cambiamento climatico.
Contro l’IPCC si sta preparando una belligeranza mediatica su larga scala: per mantenere lo status quo sul global warming si fa anche questo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Vincenzo Maddaloni
di Vincenzo Maddaloni
Praga. Chissà cosa direbbe Libuše, la principessa del popolo Ceco che secondo la leggenda fondò Praga nell'VIII secolo, più esattamente nel 730. Di certo la Fondatrice che s’era augurata «una città nel mondo illustre e la cui gloria raggiungerà le stelle», sarebbe perplessa, per non dire allibita dalla vista della sua capitale trasformata - con le bancarelle e i massaggi Thai - in una sorta di Disneyland dentro alla quale ogni giorno si accalcano decine di migliaia di turisti, che salgono verso il mitico castello che già nel X secolo era simile a quello attuale. Una dissacrazione quotidiana come accade a Venezia e nelle altre città d’arte.
Di certo Libuše [nella scultura a lato assieme a Premysl] che avrebbe avuto il dono della profezia e “vedeva” nel futuro, non si sarebbe stupita di quanto sta accadendo oggi nel suo Paese. Poiché ella sposò Premysl, un contadino, anticipando un connubio democratico - davvero inaudito per una sovrana - con il quale regnò sul popolo cèco. Sicché oggi questo brano di leggenda riaffiora e non a caso, poiché il 25-26 ottobre nella Repubblica Ceca si svolgeranno le elezioni, provocate da una crisi di governo irreparabile che aveva colpito prima quello liberamente eletto e poi quello “tecnico” che gli era per forze di cose succeduto.
Il Lidové Noviny, (Quotidiano del Popolo, una delle testate più autorevoli e antiche della Boemia), già avverte che «il panorama politico ceco si sposterà a sinistra e si tingerà di rosso». Gli analisti sostengono che i socialdemocratici e i comunisti potrebbero raccogliere tre quinti dei seggi, abbastanza da riscrivere la Costituzione. E spiegano che, in un momento in cui la situazione economica è tra le peggiori dell’Ue (soltanto i paesi del Sud e l’Ungheria sono più in difficoltà), in molti vogliono «un governo forte a guidare il Paese».
Si tenga a mente che col ritorno alla democrazia (1989) si sono riaffacciati anche sul panorama politico ceco i partiti di diverso orientamento. Una curiosità è che, analogamente a quanto accadde in Polonia con Solidarnòsc, le due maggiori forze politiche ceche, il CSSD, Partito Socialdemocratico (centrosinistra) e l’ODS, Partito Democratico Civico, (centrodestra) sono due dirette emanazioni del Forum Civico di Havel, a testimonianza del fatto di come l’opposizione al comunismo raccogliesse consensi trasversali nel Paese.
Altre forze politiche di minore entità sono il partito TOP ’09 (Tradizione, Responsabilità, Prosperità) marcatamente di destra, il partito centrista e democristiano KDU-CSL e il Partito Verde, che si attesta sempre su buone percentuali (6-7 per cento). Un discorso a parte merita il KSCM, il Partito comunista di Boemia e Moravia. Erede diretto del Partito comunista di Cecoslovacchia, il KSCM ha sempre goduto di un consenso non di poco conto, registrando, alle ultime elezioni regionali dell’ottobre 2012, il 23 per cento dei voti e 14 seggi su 45.
Stando così le cose si capisce perché le elezioni del 25-26 ottobre diventano importanti. I sondaggi prevedono come primo partito il CSSD dei socialdemocratici, senza che però esso consegua la maggioranza assoluta, eventualità che potrebbe spingere i socialdemocratici a formare un governo di coalizione proprio con il KSCM. E’ una prospettiva che inquieta personaggi come il politologo Igor Lukeš, luminare dell’Università di Boston, il quale ricordando che i comunisti imposti da Mosca conservavano il potere a forza di esecuzioni, si stupisce che i cechi continuino a votarli. «È qualcosa di unico che non ha precedenti in tutto l’Est Europa”, sbotta il professore.
Gli dà sostegno il De Standaard, il quale si dice convinto che i cechi soffrano di “un’amnesia generale”. Sicché «non possiamo trovare una dimostrazione migliore della memoria corta dell’umanità», scrive il quotidiano fiammingo, ricordando che i comunisti cechi che non hanno mai preso le distanze dai decenni di comunismo stalinista, «si sono affermati un po’ ovunque come forza politica di peso».
Naturalmente il De Standaard non accenna al fatto che la Repubblica Ceca da più di due anni attraversa la più lunga recessione economica della sua storia. Tanto meno informa che nella regione dell’est del Paese c’è il rischio di una “catastrofe sociale”, come rileva il quotidiano Mf Dnes (Fronte della Gioventù - Oggi) Secondo il giornale - tra i più influenti e diffusi - la regione già colpita dalla disoccupazione a lungo termine (9,68 per cento contro una media nazionale del 7,5 per cento) è minacciata da una nuova ondata di licenziamenti, con la previsione che 71mila persone potrebbero perdere il lavoro. Malauguratamente quanto sta accadendo a Praga non fa storia a sé, poiché la crisi economica ha nuociuto gravemente all’intera democrazia liberale europea. Il modello che univa l’economia di mercato a una vasta gamma di servizi sociali, e che ha trasformato l'Europa in un punto di arrivo per milioni di persone provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America del sud non regge più.
Malauguratamente quanto sta accadendo a Praga non fa storia a sé, poiché la crisi economica ha nuociuto gravemente all’intera democrazia liberale europea. Il modello che univa l’economia di mercato a una vasta gamma di servizi sociali, e che ha trasformato l'Europa in un punto di arrivo per milioni di persone provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America del sud non regge più.
Il continente è in fallimento, a parte alcune eccezioni come la Germania e i Paesi scandinavi che hanno applicato in tempo le manovre necessarie per evitare il disastro. Dove questo non è accaduto, sono subentrati i non-liberali i quali sono riusciti ad occupare gli spazi abbandonati dai liberali.
Come se gli elettori, indignati dalla incapacità della politica di dare risposte adeguate, scandalizzati dalla corruzione che dilaga nei centri del potere, ne avessero abbastanza di questi ventitré anni di sperimentazione liberale e aspirassero al ritorno di uno stato forte, in grado di farsi carico dei loro problemi. Sicché quanto sta accadendo nella Repubblica Ceca è la prova più evidente che la democrazia liberale nell’Europa centrale è diventata la più grande vittima della crisi.
Eppure, i tempi con i quali i cechi si scrollarono di dosso i comunisti furono fulminei rispetto a tutto l’Est. La Rivoluzione di Velluto (così definita perché il Partito comunista di Cecoslovacchia rinunciò pacificamente al potere), nel giro di poco più di un mese (metà novembre - fine di dicembre 1989), varò il Forum Civico di Vaclav Havel (ex scrittore ed attore di teatro) con il quale egli organizzò una serie di manifestazioni di protesta contro il regime che riscossero grandissimo successo tra la popolazione, tanto da costringere i vertici comunisti a dimettersi. Poche settimane dopo, il 29 dicembre, Havel venne nominato Presidente della Repubblica e Alexander Dubcek, l’eroe della “Primavera di Praga” del 1968, fu chiamato a guidare la Camera.
Da quel giorno, nel paese che ancora per pochi anni si chiamerà Cecoslovacchia, prese avvio il pluralismo, il multipartitismo e la libertà di espressione, assieme alle prime tensioni etniche, fino ad allora opportunamente coartate dal regime comunista. Nel 1993, infatti, la Cecoslovacchia si divise pacificamente in due repubbliche, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Ricordo che l’ultima volta che incontrai lo scrittore e poeta Bohumil Hrabal - qualche mese dopo la divisione del Paese, gli chiesi tra l’altro se sarebbe ritornato a Kladno, la città che dopo la separazione era rimasta ceca, dove egli aveva ambientato “Allodole sul filo” il suo romanzo che racconta di un deposito di rottami metallici trasformato negli anni Cinquanta in un campo di rieducazione per borghesi che avevano cercato di espatriare clandestinamente, costretti a un lavoro manuale.
Una satira arguta sull'assurdo quotidiano e la stupidità burocratica di un regime stalinista che egli iniziò a scrivere durante la "primavera di Praga" del '68, e la terminò nell’anno seguente, quando il Paese era tornato in mano ai comunisti. Proibito dalla censura, disseppellito vent'anni dopo, il romanzo era stato tradotto in un film che vinse l’Orso d’oro del 1990. Era il mio uno spunto per sentire il suo pensiero. Nell’osteria U Zlatého tygra, Dalla Tigre d’oro, (dove riuscì persino a trascinarvi il presidente Havel e il presidente Clinton, in quello stesso posto hanno appeso a ricordo la sua foto), egli mi rispose con un’alzata di spalle, un sorriso e la levata del bicchiere di birra com’era solito quando non aveva voglia di replicare se la domanda non gli piaceva.
Nell’osteria U Zlatého tygra, Dalla Tigre d’oro, (dove riuscì persino a trascinarvi il presidente Havel e il presidente Clinton, in quello stesso posto hanno appeso a ricordo la sua foto), egli mi rispose con un’alzata di spalle, un sorriso e la levata del bicchiere di birra com’era solito quando non aveva voglia di replicare se la domanda non gli piaceva.
Questo accadeva sovente se la domanda riguardava l’attualità. Accadde anche nell’Agosto dell’Ottantuno, un anno dopo la rivolta di Solidarnosc in Polonia e la comparsa del nuovo papa - Karol Wojtyla - che con le sue esternazioni stupiva il mondo. Anche allora Hrabal non si lasciò prendere dall’entusiasmo, dall’emozione. Come la principessa Libuše sussurrò un augurio: «Speriamo che duri». Infatti accadde, ma dopo che la Polonia attraversò il colpo di Stato del generale Jaruzelski e altri sei anni di governo comunista.
Dopotutto Hrabal era per molti versi personaggio che apparteneva al surreale come i suoi racconti, i suoi romanzi che traboccano di descrizioni anti-eroiche, di vicende quotidiane minime sempre al limite del paradosso. E’ il suo un acuto e perciò prezioso bric-à-brac - un flusso ininterrotto di invenzioni e di "chiacchiere” - da Marché aux Puces, che gli diede subito notorietà e lo rese scrittore amato, perché imprevedibile, surreale appunto. Un surrealismo inteso - si badi bene - come ribellione alle convenzioni culturali e sociali, concepito come una trasformazione totale della vita. Se si tiene a mente l’epoca con il mondo diviso in due blocchi, meglio si capisce la peculiarità coraggiosa del messaggio di Hrabal.
Sicché mi è tornato in mente Bohumil Hrabal voltando in via Husova, la strada di U Zlatého tygra, la sua osteria perché più di ogni altro egli riassume l’imprevedibilità - che sovente aderisce al paradosso - dei Cechi, i quali s’inventarono la leggenda della principessa “democratica” Libuše, e poi scelsero il velluto per abbinarlo alla parola “Rivoluzione”, che divenne un “marchio” strepitoso perché mai era accaduta prima una così contrastante unione. Come adesso rischia di esserlo pure questo riavvicinamento al comunismo, vissuto non come semplice amarcord, ma come nostalgia per un sistema statalista che, sebbene nel male più che nel bene, provvedeva a tutto. Non a caso si sente spesso dire nei dibattiti che gli elettori si sono fatti “rubare” lo Stato.
Naturalmente, è difficile dire se ci stiamo avviando verso la fine della democrazia liberale e, con essa, anche dell’economia di mercato in questi paesi ex comunisti dell’Europa centrale, che sono stati finora i più devoti sostenitori del capitalismo. In ogni caso, i traumi delle economie dell’Europa centrale hanno un peso sui responsabili politici di cui non ce n’è memoria, come degli umori disincantati delle loro genti. Che leggono, studiano, s’informano. Un’abitudine che hanno acquisito fin da ragazzi, a casa e a scuola.
Infatti, basta salire sulla scala mobile della metro della stazione di Nàmesti Republiky in centro, oppure di Opatov alla periferia di Praga per vedere scorrere sulle pareti la pubblicità del burghy che si alterna con quella delle copertine dei libri. Che non sono i gialli alla Camilleri, bensì per la gran parte saggi che riguardano l’economia. Significa che i libri sono richiesti, che vanno molto, perché il prodotto ha margini ristretti di guadagno e la pubblicità costa, anche a Praga. Di certo, sono scorci di parete inimmaginabili di là delle Alpi. Cioè da noi, e anche questo per molti versi fa la differenza
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Silvia Mari
di Silvia Mari
Mancano pochi giorni alla data di chiusura, il 15 settembre, della mostra di Sebastiao Salgado all’Ara Pacis di Roma. Per chi non avesse ancora avuto modo l’invito è di andare. Per chi non può slegare il valore assoluto dell’estetica e del bello dalla tensione etica e filosofica, la galleria di fotografie in bianco e nero è un “santuario” imperdibile. “Genesi” questo il nome del progetto che, parallelamente a Roma, è partito a Londra, Rio de Janeiro e Toronto vuole catturare la bellezza del pianeta senza alterarla, restituendola alla sua purezza.
Animali, clima, vegetazione e uomo convivono in un equilibrio perfetto in cui i piani del dominio sono - ove ci sono - quelli della natura e della legge della vita, anche nelle sue note più crude e primitive. L’ambizione è quella di proteggere il pianeta dalle avventure di uno sviluppo distruttivo e scellerato. Antartide, Patagonia, Etiopia, Indonesia e altri luoghi remoti rappresentano i fotogrammi di un viaggio che protegge, custodisce e denuncia.
A questo proposito, come ricorda la moglie del fotografo curatrice della mostra, Lelia Wanick Salgad, da questo lavoro è nato un progetto che fa capo alla Fondazione no–profit sorta nel 1998 per il rimboschimento di circa 800 ettari di Amazzonia distrutta e ridotta a sabbia bruciata.
Le fotografie non rappresentano quindi le velleità di uno scienziato della natura, né quadri di un pittore che tende a sovrapporre il piano di un sogno o di un dramma personale. Le immagini vivono, parlano e, come Salgado dice di sé, nascono dallo sguardo di un uomo curioso che non si accontenta della contemplazione, ma cattura il cuore di uno splendore tanto perfetto quanto fragile. L’obiettivo è quello dell’arte, ma il momento dell’opera immortalato è tutto giornalistico. Racconta, segue in movimento animali, uomini e donne in riti e tradizioni, foglie di palma e castelli di ghiaccio polare, denuncia il rischio di cose che possono finire, utilizzando il ripetersi di quadri viventi che vogliono rammentare al visitatore che tutto quello che è messo in cornice esiste davvero in punti precisi del nostro pianeta. La mostra come un lungo viaggio.
L’obiettivo è quello dell’arte, ma il momento dell’opera immortalato è tutto giornalistico. Racconta, segue in movimento animali, uomini e donne in riti e tradizioni, foglie di palma e castelli di ghiaccio polare, denuncia il rischio di cose che possono finire, utilizzando il ripetersi di quadri viventi che vogliono rammentare al visitatore che tutto quello che è messo in cornice esiste davvero in punti precisi del nostro pianeta. La mostra come un lungo viaggio.
Da Parigi, la città in cui vive, Salgado non ha smesso infatti di essere un viaggiatore. Non un apolide, fatto di sola inquietudine, ma uno che ama ricordare. Da qui la promessa di restituire un po’ di foresta rubata al Brasile, tutelandola con un impegno che è anche politico ed economico, nonché ecologico.
Sono in molti a rimproverargli di aver fatto fortuna sul dolore dei drammi umani. L’arte non ha bisogno, nella sua accezione più romantica, di un fine morale per essere riconosciuta nel suo assoluto valore. Ma è certamente vero che quando il bello catturato da un artista colpisce una coscienza, l’arte è già altro da sé.
E’ il desiderio di un impegno, un pensiero, una smorfia di concentrazione o stupore rivolta a se stessi. Quella che l’occhio di Salgado, in un raffinato bianco e nero, coglierebbe senza esitazioni. Non il volto di quella donna, al termine della visita, fotografato nella sua ovale armonia, ma la ruga più nascosta che ne racconta il pensiero di quel preciso momento. La bellezza più fragile.
