- Dettagli
- Scritto da Administrator
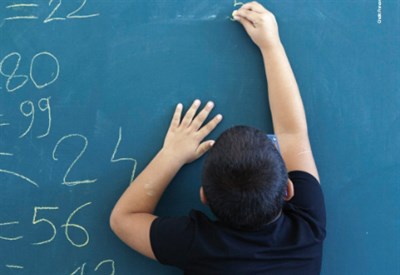 di Tania Careddu
di Tania Careddu
E’ subdola, imprevista e si cela dietro alle debolezze nella lettura e nel calcolo. E’ il prodotto di solitudine, angustia, squallore e assenza che i bambini hanno respirato fin dalla più tenera età. In un mondo sempre più caratterizzato dall’economia della conoscenza, la povertà educativa alleva bambini senza favole, senza giochi, senza fantasia e, talvolta, senza rapporti umani profondi.
Strettamente connessa alla condizione socio-economica e culturale delle famiglie, la povertà educativa priva i minori delle opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità e aspirazioni. Non solo cognitive ma anche emotive, di creazione del sé e di scoperta dell’altro.
Colpisce più di un bambino su cinque, secondo un circolo vizioso di ereditarietà - di padre in figlio - tanto che l’Italia, nel 2016, si è caratterizzata come uno dei Paesi europei con la più bassa mobilità educativa. Se poi i genitori sono migranti, la drammaticità della povertà cognitiva è ancora più preoccupante.
Sta di fatto che per tutti, migranti o autoctoni svantaggiati, la partecipazione ad attività culturali e ricreative è, e non solo per ovvi motivi finanziari, significativamente residua tra coloro che vivono in nuclei famigliari con risorse economiche scarse.
L’associazione tra la povertà educativa e le capacità non cognitive, in particolare il piacere di stare con gli altri, l’abilità di vincere la solitudine, di stare bene fra i banchi di scuola così come la motivazione nel perseguire uno scopo nella vita e l’investimento per cogliere le giuste opportunità di crescita, rivela tutta la sua portata quando gli adolescenti arrivano a sentirsi outsider, accrescendone la privazione educativa che li spinge fino all’abbandono degli studi, soprattutto fra i maschi, nei centri piccoli e nelle periferie delle grandi città.
Più al Sud che al Nord: un adolescente che vive in Campania ha quasi il doppio di possibilità di non raggiungere le competenze minime rispetto a un coetaneo della Lombardia e il triplo rispetto a quello della Provincia Autonoma di Bolzano e Trento. Nelle Isole, più di due minori su tre non leggono libri, non praticano sport e non navigano su internet nel tempo libero, e registrano percentuali tra le più basse d’Europa relativamente all’abbandono scolastico.
Nonostante l’evidenza della correlazione tra fruizione culturale e ricreativa e diminuzione dell’incidenza della povertà educativa, a oggi sono proprio i bambini delle famiglie disagiate ad avere minori opportunità di formarsi educativamente per la carenza dei servizi a loro destinati. A partire dagli asili nido. Gli scienziati di tutto il mondo affermano che è nei primissimi anni di vita che si forma l’identità, quindi l’acquisizione di abilità cognitive (intelligenza critica, memoria, linguaggio e comprensione) cui seguono quelle socio-emozionali ( socialità, valori ed ethos collettivo, comportamento individuale e capacità di adattamento) e fisiche (massa corporea, facoltà visive e uditive, stato nutrizionale e di salute).
Gli scienziati di tutto il mondo affermano che è nei primissimi anni di vita che si forma l’identità, quindi l’acquisizione di abilità cognitive (intelligenza critica, memoria, linguaggio e comprensione) cui seguono quelle socio-emozionali ( socialità, valori ed ethos collettivo, comportamento individuale e capacità di adattamento) e fisiche (massa corporea, facoltà visive e uditive, stato nutrizionale e di salute).
Per Save the children, che ha redatto il rapporto “Futuro in partenza”, la mission è quella di investire nella prima infanzia, chiave per debellare la povertà educativa. Fino a che la distribuzione delle abilità per stare bene nel mondo non diventi uguale per tutti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Altro che mille e una. Sono trecentocinquantacinque milioni e ottocentoquarantanove mila le notti trascorse fuori casa dagli italiani nel 2016. Invertendo la tendenza negativa a viaggiare che, per la prima volta dopo sette anni, assume segno positivo. Determinato, soprattutto, dalla predilezione (o possibilità) per le vacanze brevi che aumentano del 20 per cento, anche se non è affatto trascurabile l’incremento, pari all’11 per cento, di quelle a lungo termine.
Corte o lunghe, le vacanze sono, nel 90 per cento dei casi, la ragione dei pernottamenti fuori dalle mura domestiche, lasciando al 10 per cento gli spostamenti per motivi di lavoro, che rimangono sostanzialmente invariati, salendo, però, in maniera consistente nel periodo tra aprile e giugno.
Ed è proprio da questo mese che un italiano su tre - soprattutto quelli del Nord Est, che detiene il primato del maggior numero di viaggiatori - comincia a preparare le valigie. Per soggiornare, principalmente e meglio di niente, per una settimana, confermandosi, la tendenza della contrazione della durata media delle vacanze.
Per le quali, quando battono bandiera tricolore, il Nord è l’area con il più alto potere attrattivo, con Emilia Romagna e Veneto in testa, sia per le vacanze sia per i viaggi professionali, questi ultimi diretti soprattutto in Lombardia; il Mezzogiorno, di contro, è la meta preferita per le vacanze di lungo periodo, Puglia in cima. Per il Trentino Alto Adige prima posizione per quelle invernali. Si raggiunge la destinazione per lo più con la macchina, anche se l’aereo e il treno, in quinto dei casi, rimangono i mezzi più utilizzati per i viaggi di lavoro. Per soggiornare, la sistemazione preferita sono gli alloggi privati versus le strutture collettive opzionate per i soggiorni di lavoro.
Andando Oltralpe, se l’opzione è una destinazione europea, Francia e Spagna sono i Paesi più visitati, seguiti da Germania (per motivi di lavoro) Austria, Regno Unito e Croazia. Varcando i confini del vecchio continente, gli Stati Uniti la fanno da padrone per i soggiorni lunghi e la Tunisia per quelli brevi, mentre per i viaggi d’affari, dal 2015 la Cina si conferma al primo posto. Quattro viaggi su dieci sono stati prenotati su internet, con l’intento di trascorrere un periodo di svago o per far visita ad amici e parenti. Mare, sapore di mare, è la colonna sonora del 47 per cento circa delle vacanze di piacere mentre le visite al patrimonio artistico, monumentale o archeologico sono molto più diffuse sia all’estero sia in Italia.
Quattro viaggi su dieci sono stati prenotati su internet, con l’intento di trascorrere un periodo di svago o per far visita ad amici e parenti. Mare, sapore di mare, è la colonna sonora del 47 per cento circa delle vacanze di piacere mentre le visite al patrimonio artistico, monumentale o archeologico sono molto più diffuse sia all’estero sia in Italia.
Per le vacanze all’insegna dello sport (meglio conosciuta come settimana bianca) si preferisce la stagione invernale, in cui, invece, rispetto al 2015, cala il trend di spostarsi per partecipare a manifestazioni culturali, folkloristiche, spettacoli e mostre.
Le escursioni, tradotto in spostamento turistico senza pernottamento, sono aumentate del 10 per cento rispetto a due anni or sono, fatte per piacere, per shopping, per presenziare a corsi di formazione o attività culturali, per partecipare a ricorrenze religiose, fare visite a santuari e luoghi di culto, o cure termali e trattamenti di salute. La nostra natura consiste nel movimento, la calma completa è la morte, diceva Blaise Pascal.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Che la morfologia dei flussi migratori, sempre più connessi all’emergenza e alla contingenza delle crisi internazionali, ponga non pochi problemi al nostro sistema di accoglienza è certamente innegabile. Ed è altrettanto vero che con questi dobbiamo fare i conti per pagare il prezzo della globalizzazione e lo sviluppo in un Paese assopito. Con buona pace dei rigurgiti nazionalisti, gli immigrati rappresentano un formidabile volano per la crescita dell’Italia, alla quale forniscono una vitalità altrimenti difficile da trovare per immaginare il futuro.
Con una popolazione composta per il 22 per cento da longevi di età superiore ai sessantaquattro anni e da ultraottantenni che costituiscono il 6,7 per cento del totale e dove i giovani sono sempre meno e fanno sempre meno figli, gli stranieri colmano quel deficit di energie che andiamo progressivamente perdendo. Contribuiscono al mantenimento di quei piccoli periferici comuni che scomparirebbero per effetto dello spopolamento e impediscono la chiusura di alcuni servizi essenziali (a tutti) come scuole, presidi sanitari e farmacie.
Sono indispensabili alla tenuta del welfare famigliare – a basso costo e di buona qualità, sostitutivo di quello pubblico – senza il quale le donne dovrebbero rinunciare alla realizzazione professionale (per dedicarsi all’assistenza degli anziani).
E sono esempio di coraggio, di cui gli italiani diventano sempre più carenti, con quella spinta all’intrapresa che li contraddistingue: la propensione alla microimpresa, nelle costruzioni come nel commercio di prossimità e nella ristorazione, ne ha rivelato la capacità, da sempre considerata italica virtù, di omologarsi a comportamenti socioeconomici.
Guadagnano terreno pure in presenza di segnali (più o meno velati) di insofferenza da parte di molti cittadini italiani che, negli anni della crisi, davanti alla caduta verticale dei livelli di occupazione li hanno reputati pericolosi competitors sul mercato del lavoro, in una caccia alle streghe del tutto infondata soprattutto alla luce dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche. Si rasserenino, gli italiani: gli stranieri, infatti, fino a oggi, hanno lavorato e contribuito a sostenere il nostro sistema previdenziale, ma ne beneficiano in maniera molto limitata. Basti pensare che quel welfare pubblico sgangherato per gli italiani, fa sentire il peso del suo malfunzionamento anche (e forse di più) agli immigrati.
Si rasserenino, gli italiani: gli stranieri, infatti, fino a oggi, hanno lavorato e contribuito a sostenere il nostro sistema previdenziale, ma ne beneficiano in maniera molto limitata. Basti pensare che quel welfare pubblico sgangherato per gli italiani, fa sentire il peso del suo malfunzionamento anche (e forse di più) agli immigrati.
Lo si vede sul versante della procreazione: dai dati riportati nella relazione “Senza stranieri il rischio è il declino”, realizzata dal Censis nell’ambito del progetto “Fuori dal letargo: soluzioni per una buona crescita”, sembrerebbe che i migranti, da sempre e culturalmente sostenitori dell’idea che i figli sono strumento di crescita e riscatto, tendano ormai ad assorbire il nostro modello demografico, con un crollo delle nascite del tutto estraneo al loro vivere.
Cambiamento che, tutto considerato, non impatta sulla silenziosa ma efficace integrazione di cui sono motori, nonostante le derive, interne e internazionali, di rifiuto e chiusura. Un processo lento ma inesorabile, dunque, a cui l’Italia deve la possibilità di trasformarsi, da nolente a volente, in un Paese multietnico.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Alla base di ogni rifiuto (a meno che il termine non sia utilizzato nei meandri della psichiatria) c’è sempre un movente discriminatorio. A maggior ragione quando l’oggetto della deplorevole reazione sono gli immigrati, e senza equivoco alcuno quando quello della pratica in questione è la loro accoglienza. Nel 2016, secondo la ricerca “Accoglienza. La propaganda e le proteste del rifiuto, scelte istituzionali sbagliate”, condotta da Lunaria, sono stati rifiutati duecentodieci volte.
In vario modo, con iniziative di propaganda politica o attraverso quelle pubbliche e proteste di piazza. Della prima specie, settantanove casi riguardano azioni messe in atto da movimenti di estrema destra, vedi Casa Pound e Forza Nuova, e affissioni di striscioni e dichiarazioni verbali a opera di anonimi senza pudore.
Sono i centri di accoglienza, appunto, i luoghi fisici prescelti per veicolare la propaganda che, insieme ai cittadini sul fronte del no, si trasforma in presidi e picchetti, e i social network, le piazze virtuali per dare visibilità alle loro iniziative. Con ‘business dell’immigrazione rovina della nostra nazione’, ‘basta con questa invasione: no profughi’ o ‘no clandestini in mezzo ai bambini’, la propaganda razzista per il rifiuto punta ai temi più caldi per i cittadini: dai costi dell’accoglienza all’evocazione dell’invasione fino ai rischi per la sicurezza del territorio e all’asserzione di un rapporto di concorrenza barra sostituzione nel mondo del lavoro riassumibile in ‘casa e lavoro agli italiani’.
Della seconda, fanno parte le centotrent’uno manifestazioni pubbliche che, nel 2016, assumono una forma più strutturata rispetto gli anni precedenti, e dove i fautori operano con modalità pressoché analoghe, talvolta dietro la pericolosa saldatura tra gruppi di cittadini autorganizzati e partiti politici. Lo fanno muovendosi con un comune denominatore: per eludere le accuse di razzismo, scelgono come bersaglio non i profughi ma lo Stato; aiutiamoli sì, ma a casa loro, rivendicando il primato dei residenti italiani e difendendo il turismo e il commercio locali danneggiati, a loro dire, dalla presenza massiccia dei migranti, oltreché facendo leva sulla paura e sull’agitazione identitaria di un’imminente e perniciosa sostituzione etnica.
Come biasimare (fortemente, se non dal punto di vista umano) le voci di protesta se le politiche migratorie adottate tra il 2005 e il 2012 sono sintetizzabili in respingere, espellere e rimpatriare?
 E’ il discorso istituzionale a consentire sia la proposizione che l’intolleranza nei confronti dei cittadini stranieri; l’adozione di comportamenti discriminatori e anche le violenze razziste possono avere, in fondo, una ragion d’essere. La retorica del rifiuto sta sedimentando pericolosamente un pensiero diffuso che si traduce in pratiche sociali aggressive contro gli interventi di solidarietà e in una declinazione territoriale dei messaggi veicolati nel dibattito politico nazionale.
E’ il discorso istituzionale a consentire sia la proposizione che l’intolleranza nei confronti dei cittadini stranieri; l’adozione di comportamenti discriminatori e anche le violenze razziste possono avere, in fondo, una ragion d’essere. La retorica del rifiuto sta sedimentando pericolosamente un pensiero diffuso che si traduce in pratiche sociali aggressive contro gli interventi di solidarietà e in una declinazione territoriale dei messaggi veicolati nel dibattito politico nazionale.
Le scelte politiche e istituzionali in materia di immigrazione e asilo, con un approccio che intreccia le politiche migratorie con quelle per la sicurezza, confondono e inducono così al consolidamento di una logica binaria che contrappone i cittadini della patria da un lato e gli immigrati senza dio dall’altra. L’ordine e il caos. Gli umani e i mostri.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Lo chiamano ritorno alla normalità. Ma quello di far rientrare gli sfollati nelle case localizzate attorno alla centrale nucleare di Fukushima Daiidi è tutt’altro che regolare. A un anno dalla cessazione delle compensazioni economiche ai cittadini evacuati, il governo giapponese ritirerà, non più tardi del 31 marzo prossimo, l’ordine di evacuazione per seimila abitanti di Litate, villaggio che si trova a nord ovest dei reattori distrutti della centrale, nonché uno dei siti pesantemente contaminati dal disastro nucleare del 2011.
Da una recente indagine condotta da Greenpeace Giappone è emerso che gli sforzi di decontaminazione effettuati dal governo, essendosi concentrati solo nelle aree immediatamente attorno alle case, ai campi agricoli e in strisce di venti metri lungo le strade pubbliche, i livelli di radioattività riscontrati nelle abitazioni della zona - vastissima di duecento chilometri quadrati, il 75 per cento dei quali costituito da foreste montane, parte integrante della vita dei residenti - sono ben al di sopra degli obiettivi a lungo termine prefissati dal governo nipponico.
Si misurano limiti di esposizione annuali che, estesi nel corso della vita delle persone, presenterebbero un rischio radiologico superiore alle norme. Inaccettabile, pari a una radiografia toracica a settimana, anche perché i lavori di decontaminazione hanno generato milioni di tonnellate di rifiuti nucleari che, a oggi, si trovano in altrettante migliaia di siti sparsi in tutta la prefettura.
Ma tant’è: per il governo del Giappone, i paesi considerati non sono più a rischio e per buona parte dell’opinione pubblica, gli sfollati hanno ricevuto compensi sufficientemente equi oltre ai vari indennizzi per il danno. Ma, che se ne dica, la politica giapponese di riportare gli sfollati in aree ancora troppo contaminate va contro le leggi dello Stato e viola numerosi trattati internazionali sui diritti umani. Oltre che sul piano della salute, da garantirsi sia a livello fisico sia mentale, il paese sarebbe tenuto a rispettare accordi che tutelino i gruppi più vulnerabili: donne e bambini, a sei anni dall’incidente, sono i soggetti più a rischio.
E, però, per tutta risposta, il governo nipponico, sia nel periodo immediatamente successivo all’11 marzo 2011 sia negli anni a seguire, ha inflitto molteplici violazioni di quei diritti. Durante il blackout, è aumentata la violenza sessuale e quella domestica sulle donne che, oltretutto, avevano poca voce in capitolo sulle decisioni relative alla loro privacy nei centri di evacuazione, gestiti da uomini, nei quali erano costrette a una serie di incombenze domestiche, come la cura dei malati. Nell’enorme divario di genere, culturalmente accettato, le donne sono state penalizzate da un significativo svantaggio nel far fronte alle conseguenze del disastro tanto più che i pagamenti dei sussidi sono stati dispensati al capo famiglia che ne gestiva l’accesso a sua discrezione.
Nell’enorme divario di genere, culturalmente accettato, le donne sono state penalizzate da un significativo svantaggio nel far fronte alle conseguenze del disastro tanto più che i pagamenti dei sussidi sono stati dispensati al capo famiglia che ne gestiva l’accesso a sua discrezione.
Oltre a una femminilizzazione della povertà (nucleare) le donne sono state vittime, anche, di una grave disinformazione pure per quanto riguarda le conseguenze sulla salute dell’esposizione a radiazioni: aborti spontanei, mortalità perinatale, malformazioni e malattie cardiovascolari sono lievitate.
E con le donne, i bambini, più soggetti a tumori alla tiroide per esposizione allo iodio radioattivo e ‘obbligati’ a mangiare carne contaminata, volutamente propinata nelle mense scolastiche per dimostrarne la sicurezza. Alimentata (ingiustamente) anche dalla lettura obbligatoria dei loro libri scolastici che riportavano informazioni fuorvianti relativamente ai rischi che correvano. Per oscurare i fatti legati alla decontaminazione e minimizzare, in modo ingiustificato, i pericoli. Un vero disastro.
