- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
“Quando chiedo alle persone perché rischiano la vita in questo modo, ricevo ogni volta la stessa risposta: ‘Non abbiamo alternativa’. Queste persone conoscono i pericoli, ma rischiano comunque. Ci dicono che preferirebbero annegare cercando sicurezza e libertà piuttosto che restare nei loro paesi d’origine o in Libia dove le loro vite non valgono la pena di essere vissute”, racconta un coordinatore dell’emergenza di Medici Senza Frontiere, sulla nave My Phoenix, nel rapporto Corsa a ostacoli verso l’Europa.
Rischi e pericoli, che corrono oltre un milione di persone in fuga da guerre e persecuzioni, dei quali i principali responsabili sono i governi europei e le loro politiche di deterrenza. Propongono un vuoto di alternative alle pericolose traversate del mare, recinzioni di filo spinato per chiudere i confini, continui cambiamenti nelle procedure amministrative e di registrazione, condizioni di accoglienza del tutto inadeguate, soprattutto in Italia e in Grecia, fino a veri e propri atti di violenza in mare e alle frontiere di terra.
Un approccio inumano e inaccettabile che ha conseguenze concrete sulla salute, sia fisica sia psicologica, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti. Una serie di patologie che, a detta degli operatori di Msf, poteva essere facilmente prevenuta se gli Stati europei avessero garantito un sistema di accoglienza adeguato (agli esseri umani) e un passaggio sicuro.
Come non è, invece, attraversare il Mediterraneo: il 2015, in seguito all’assenza, appunto, di alternative legali al viaggio su barconi sovraffollati guidati da trafficanti, è stato l’anno con la più alta mortalità nel Mare nostrum, in cui tremila e settecento persone circa hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa. Quelli che vi approdano, baciano terra. Esultano. Piangono di sollievo. Senza conoscere ancora, però, le condizioni di accoglienza. Precarie: bisogni elementari spesso negati e costante mancanza di informazioni.
Benvenuti in Italia. Che ha, sì, un sistema di accoglienza funzionante ma largamente insufficiente: centri sovraffollati con scarso accesso ai servizi essenziali – vedi assistenza medica, psicologica, supporto legale e amministrativo -, carenza di mediatori culturali qualificati e interpreti ad aiutarli a dare un senso a ciò che stanno vivendo. Invece, il più delle volte, più che rispondere immediatamente a bisogni medici e umanitari dei migranti, la priorità delle autorità è identificarli. Perché la rotta continua in terraferma. E le frontiere sembrano ingestibili. Aprirle e chiuderle (in modo incostante e repentino), senza alcuna pianificazione adeguata sembra l’unica via possibile per controllare il flusso di persone che cerca asilo nell’Europa settentrionale e occidentale. Decisioni unilaterali e mancanza di coordinamento tra gli Stati europei hanno generato pericolo per migliaia di loro: brutalmente fermati, bloccati in una terra di nessuno, con assistenza umanitaria e medica inesistente.
Perché la rotta continua in terraferma. E le frontiere sembrano ingestibili. Aprirle e chiuderle (in modo incostante e repentino), senza alcuna pianificazione adeguata sembra l’unica via possibile per controllare il flusso di persone che cerca asilo nell’Europa settentrionale e occidentale. Decisioni unilaterali e mancanza di coordinamento tra gli Stati europei hanno generato pericolo per migliaia di loro: brutalmente fermati, bloccati in una terra di nessuno, con assistenza umanitaria e medica inesistente.
Le conseguenze sulla salute sono quasi tutte legate al viaggio, tipo infezioni del tratto respiratorio, problemi ossei e muscolari e alla pelle, ma l’impatto più significativo ricade sulla salute mentale. Di fronte alla mancanza di assistenza da parte delle agenzie governative e alle violenze costanti, alle aspre condizioni alle frontiere e al senso di incertezza perenne, la risposta è un aumento degli attacchi di panico e di tendenze autolesioniste. Persone vulnerabili dalle quali gli Stati hanno urgenza di difendersi. Catastrofico fallimento dell’Unione europea.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
E’ emergenza. E rischia di diventare cronica. Fra provvedimenti in ordine sparso e misure addirittura controproducenti, l’inquinamento, nelle città italiane, dilaga. Polveri sottili - PM10 - minacciano brutalmente quarantotto su novanta città monitorate, con Frosinone in testa, seguita da Pavia, Vicenza, Milano e Torino, le quali hanno superato i trentacinque giorni permessi dalla legge. Polveri ancora più fini - PM2,5 - attaccano Monza, Milano e Cremona, che hanno oltrepassato i venticinque microgrammi per metrocubo.
Per non parlare, poi, di altri inquinanti atmosferici tipici degli ambienti urbani - ossidi di azoto e ozono troposferico - meno immediati nel determinare il superamento dei limiti consentiti, ma che, a lungo termine, mostrano criticità sostanziali: Genova e Rimini in testa, con Bologna, Mantova e Siracusa a seguire.
Qualche numero: nel 2012, l’Italia ha registrato il primato legato alle morti per PM2,5, circa cinquantanove mila casi, e, nel 2010, i costi collegati alla salute derivanti dall’inquinamento dell’aria si stimano tra i quarantasette e i centoquarantadue miliardi; confrontando il periodo dal 2009 al 2015 emerge che nei sette anni considerati, le città coinvolte siano prevalentemente sempre le stesse, ventisette città lo sono sistematicamente.
A farne le spese è soprattutto il Nord Italia ma è solo conoscendo profondamente l’origine dell’inquinamento atmosferico e le principali fonti che contribuiscono alla sua formazione che è possibile prospettare interventi adeguati. Traffico, industria, riscaldamento, agricoltura, responsabili delle emissioni di PM2,5 e di PM10, devono essere associati a fonti di inquinamento di origine secondaria, da non sottovalutare, ossia quelle che non lo generano per via diretta ma in seguito a reazioni chimiche tra le sostanze già presenti in atmosfera.
Un mix responsabile di patologie cardiovascolari e polmonari e a causa del quale ogni persona residente in Italia perde più di nove mesi di vita - quattordici mesi al Nord, sei mesi e mezzo al Centro, più di cinque mesi al Sud e alle Isole - e quelli che vivono nei centri urbani rinunciano a un anno e cinque mesi di vita. Polveri che non si vedono ma che, a lungo andare, si fanno sentire. Tanto quanto l’inquinamento acustico: nel 2014, i cittadini dei capoluoghi hanno presentato quasi duemila esposti (undici ogni centomila abitanti) e, secondo una stima internazionale, riportata da Legambiente nel dossier Mal’aria, l’Italia è seconda solo agli Stati Uniti, con Napoli al terzo posto dopo New York e Los Angeles.
Tanto quanto l’inquinamento acustico: nel 2014, i cittadini dei capoluoghi hanno presentato quasi duemila esposti (undici ogni centomila abitanti) e, secondo una stima internazionale, riportata da Legambiente nel dossier Mal’aria, l’Italia è seconda solo agli Stati Uniti, con Napoli al terzo posto dopo New York e Los Angeles.
Non solo fastidioso, il rumore contribuisce ad almeno diecimila casi di morti premature, ogni anno, dovute a coronaropatia e ictus e disturbi del sonno di otto milioni di individui, oltre a essere fisicamente stancante e alterare le funzioni degli organi. Il 90 per cento di questi effetti deriva dal traffico, sono quasi sei milioni i cittadini italiani esposti al rumore del traffico a livelli inaccettabili e quasi cinque milioni quelli disturbati durante la notte.
Chissà se utilizzando pneumatici silenziosi, come previsto dal regolamento del Parlamento europeo, in vigore da aprile prossimo, l’Italia diventerà più silenziosa.
- Dettagli
- Scritto da Administrator

di Tania Careddu
Vivono in un limbo di identità e di diritti pur non avendolo scelto: sono apolidi. Senza una cittadinanza, senza documenti, invisibili. Non ha la possibilità di studiare, di sposarsi, di lavorare. Perché hanno perso (o non hanno mai avuto) la cittadinanza del loro Paese di origine. Una condizione che in Italia, dove il riconoscimento del loro status è molto difficoltoso a causa di procedure inaccessibili, può diventare una condanna.
Riconoscere ufficialmente l’apolidia è una prima possibilità di accedere ai diritti fondamentali. Sebbene sia una condizione dolorosa, permette però di ottenere un’identità. Perché “in assenza di qualsiasi senso di appartenenza (…), senza alcun collegamento con uno Stato”, Nyima, artista tibetano, il primo apolide in Italia, si è “sentito perso e abbandonato”, ha raccontato in occasione della presentazione della campagna #nonesisto, lanciata dal Consiglio Italiano per i Rifugiati, al fine di sensibilizzare sugli ostacoli che incontrano le persone apolidi nella vita quotidiana, cioè l’impossibilità pratica di accedere a un riconoscimento legale della propria condizione.
Un’esistenza negata che rischia di tramandarsi di generazione in generazione, facendone pagare le conseguenze ai bambini. E’ il caso dei figli nati da famiglie sfollate dell’ex Jugoslavia che hanno ereditato lo status di apolidia dai genitori o si sono ritrovati con una nazionalità incerta. Di più: questa condizione di irregolarità sostanziale impedisce loro di acquisire la cittadinanza italiana. Ed è una situazione in cui potrebbero ritrovarsi anche i rifugiati che stanno sbarcando sulle coste dello Stivale. Vedi, per esempio, i figli nati da madri siriane rimaste sole, impossibilitate a trasmettere la cittadinanza ai loro figli a causa della legge siriana che lo permette solamente ai padri.
Per la direttrice del CIR, Fiorella Rathaus, “l’apolidia è in sé una condizione estremamente complessa e dolorosa, perché presuppone l’inesistenza, la negazione del legame più importante che unisce un individuo al suo Stato: la cittadinanza. Ma questa condizione può divenire addirittura drammatica se non riconosciamo a queste persone identità e diritti. Tutti gli esseri umani hanno diritto ad avere una nazionalità, e coloro che sono sprovvisti hanno comunque diritto a una protezione adeguata.
Per questo motivo - ha proseguito la direttrice del CIR ha dichiarato - con questa campagna vogliamo creare una sensibilità sul tema che possa favorire in Italia l’introduzione della legge sull’apolidia, uno strumento normativo in grado di garantire una procedura chiara, facilmente accessibile e fruibile per tutti coloro che hanno diritto a chiedere il riconoscimento di apolidia e che include una regolamentazione dei diritti della persona, durante l’iter e dopo l’eventuale riconoscimento”. Si stima che in Italia siano quindicimila e sono solo seicentosei coloro che hanno uno status di apolidia riconosciuto; provengono dalla ex Jugoslavia, dalla Palestina, dal Tibet, dall’Eritrea, dall’Etiopia e dai Paesi ex Urss. L’UNHCR valuta che ogni dieci minuti, nel mondo, nasca un bambino apolide.
Si stima che in Italia siano quindicimila e sono solo seicentosei coloro che hanno uno status di apolidia riconosciuto; provengono dalla ex Jugoslavia, dalla Palestina, dal Tibet, dall’Eritrea, dall’Etiopia e dai Paesi ex Urss. L’UNHCR valuta che ogni dieci minuti, nel mondo, nasca un bambino apolide.
Per quelli che nascono nel Belpaese, predisponendo l’acquisizione della nazionalità (italiana) senza introdurre come requisito il riconoscimento formale dell’apolidia dei genitori, si assicura loro il godimento dei diritti fondamentali e di una vita dignitosa. Speriamo che il Disegno di legge sul riconoscimento dello status di apolide, presentato in Parlamento a novembre scorso, sia sulla buona strada.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Metti un giorno qualunque del 2015. Metti il ‘palinsesto’ di radio, televisione, stampa e web. Risultato: le donne sono sottorappresentate. E, sebbene gli ultimi cinque anni abbiano segnato un lento miglioramento, diventando, da argomento per poche addette ai lavori a questione di dominio pubblico, l’informazione italiana è ancora lontana da una bilanciata rappresentazione di donne e uomini. Non giustificabile se si pensa ai significativi mutamenti intervenuti nella società del Belpaese durante l’ultimo decennio, in particolare quelli attinenti alla partecipazione politica delle donne e all’aumento, fra la popolazione femminile, delle competenze. Pressoché invisibili sui media, vecchi e nuovi.
Secondo il Global Media Monitoring Project 2015, curato in Italia dall’Osservatorio di Pavia, nei media tradizionali, nonostante a fare notizie continuino a essere gli uomini, la presenza femminile è cresciuta (con riserva): marginalizzate nelle notizie di politica, più considerate in quelle relative a salute e scienza; con una visibilità mediatica ‘anonima’, cioè indipendente dal loro ruolo sociale o dalle loro esperienze professionali e invitate molto poco a commentare un evento.
Ben una donna su quattro fa notizia in quanto vittima, il 28 per cento è presentato sulla base di una relazione famigliare - madre, figlia di, moglie - piuttosto che sulla base di un’identità autonoma e individuale. Più segnalate nell’informazione estera e locale che in quella nazionale dove, sebbene facciano meno notizia dei maschi, hanno maggiore probabilità di essere ritratte in fotografia sui quotidiani.
Quanto ai media digitali, internet risulta il mezzo di comunicazione, in assoluto, più inclusivo per le donne che sulle pagine on line monitorate raggiungono il 29 per cento: ci compaiono soprattutto come oggetto di notizia e come portavoce di enti, istituzioni, associazioni, partiti.
E chi decide le notizie? Le centosettantasei registrate nel corso della giornata monitorata (precisamente, il 25 marzo 2015) sono state scritte, redatte o presentate da duecentoquarantuno giornalisti, il 36 per cento dei quali di sesso femminile, una proporzione prossima alla componente femminile reale nella categoria professionale (l’INPGI stima il raggiungimento del 40 per cento delle donne giornaliste). Ma, nonostante ciò, non si può certamente considerare gender-sensitive l’agenda del giorno: le notizie dedicate alle donne, infatti, hanno coperto solo l’8 per cento dell’informazione.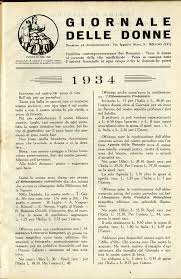 Giornaliste giovani, di una fascia d’età compresa fra i trentacinque e i quarantanove anni, quelle dei vecchi mezzi di comunicazione ma invisibili nell’informazione digitale la quale, però, è quella più attenta a questioni di pari opportunità ma, paradossalmente, che più di tutte tende a rinforzare gli stereotipi attraverso il linguaggio, le immagini o la costruzione delle notizie, raccontando un mondo ancora molto convenzionale rispetto alle relazioni di genere.
Giornaliste giovani, di una fascia d’età compresa fra i trentacinque e i quarantanove anni, quelle dei vecchi mezzi di comunicazione ma invisibili nell’informazione digitale la quale, però, è quella più attenta a questioni di pari opportunità ma, paradossalmente, che più di tutte tende a rinforzare gli stereotipi attraverso il linguaggio, le immagini o la costruzione delle notizie, raccontando un mondo ancora molto convenzionale rispetto alle relazioni di genere.
Conseguenze: la continua sottorappresentazione delle donne nei media, in particolare in quelli tradizionali, da un lato rispecchia una società non ancora in grado di includere a pieno titolo le donne, specialmente nella vita pubblica, dall’altro, questa sottorappresentazione contribuisce a consolidare un’attitudine culturale incapace di promuovere una conoscenza e un approccio bilanciato alle problematiche di genere. Tirando le somme, “l’immaginario collettivo promosso dai media italiani relega le donne a un limitato numero di ruoli convenzionali: la donna come oggetto sessuale e la donna come madre casalinga”. Che negazione.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Vincenzo Maddaloni
di Vincenzo Maddaloni
BERLINO. Papa Francesco ricorda ai fedeli che, «non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione». Sicuramente qui in Germania la confusione non c'è, e da anni. A volte, è sufficiente anche il varo di una legge per misurare le distanze culturali tra le nazioni. Quella sulle Unioni civili ci separa dai tedeschi anni luce, conferma che ci sono concezioni diverse d'intendere la democrazia. Il Belpaese non ci fa una bella figura. Come sempre, o quasi.
I tedeschi hanno da quindici anni la legge sulle Unioni civili. La Eingetragene Lebenspartnerschaft (così in tedesco) venne approvata nel 2001 dal Governo Rosso-Verde di Schöder e Fischer, e nel corso degli anni ha subito molte modifiche grazie alla Corte Costituzionale e alla consapevolezza tedesca che la politica deve favorire e sostenere i cambiamenti sociali. Infatti, la legge è sempre cambiata in meglio, ampliando ogni volta i diritti delle coppie omosessuali.
In Italia invece, soltanto giovedì 28 gennaio 2016 tornerà in aula il disegno di legge sulle Unioni civili, la Cirannà Bis, dal nome della senatrice Pd Monica Cirinnà che l'ha promossa. Le Unioni civili sono un diritto riconosciuto in gran parte dei Paesi dell’Unione Europea. Alcuni dei paesi comunitari, come la Germania, arrivano a equiparare le unioni civili al matrimonio. Insomma dei ventotto stati membri della UE, quelli che ancora non hanno legiferato in merito sono: Bulgaria, Cipro, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, e naturalmente l’Italia.
Sicché se il Cirannà Bis non sarà approvato, l’Italia continuerà ad essere uno dei pochi Stati europei che non riconoscono in alcun modo le famiglie di persone omosessuali. I segnali che possa accadere ci sono, perché proprio l'altro giorno il vescovo Nunzio Galantino, segretario della Cei, ha nuovamente criticato la possibilità di adozione per le coppie gay. E così la sentenza dell'autorevole prelato diventa una benedizione per il raduno - il prossimo 30 gennaio in Piazza san Giovanni a Roma - del Family Day che è organizzato da molte associazioni di cattolici conservatori che al grido di “non toccate i bambini”, si oppongono, appunto, al riconoscimento delle Unioni civili.
Per la cronaca, risale al 1986 la prima proposta di legge sul riconoscimento delle coppie di fatto. Dopo trent'anni di disegni di legge nel vano tentativo di riportarli in esame nel Parlamento Italiano, finalmente il 28 gennaio si voterà sulle modifiche del cosiddetto Cirinnà Bis, che riguardano la distinzione della regolamentazione tra le coppie civili di diverso orientamento sessuale. Per la prima volta s’inserisce nell’ordinamento giuridico italiano, l’istituzione delle Unioni civili per quelle formate da persone dello stesso sesso che assumeranno la definizione di coppie di «specifica formazione sociale» cancellando così ogni riferimento al matrimonio.
Va pure precisato che la legge Cirinnà, nella sua ultima versione, stabilisce che le coppie dello stesso sesso unite civilmente non potranno adottare bambini che non siano già figli di uno dei componenti della coppia. E quindi tutta la discussione attorno al cosiddetto “utero in affitto” che la legge Cirinnà si appresterebbe “a promuovere”, come i suoi avversari sostengono si fonda su premesse che non esistono, poiché il ddl non dicendo nulla a riguardo, lascia quindi in vigore i divieti della legge 40 del 2004. Concludendo, non essendoci alcuna equiparazione con il “matrimonio”, le coppie di «specifica formazione sociale» hanno soltanto la possibilità di accedere a una adozione particolare: l’adozione del figlio dell’altro componente della coppia, compiuta con il consenso di entrambi i genitori, oppure la possibilità di adottare un minore che ha un solo genitore, quello interno all’Unione civile, perché l’altro è irreperibile, ignoto, defunto o ritenuto incapace di esercitare la potestà genitoriale, cioè non idoneo ad occuparsene.
Concludendo, non essendoci alcuna equiparazione con il “matrimonio”, le coppie di «specifica formazione sociale» hanno soltanto la possibilità di accedere a una adozione particolare: l’adozione del figlio dell’altro componente della coppia, compiuta con il consenso di entrambi i genitori, oppure la possibilità di adottare un minore che ha un solo genitore, quello interno all’Unione civile, perché l’altro è irreperibile, ignoto, defunto o ritenuto incapace di esercitare la potestà genitoriale, cioè non idoneo ad occuparsene.
Tutt'altra aria spira in Germania. Ancora una volta il sano pragmatismo tedesco non soltanto nei contenuti ma anche nei metodi ha dato i suoi frutti, che aiutano anche a capire il baratro che separa il Belpaese dalla Germania.
Perché i tedeschi hanno pensato davvero a tutto. Da due anni hanno pure una legge che prevede l'equiparazione del trattamento fiscale tra famiglie omo e etero. Essa ha comportato una revisione complessiva della fiscalità delle famiglie tutte, distinguendo solo le famiglie con o senza figli. Così operando è nato un modello fiscale che ha arricchito le entrate allo Stato tedesco e ampliato i diritti delle coppie omosessuali.
Ritorniamo in Italia. Le notizie della vigilia del voto parlano di circa seimila emendamenti sono stati presentati al disegno di legge Cirinnà. La stragrande maggioranza - circa cinquemila - sono stati presentanti dalla Lega Nord e sono in gran parte emendamenti studiati soltanto per fare ostruzionismo alla legge. Forza Italia ne ha presentati altri 300 e il PD in tutto circa 60, di cui una decina - nove,secondo il Corriere della Sera - sono stati presentati dal gruppo di cattolici interno allo stesso PD ostile alla nuova legge.
Secondo Rainews, il nuovo emendamento presentato dai Cattdem stabilisce che il giudice del tribunale dei minori potrà disporre “verifiche e indagini” dopo la richiesta di adozione inoltrata da parte dell’unione civile di persone dello stesso sesso. Una fonte di Repubblica precisa che in materia di stepchild adoption «non c’è alcun automatismo».
Quel che si fa fatica a capire è perché, una volta chiarito che le Unioni civili non debbono definirsi matrimonio bensì «specifica formazione sociale» e quindi - lo ripeto ancora - non possono adottare bambini che, non siano già figli di uno dei componenti della coppia, non si capisce appunto perché l'approvazione del Cirinnà Bis debba creare tanti scrupoli ai parlamentari del Pd, da indurre il Partito a lasciare ai propri parlamentari «libertà di coscienza», senza dare alcuna indicazione di voto. Si tenga a mente poi che la votazione si svolgerà a scrutinio segreto.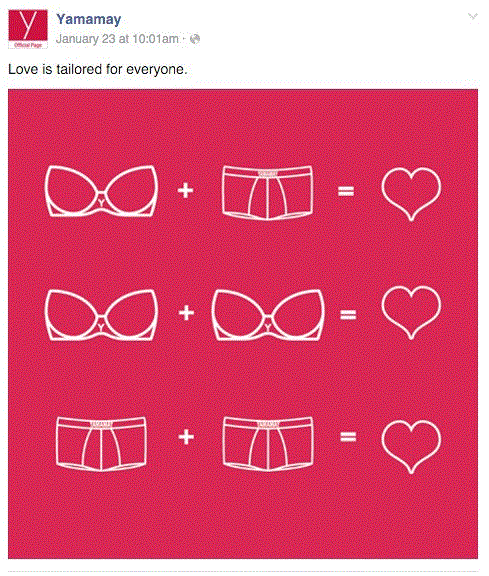 E' una decisione anche questa che mostra l'assoluto scollamento del Pd dalla società civile ogni volta che c'è da votare una legge che contrasta con le posizioni delle gerarchie cattoliche. Dimenticando che in una democrazia i partiti nascono perché si confrontino le opinioni.
E' una decisione anche questa che mostra l'assoluto scollamento del Pd dalla società civile ogni volta che c'è da votare una legge che contrasta con le posizioni delle gerarchie cattoliche. Dimenticando che in una democrazia i partiti nascono perché si confrontino le opinioni.
Il compito del partito è raccogliere i punti di vista, esprimere il sentimento della gente e, in casi come questi, dove in discussione è il principio costituzionale della libertà di religione e della separazione tra Stato e Chiesa, esso deve spiegare bene il proprio punto di vista e suggerire da che parte conviene stare, con quelle che si chiamano “indicazioni di voto”. Sicché lasciare ai propri parlamentari «libertà di coscienza» significa svilire profondamente la ragione di essere dei partiti.
Viene da chiedersi da che parte stanno questi parlamentari del Partito democratico che dichiarano con enfasi che l’Unione civile «non è un matrimonio», che «il matrimonio è una cosa diversa», che i bambini ne «soffriranno», come sostiene il Family Day assieme alla Chiesa tutta. Da che parte stanno? Da quella degli ipocriti, sicuramente.
