- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Diminuiscono ma aumenta il loro reddito: i pensionati, in Italia nel 2014, sono sedici milioni e poco più e la loro retribuzione media annua lorda è pari a circa diciassette mila euro. Aumentano gli ultrasessantaquattrenni, la cui elevata incidenza spiega il divario di istruzione rispetto al resto della popolazione: quasi la metà dei pensionati non ha un titolo di studio o possiede, al più, la licenza elementare, appena un quarto ha conseguito la licenza media superiore.
Se il pensionato possiede, invece, un titolo di studio corrispondente alla laurea, il suo reddito lordo è più che doppio rispetto a quelli sopracitati. Penalizzate come sempre le donne, che costituiscono quasi il 53 per cento della popolazione pensionata; sono più anziane - tre su dieci ultraottantenni - e ricevono mediamente importi di circa sei mila euro inferiori a quelli maschili.
Quasi la metà dei pensionati risiede nelle regioni del Nord, dove sono più frequenti le pensioni di vecchiaia, e poco meno di un terzo nel Mezzogiorno, in cui sono più elevate le quote dei percettori di trattamenti assistenziali o di invalidità ordinarie e dove l’importo netto mediamente percepito è del 15 per cento inferiore a quello del resto del Paese; ma a percepire i redditi pensionistici più alti sono gli anziani del Centro, mentre nelle Isole è forte l’incidenza delle pensioni sociali, cioè di quelle introdotte nel 1969 per garantire un reddito pensionistico minimo anche in assenza di pregresso contributo o di specifiche patologie.
E se al Settentrione i pensionati vivono per lo più da soli, nel Mezzogiorno sono in coppia e al Centro risiedono in famiglie di altra tipologia. Le quali, si stima, siano circa dodici milioni e quattrocentomila, più o meno una su due: per quasi sette milioni e ottocentomila di queste, le pensioni dei ‘nonni’ rappresentano oltre i tre quarti del reddito familiare a disposizione e per il 26,5 per cento è l’unica fonte di reddito.
Nonostante il valore medio del reddito delle famiglie con pensionati sia più basso di circa duemila euro rispetto a quello delle restanti famiglie, il rischio di povertà delle prime è ridotto rispetto a quello delle seconde. Perché la presenza di trasferimenti pensionistici rappresenta un’importante rete di protezione del disagio economico, tant’è che il contributo di un pensionato all’interno di nuclei famigliari vulnerabili, per esempio quelli di genitori soli, consente di dimezzare il rischio di povertà. Se poi alla pensione si cumulano entrate provenienti da attività lavorativa, il rischio si riduce di oltre dieci punti percentuali e di sette punti percentuali qualora fosse presente il reddito di un altro componente della famiglia occupato. Le famiglie di pensionati del Sud e delle Isole vivono un rischio di povertà triplo di quello delle stesse famiglie del Nord e doppio di quelle del Centro.
Se poi alla pensione si cumulano entrate provenienti da attività lavorativa, il rischio si riduce di oltre dieci punti percentuali e di sette punti percentuali qualora fosse presente il reddito di un altro componente della famiglia occupato. Le famiglie di pensionati del Sud e delle Isole vivono un rischio di povertà triplo di quello delle stesse famiglie del Nord e doppio di quelle del Centro.
Un rischio che mette in fuga i ‘capelli grigi’: secondo i dati INPS, che ha curato anche la ricerca “Le condizioni di vita dei pensionati”, negli ultimi cinque anni sono espatriati più di sedicimila e cinquecento pensionati, di cui cinquemila e trecento solo nel 2014. Da Tenerife a Lanzarote, dal Portogallo alla Bulgaria, luoghi in cui il costo della vita è il 40 per cento in meno di quello in Italia. In cerca di una vecchiaia più agiata, qualità dei servizi, sicurezza. E, perché no, di un clima migliore.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Chi ha il potere e la capacità di influire sulle attività di Camera e Senato? Una manciata di parlamentari. Mettendo a confronto novecentocinquantuno parlamentari, contando circa ventiseimila e cinquecento votazioni elettroniche, spulciando più o meno quarantacinquemila atti non legislativi e cinquemila e settecento disegni di legge presentati, Openpolis, nel minidossier “Indice di produttività parlamentare 20152, lo conferma.
Aggiungendo che quelli con incarichi istituzionali battono tutti: rispetto ai quattrocentocinquantotto deputati e ai centosettantasei senatori senza incarichi, il loro peso è notevolmente più consistente. Se il 66,35 per cento dei deputati e il 62,93 per cento dei senatori è sotto la media di produttività, il potere di contribuire (determinare) alle attività dell’istituzione in cui siede è in mano al 3 per cento dei deputati e solo in cinque occupano la cima della classifica.
Tra i senatori, i soggetti più influenti corrispondono al 5,30 per cento e solo in sei trainano la lista dei più produttivi. Capigruppo di aula, di commissione e presidente di commissione hanno una produttività media fino a due volte superiore a quella del deputato ‘semplice’.
E, in questo caso, non serve la buona volontà per stabilire la produttività di un parlamentare. Cioè, non è produttivo il primo firmatario di innumerevoli ddl ma quello che porta a casa una legge e nemmeno chi protocolla centinaia di interrogazioni ma colui che riesce a ottenere una risposta da parte del ministro competente.
Non aiuta neppure la presenza per ottenere la nomination di produttivo perché la partecipazione alle votazioni elettroniche ha una portata decisamente inferiore rispetto all’incisività degli incarichi istituzionali e dei ruoli di potere all’interno dei gruppi: fra chi è stato presente oltre il 90 per cento delle volte, solo il 20 per cento dei deputati e il 43 per cento dei senatori supera la media della produttività. Fra i presenti, appunto, il più produttivo è l’onorevole della Lega Nord, Stefano Borghesi, e il senatore del Partito Democratico, Giorgio Pagliani. Stesso discorso all’interno dei gruppi parlamentari: alla Camera dei deputati, il 70 per cento ha la maggior parte dei membri ‘scansafatiche’ e al Senato della Repubblica, il 90 per cento. Pollice su, sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama, per la Lega Nord che annovera il 75 per cento dei membri sopra la media, portando alla ribalda una dinamica che fa spiccare chi, pur non sostenendo il governo, si è reso disponibile a contribuire a determinati provvedimenti, lasciando sullo sfondo i gruppi di maggioranza.
Stesso discorso all’interno dei gruppi parlamentari: alla Camera dei deputati, il 70 per cento ha la maggior parte dei membri ‘scansafatiche’ e al Senato della Repubblica, il 90 per cento. Pollice su, sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama, per la Lega Nord che annovera il 75 per cento dei membri sopra la media, portando alla ribalda una dinamica che fa spiccare chi, pur non sostenendo il governo, si è reso disponibile a contribuire a determinati provvedimenti, lasciando sullo sfondo i gruppi di maggioranza.
In fondo alla classifica della Camera, Scelta Civica, Partito Democratico e Forza Italia, quattro volte inferiore alla media del primo classificato; alla base di quella del Senato, Conservatori e Riformisti, Alleanza Liberalpopolare Autonomie, Grandi Autonomie e Libertà, tre volte inferiore alla media del gruppo in testa. Nella top ten della produttività alla Camera, l’80 per cento dei deputati fa parte dell’opposizione e al Senato, il 50 per cento.
Una mera curiosità: a Palazzo Madama, tre dei cinque senatori più produttivi sono donne. Pari produttività?
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Complessità delle prassi burocratiche, tempi biblici di realizzazione del progetto, alti costi, trasparenza del processo. Sono le criticità, secondo quanto riporta il documento del CARE (Coordinamento associazione famiglie adottive e affidatarie in rete), Dossier Adozioni. Stato dell’arte sulle adozioni nazionali e internazionali dal punto di vista delle famiglie adottive italiane, con le quali le famiglie adottive devono fare i conti.
Andiamo con ordine: il decreto di idoneità per procedere all’adozione è a discrezione del tribunale dei minorenni competente viene rilasciato in un periodo che varia da sei a dodici mesi e il tempo medio del percorso adottivo, dal conferimento dell’incarico all’ente competente fino al rilascio dell’autorizzazione all’ingresso (per le adozioni internazionali) del minore, si è stabilizzato intorno ai due anni.
Ma pare che, per molte coppie, i tempi d’attesa siano molto più dilatati. Causa il complicarsi delle tempistiche dopo l’ottenimento del decreto di idoneità: rallentamenti, blocchi e congelamenti hanno costretto varie coppie a cambi di direzione o ad attese protratte. Che diventano solitudine, ostacoli e traversie. Dati alla mano, più del 30 per cento di loro ha aspettato oltre ventiquattro mesi per portare a termine il percorso e il 16 per cento più di tre anni.
La mancanza di informazioni, poi, gravosa di per sé dietro tanti aspetti, diventa foriera di ulteriori difficoltà quando si tratta dello stato di salute del bambino: documentazione sanitaria carente e poco attendibile, certificati (quando recuperati) di difficile interpretazione, dossier medici scarni, cartelle cliniche nelle quali appaiono i sintomi piuttosto che la diagnosi. Cosicché alcune situazioni vengono accertate solo all’arrivo: nel 2012, sono stati quattrocentoventinove i bambini arrivati in Italia con bisogni speciali, il 13,4 per cento degli ingressi, di cui centottantacinque fra i cinque e i nove anni.
I costi sono eccessivi e non sempre giustificabili; fino al “sospetto di lucro”, se si pensa che negli ultimi dieci anni i costi per l’adozione internazionale sono andati progressivamente crescendo, arrivando a toccare cifre che vanno dai venti ai quarantamila euro.
E successivamente? Dopo l’adozione, spesso, è confusione e mancanza di mezzi e risorse: si scopre che la preparazione (quando viene effettuata) era solo sulla ‘carta’, le informazioni erano ridotte, la società può rivelarsi meno accogliente di quanto si era pensato, le criticità dei figli possono essere davvero ampie e non di rapida evoluzione e i genitori stessi non sono come immaginavano di essere. Una fase difficile, quella del post adozione, che, negli ultimi cinque anni nel Belpaese, è stata trascurata a causa del disinvestimento diffuso che ha coinvolto la rete dei servizi sociali.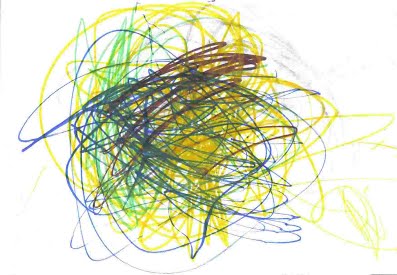 Di quei servizi che, in passato più che oggi, si facevano carico dei nuovi piccoli arrivati solo nelle fasi precedente e immediatamente successiva all’adozione e che, attualmente, alla luce dei cambiamenti che l’adozione ha subìto in questi ultimi anni, devono invece tenere in considerazione bisogni che richiedono valutazione e sostegno anche negli anni successivi al primo anno post adozione.
Di quei servizi che, in passato più che oggi, si facevano carico dei nuovi piccoli arrivati solo nelle fasi precedente e immediatamente successiva all’adozione e che, attualmente, alla luce dei cambiamenti che l’adozione ha subìto in questi ultimi anni, devono invece tenere in considerazione bisogni che richiedono valutazione e sostegno anche negli anni successivi al primo anno post adozione.
Sarebbe doveroso investire risorse maggiori, visto che le coppie italiane sono in prima linea rispetto a quelle di tanti altri Paesi relativamente all’accoglienza di bambini più grandi e di quelli con bisogni speciali.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
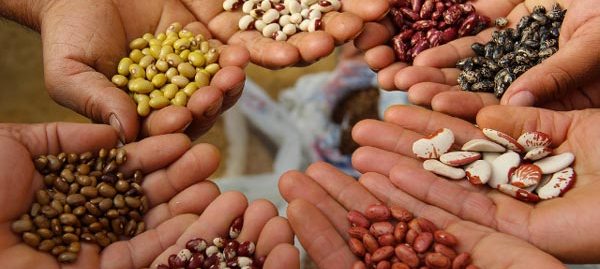 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Il mondo è denutrito. E gli italiani sono scarsamente nutriti di informazioni sulla fame nel mondo. Anche dopo Expo Milano 2015. Doveva essere un momento (?) di riflessione collettiva sul tema legato all’alimentazione nei termini della fame nell’intero pianeta, delle sue cause e delle possibili soluzioni, ma pare sia stato così solo in minima parte. Almeno stando alle conoscenze degli italiani, rilevate dall’indagine condotta da Mani Tese, "Il pianeta non nutrito", nemmeno Expo 2015 - che per la maggior parte dei connazionali è stata una grande fiera per promuovere prodotti, marchi e aziende oltre che una sorta di menu globale - è servito a informare sulla diffusione della fame, che pure risulta la priorità nell’agenda personale per l’umanità.
Ignorano che ottocento milioni di persone la soffrono ma che più di due miliardi siano in sovrappeso. E invece, il 41,5 per cento di loro è convinto che il problema della fame nel mondo sia, numericamente, prevalente su quello del sovrappeso. Ammesso che sappiano che la comunità internazionale si è data, per il 2030, l’obiettivo di annullare la fame a livello globale, la parte più consistente della popolazione del Belpaese si aspetta una riduzione moderata o addirittura nulla.
E quella minima parte che pensa che, da qui a quindici anni, la fame possa essere sostanzialmente debellata, nutre, però, una visione distorta sulle ipotesi di risolvibilità. Ossia: invece di pensare che la Terra non sia in condizioni di nutrirci tutti con gli attuali sistemi di produzione e sono necessarie innovazioni tecnologiche diffuse, unite a una forte liberalizzazione degli scambi commerciali tra i paesi per aumentare la disponibilità di cibo, idealizzano (erroneamente) un pianeta in grado di fornire cibo a tutti anche a fronte di una crescita (che ci faccia toccare i dieci miliardi di abitanti del pianeta) della popolazione mondiale e che la piaga della fame sia dovuta alle differenza, alla disparità di distribuzione della ricchezza e dell’accesso al cibo.
Per tutti, la fame nel mondo - sebbene sia considerato un fenomeno multicausato, con guerre e conflitti interni ai paesi, sfruttamento dei terreni hic et nunc, tecniche produttive, strumenti e infrastrutture inefficaci in molte aree del mondo, fra le ragioni più considerate - è causata da un sistema economico che favorisce una parte del globo rispetto alle altre. Ignote le proposte elaborate (per ridurla) tra i decisori mondiali - tipo utilizzo di diserbanti, OGM, che contribuiscono alla resa dei terreni - e le diciotto soluzioni. Quella che potrebbe caratterizzare il futuro del pianeta nei prossimi decenni è quella meno nota agli italiani, cioè quella associabile alle teorie liberali: favorire un’alimentazione omogenea a livello mondiale, diffondere l’uso di sementi nuove e OGM, liberalizzare i mercati, ribassare i prezzi al consumo dei prodotti, impedire il land grabbing, avere sistemi decisionali democratici che coinvolgano produttori e consumatori, evitare il vantaggio dei ‘grandi’ sui ‘piccoli’ negli scambi commerciali e bloccare la speculazione finanziaria.
Quella che potrebbe caratterizzare il futuro del pianeta nei prossimi decenni è quella meno nota agli italiani, cioè quella associabile alle teorie liberali: favorire un’alimentazione omogenea a livello mondiale, diffondere l’uso di sementi nuove e OGM, liberalizzare i mercati, ribassare i prezzi al consumo dei prodotti, impedire il land grabbing, avere sistemi decisionali democratici che coinvolgano produttori e consumatori, evitare il vantaggio dei ‘grandi’ sui ‘piccoli’ negli scambi commerciali e bloccare la speculazione finanziaria.
Sarà perché è un problema sempreverde e perciò, paradossalmente, silente o perché è geograficamente lontana da noi (secondo la logica della vicinanza che rende sensibili ai fatti), ma sta di fatto che la denutrizione ha l’aspetto di una crisi dimenticata. Tra le nostre portate.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
L’anagrafe scolastica (peraltro, ancora incompleta) e lo stanziamento di fondi (quattro miliardi di euro dal 2014 a oggi) per la messa in sicurezza degli edifici, non sono bastati. In media, una scuola su due, nei capoluoghi del meridione e delle isole, necessita ancora di interventi urgenti di manutenzione. Nel sud e nelle isole non esiste nemmeno una scuola costruita secondo i criteri della bioedilizia (sebbene sia significativa la percentuale di quelle dotate, invece, di impianti per la produzione di energie rinnovabili) e solo il 7 per cento al Sud e l’1,1 per cento nelle isole utilizza fonti di illuminazione a basso consumo, a fronte di una media nazionale del 31,7 per cento.
Negli ultimi cinque anni, solo il 17 per cento degli istituti è stato interessato dagli interventi di manutenzione ordinaria: le strutture bisognose passano dal 32,5 per cento dello scorso anno al 39,1 per cento di questo; il 73 per cento è sprovvisto di certificazioni (a parte quella igienico-sanitaria) e il 20 per cento non ha ancora provveduto a dotarsi di impianti elettrici a norma.
Un dato, però, accomuna le scuole di tutta Italia: la vetustà degli edifici, per cui su seimila e trecentodieci scuole, circa il 65 per cento è stato costruito prima dell’entrata in vigore della normativa antisismica del 1974, mentre solo il 9,3 per cento tra il 1991 e il 2014. Flette, rispetto allo scorso anno e dopo anni di trend di crescita, il dato relativo agli edifici a norma, accompagnato a un calo rilevante degli interventi previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Peggiorano gradualmente, in termini di qualità e sostenibilità, anche i due servizi principali: mensa e trasporto. Se nel 2014, erano l’8,5 per cento i pasti interamente bio, oggi sono il 5,3 per cento; se le mense scolastiche che servivano acqua dal rubinetto erano il 70,8 per cento nel 2010, attualmente sono diminuite al 56 per cento. Se la disponibilità di scuolabus, nel 2010 era del 32,6 per cento, oggi è del 25,8 per cento, con una flessione nelle scuole del Nord, del Sud e delle Isole.
Ancora carenti pure le condizioni strutturali che danno autonomia di mobilità ai ragazzi, dalle piste ciclabili nei pressi delle scuole, presenti in meno del 10 per cento dei plessi scolastici, alle transenne parapedonali presenti in poco più del 7 per cento. Diminuiscono le scuole con spazi verdi e giardini e quelle con aree per lo sport. Aumentano le strutture con biblioteche. Prosegue il trend positivo delle azioni di bonifica dall’amianto: Trieste capofila, Vercelli il capoluogo dove sono più presenti le scuole a rischio. E, sebbene nessun dato scientifico evidenzi in modo assoluto il rischio associato all’esposizione alle onde ad alta frequenza, i dati riportati dal Rapporto di Legambiente Ecosistema Scuola, evidenzia un’altra criticità: una crescente percentuale di scuole a rischio elettromagnetico, dato che il 34,6 per cento di scuole ospita impianti wi-fi, il 15 per cento si trova in prossimità di stazioni radio base per la telefonia mobile e il 3,7 per cento vicine a elettrodotti.
E, sebbene nessun dato scientifico evidenzi in modo assoluto il rischio associato all’esposizione alle onde ad alta frequenza, i dati riportati dal Rapporto di Legambiente Ecosistema Scuola, evidenzia un’altra criticità: una crescente percentuale di scuole a rischio elettromagnetico, dato che il 34,6 per cento di scuole ospita impianti wi-fi, il 15 per cento si trova in prossimità di stazioni radio base per la telefonia mobile e il 3,7 per cento vicine a elettrodotti.
Regioni - Abruzzo e Sardegna in testa - e Comuni dove l’esigenza di intervenire è altamente rilevante, mostrano, di contro, un forte disinteresse a stanziare fondi. Trento, Bolzano e Reggio Emilia, sono le città più virtuose. Como e Verona, i comuni che riescono a coprire il 100 per cento dei consumi con le energie rinnovabili. Brindisi, L’Aquila e Pisa, le mense più bio. Lucca, Macerata, Siena, le città che garantiscono lo scuolabus a tutte le strutture scolastiche. Buone scuole dalle quali non si finisce mai di imparare.
