- Dettagli
- Scritto da Administrator
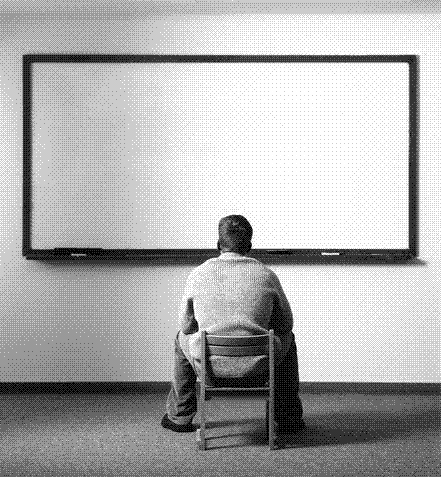 di Giovanni Cecini
di Giovanni Cecini
Internet, videofonini, digitale terreste e satellitare: viviamo ormai nella società della comunicazione totalizzante. Nessuno può dire più di non essere informato o di non poter partecipare anch’egli al mondo della divulgazione attraverso Youtube o altri pirotecnici mezzi mediatici. Ovviamente ciò è valido solo nella parte dove la tecnologia esiste ed è fruibile come bene prevalentemente superfluo, avendo già risolto problemi come la fame, la sete, l’igiene e la difesa dagli agenti atmosferici. Premesso questo, pare quasi scontato che nel nostro Paese, a titolo d’esempio, vista la grande diffusione d’innumerevoli metodi di divulgazione, dalle apparecchiature elettroniche più sofisticate alle ormai primitive carta e penna, ciascun individuo possa parlare, ascoltare, leggere e comprendere notizie e dati resi dagli altri.
Se crediamo questo, incappiamo in un grave errore, perché se facciamo i conti con le competenze base degli italiani, si scopre che una parte considerevole degli abitanti della Penisola è - secondo i canoni odierni - completamente analfabeta. Circa il 15% saprà anche scrivere o leggere, ma ciò non è sufficiente affinché esso possa comprendere un testo o sappia riprodurre per iscritto il suo pensiero. Questo elemento non dovrebbe apparire sorprendente se circa il 36% possiede solo un titolo di licenza elementare o neppure quello, e se il tasso dei laureati non arriva al 10%.
La notizia è sconcertante, ma in un momento storico in cui l’attenzione generale è rivolta alla crisi economica, al sempre più schizofrenico dibattito politico, ai problemi di ordine pratico e materiale, una calamità sociale di questo tipo passa in sordina e suscita poca considerazione. Tullio De Mauro, insigne studioso di lingue e linguaggi, lancia in toni molto preoccupati l’allarme, prefigurando uno scenario dove solo il 20% della popolazione nazionale sarebbe capace di apprendere o esprimersi in maniera adeguata attraverso la forma scritta dell’italiano.
Le colpe e le origini di questo dramma culturale e umano sono molteplici e ricche di significato antropologico: dall’uso distorto delle forme lessicali negli sms o nelle rapide risposte delle chat, fino all’eccessivo impiego di formule derivanti dall’inglese o da qualsiasi altra spuria variante linguistica. Ecco quindi come, non solo l’italiano “vivo” cambia pelle, ma gli italiani in generale perdono l’uso della propria lingua sia nel lessico, sia nelle costruzioni verbali.
Di fronte quindi all’ardore orgoglioso dei dialetti come forma demagogica di cultura locale, l’idioma nazionale è vittima di un analfabetismo funzionale o di ritorno dalle proporzioni impressionanti. A tutto ciò si aggiunge che la scuola, come l’università, prediligono in modo prevalente il canale orale. La gran parte degli studenti, che frequentano gli atenei, s’imbattono nell’elaborazione di un testo scritto complesso, solamente al momento della tesi di laurea, riducendo gran parte delle prove intermedie con carta e penna a una scelta multipla, importata direttamente dai quiz televisivi.
Tutto questo apparato si va a sommare alla già consistente presenza sul suolo nazionale di numerose comunità straniere, che coltivano i propri idiomi alloglotti, ma si trovano nella quotidianità ad approcciarsi con un mondo linguistico senza regole e dove l’incomunicabilità divampa oltre qualsiasi confine. In queste condizioni sembrerebbe quindi ipocrita e inutile richiedere un esame di lingua, storia e cultura nazionale agli stranieri, per ottenere la cittadinanza, quando la stragrande maggioranza degli italiani sono privi di una solida base d’identità comune in fatto di comunicazione.
Per chi ha i capelli grigi, forse tornano alla mente le lezioni del maestro Alberto Manzi e del suo “Non è mai troppo tardi” che, in una televisione in bianco e nero, insegnava ad adulti senza preparazione scolastica, i rudimenti di educazione sociale attraverso la lingua. In un Paese, come l’Italia, che è regredito culturalmente sotto ogni punto di vista, tale esperimento tornerebbe d’attualità, in barba a tutta quella serie di pantomime pseudo culturali, più vicine a un ciarpame mediatico, che a vera diffusione del sapere. Come si dice in questi casi, meglio ridere che piangere. Per questo ci possiamo consolare con la spassosissima e senza senso lettera di Totò e Peppino: «Abundantis abundantum… che poi dicono che siamo provinciali, siamo tirati».
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Lo scorso gennaio, a margine di una conferenza dal titolo "Chiesa in Rete 2.0", il portavoce della CEI, don Domenico Pompili, emetteva il dubbioso verdetto della confessione che egli rappresenta sui "social network". Niente anatemi questa volta, ma un atteggiamento cauto, suggerito dal presunto rischio che gli utenti di Facebook, Twitter e simili si ritrovino nella paradossale condizione di "individualismo interconnesso" (concetto formulato dal sociologo Manuel Castells per descrivere quelle persone che trascurano le relazioni personali con i loro simili, pur vantandone numerose e complesse di tipo elettronico-virtuale).
I (legittimi) dubbi della Chiesa, però, hanno per oggetto i soli social network realizzati dagli altri; sembrerebbe di capire che, per la Chiesa, essi risulterebbero "pericolosi" se impiegati per fare amicizia, condividere interessi, scambiare informazioni, mentre la benedizione è assicurata su quelli, anzi su quello, che viene impiegato per pregare. E' questo infatti lo scopo principale di Prex-Communion, il "social network della preghiera" lanciato lo scorso 19 novembre in occasione del convegno "Fede e Tecnologia", tenutosi nel palazzo apostolico di Loreto - presenti il "padrone di casa" Monsignor Tonucci (il quale, a mo' di chiusura dei lavori, benedice tutti i partecipanti); la giornalista berlusconiana Cesara Buonamici; il vaticanista del Corriere della Sera Luigi Accattoli; rappresentanti della società informatica che ha realizzato il prodotto (la EDE, Euro Digital Equipment, che fa capo al gruppo More Technologies, di cui è stato impossibile reperire notizie aggiornate); più due alti dirigenti della Saatchi & Saatchi Italia, società cui è stata affidata la cura dell'immagine della piattaforma e la relativa campagna pubblicitaria.
Il nome del social network della Chiesa, invero non molto sexy, è emblematico della immensa distanza culturale che separa il milieu dal committente: Prex sta per "preghiera" in latino, mentre community (ossia "gruppo di persone accomunate dagli stessi interessi che corrispondono tra loro attraverso una rete telematica") viene miracolosamente promosso a "communion" (cioè, questa volta in inglese; comunione, ovvero il corpo dei cattolici.
Per inciso, la grafica del sito - cielo azzurro a nuvolette, aura di luce attorno ad una colomba a sinistra della testata, silhouette di una famigliola sulla destra - è dozzinale. Mentre lo spot per la televisione è un capolavoro kitsch: vi si susseguono, mentre una voce femminile canta l'Ave Maria di Schubert, uno scenario da paese in guerra, l'immagine di un’anziana signora borghese dignitosamente seduta nel suo salotto, un simpatico nonnino intento a prepararsi il caffè, un giovane "bello e dannato" che percorre una banchina battuta dai flutti, una bella ragazza relativamente vestita a pancia in sotto su un letto (incongruo tocco sexy, che, oltre a sancire l'onnipresente uso commerciale del corpo femminile, ha il merito di tener viva l'attenzione).
L'unica caratteristica comune a tutti i personaggi è la solitudine; in effetti, se proprio si volesse estrarre senso da questa pubblicità, parrebbe che a dedicarsi al rosario (digitale o "analogico") siano persone infelici cui non resti molto altro nella vita se non dedicarsi ad biascicare una sequenza di preghiere preconfezionate, che la ripetizione meccanica tende a svuotare di significato. Da questo punto di vista sono rivelatrici, quasi un lapsus, le parole dell'arcivescovo monsignor Tonucci, intervistato da Jenner Meletti di La Repubblica: "Io penso che tecnologie come questa, almeno in questa fase, aiutino le persone che sono sole - per giorni, per mesi o anche per pochi minuti - a sentirsi meno sole."
Nel tentativo improbo di intercettare consenso in una società quasi completamente secolarizzata e tendenzialmente consapevole, la Chiesa Cattolica ha accettato la difficile sfida di far proprie le dinamiche tipiche dei mezzi di comunicazione di massa: va interpretato in questa ottica il lancio di un canale tematico su YouTube in tre lingue, dedicato alle parole del Papa. Come anche la realizzazione del "rosario elettronico", un piccolo riproduttore MP3 a forma di uovo in due versioni, base (prex) e accessoriata (lux - luce in latino, o lusso?) - dotato, quest'ultimo, di cuffiette "per un ascolto più discreto". E' la risposta clericale all'iPod. Mentre Apple propone al resto del mondo un apparecchio per riprodurre musica, filmati o podcast, la chiesa mette in campo uno strumento per assistere il fedele nelle preghiere strutturate e formalizzate che essa prescrive.
L'ovetto santificante, che ha venduto 40.000 unità praticamente senza pubblicità, è disponibile in diverse versioni: standard (giallo, bianco e celeste con i segni della delegazione pontificia di Loreto), ovvero personalizzato per altri gruppi di fedeli, quali "papa-boys", Croce Rossa, Carabinieri, Cavalieri di Malta e Aviazione. Tutto questo per dire che, se Gesù tornasse sulla terra, dopo aver parlato di pace e di uguaglianza (temi sempre attuali) non dovrebbe dimenticare di andare al tempio a tirare qualche altra legnata ai sempre attivissimi mercanti che, ancor oggi, si nascondono dietro le sue colonne.
E' evidente, quanto inevitabile, che la Chiesa, nel suo tentativo di penetrare in territori tipici della modernità, e pertanto lontani dalla sua cultura, si muova in modo goffo ed inefficace: realizzare un applicativo da far girare sull'iPhone per recitare il rosario è una contraddizione in termini troppo difficile da riconciliare. Da una parte la modernità, con la sua nevrosi e le sue infinite possibilità di comunicare, condividere, creare; dall'altra, la rigidità di una monarchia che si è ben poco evoluta dal Medioevo a oggi. In effetti, i dati statistici sugli accessi a Prex Community ad un mese dal suo lancio non sembrano particolarmente incoraggianti: secondo quanto dichiara la EDE, se si eccettua un picco, il sito sta ricevendo circa 400 visitatori unici al giorno, un risultato che potrebbe essere raggiunto da un blog, il quale però, a differenza di Prex Communion, viene di solito ideato, gestito e manutenuto da una sola persona (o da una piccola redazione informale di amici) e senza metterci sopra nemmeno un euro.
Prex Communion consente di creare gruppi di preghiera con obiettivi specifici; in questo esso è simile a Facebook: chi vuole promuovere una certa causa non deve fare altro che costituire un "gruppo" cui altri possono aderire. Strumento potentissimo, benché l'obiettivo del gruppo possa essere modificato impunemente dal creatore (o amministratore) anche dopo aver raccolto le adesioni (a chiunque potrebbe capitare di diventare membro di un gruppo contro il riscaldamento globale, salvo poi trovarsi iscritto ad un gruppo che predica la pedofilia!).
In ogni caso, chi è dotato di fede robusta crede che la preghiera possa costituire uno strumento potente per risolvere i suoi guai e quelli degli altri. In mondo di spirito e di astrazione, come quello in cui ci stiamo muovendo, appare incongruente ricorrere a ragionamenti quantitativi: eppure, sembra che quanto più sono numerosi i fedeli che chiedono un dato intervento al Signore, tanto più le orecchie del Vecchio Barbuto si facciano ricettive. Se questa è la "logica", ed è difficile accettarla, ben venga Prex Community: anzi, verrebbe quasi da dire che, a costo di qualche compromesso di coscienza, dovremmo - tutti - registrarci. Chissà che, biascicando tutti assieme una preghierina online, non si riesca a far sparire gli incubi della fame, della guerra e del riscaldamento globale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
È bufera sulle carceri italiane. Numerose e drammatiche le denuncie che negli ultimi tempi hanno evidenziato i grandi mali della detenzione. Il sovraffollamento, i diritti negati, anche quelli di cura, le condizioni disumane e i pestaggi. Le morti nere. Quelle rimaste senza causa e colpevoli. L’ultimo a morire venerdi scorso è Uzoma Emeka, testimone chiave del pestaggio avvenuto nel carcere di Teramo il 22 settembre. Era un nigeriano di 32 anni arrestato per spaccio di stupefacenti, ed è soprattutto "il negro che ha visto tutto", come dissero i secondini autori del famigerato pestaggio.
Era testimone di quell’orribile racconto di pestaggi e violenze riservate ai detenuti, che abbiamo ascoltato dalla registrazione resa nota dal quotidiano La Repubblica. Un’interrogazione parlamentare del PD chiede al guardasigilli Alfano di aprire un’indagine su questa morte oscura. Si chiede che l’autopsia sia filmata e che non si ripeta la sepoltura veloce riservata poco più di un mese fa al giovane Cucchi, riesumato per scoprire tutta la verità di una morte trovata sempre in carcere. Sempre per mano della polizia.
"Il negro" è morto per cause naturali. Si dice per arresto cardio-circolatorio. Era già svenuto qualche tempo fa sotto la doccia. Ammesso che l’autopsia lo confermi, va precisato che nessuna assistenza sanitaria, né trasferimento in struttura ospedaliera, gli era stato ovviamente riservato. Emeka era stato lasciato lì, testimone di un fatto tanto delicato e difficile, in mezzo a ogni possibile pressione, minaccia, violenta solitudine. Senza il diritto di alcuna protezione o trattamento speciale. Privato del diritto di cura e in totale insicurezza come non si conviene per un testimone di un fatto tanto scomodo.
Come lui, molti altri. Una prassi diffusa, a quanto pare, non proteggere quanti possono smascherare l’abuso extra legem che vige come regola nel carcere. Ricordiamo il tunisino Ama Tbini, che denunciò al procuratore John Woodcoock le violenze subite dai poliziotti e dagli operatori sanitari del carcere di Potenza nel 2000. Fu lasciato in mezzo agli aguzzini che aveva denunciato e fu ritrovato poco dopo nella sua cella, impiccato. Le morti dei detenuti avvenute per abbandono terapeutico o per fatti di violenza rimasti senza colpevoli o per storie di testimoni scomodi come Emeka sono tante e disegnano il quadro di un’emergenza. I morti dietro le sbarre nel 2009 arrivano a 172. Una matematica degli orrori e un record nella storia della Repubblica.
I numeri delle associazioni che lavorano per i diritti dei detenuti, “Antigone” e “Ristretti Orizzonti”, da tempo ormai denunciano l’ingiustizia che ribolle dietro le sbarre. La popolazione carceraria sfiora i 70mila detenuti, il 65% dei quali per pene inferiori ai 3 anni, per i quali bisognerebbe attuare, come previsto, pene alternative. Suicidi e morti in aumento. Ammalati lasciati morire, giovani pestati. Testimoni che non parlano o che non devono.
Quello del caso Cucchi, anche lui con la sfortuna di essere un clandestino di pelle nera, per ora ha visto essergli riservato un programma di protezione speciale che lo sottraesse al pericolo di rimanere a Regina Coeli o di finire in un altro carcere. Troppo sconvolgente il caso di Stefano e troppo straziante per le famiglie italiane la pubblicazione di quelle foto per poter permettere che un altro testimone tacesse per infarto o per una corda al collo.
Proprio il caso Cucchi ha mostrato all’opinione pubblica, senza perifrasi e senza sconti, l’intreccio diabolico che ha visto uniti medici, giudici e poliziotti in un’alleanza di morte, di abusi e omissioni che hanno ucciso. In quel modo lì, che abbiamo visto su quel lettino d’obitorio. E forse proprio quella storia, aldilà del suo epilogo giudiziario, ha restituito all’attenzione delle Istituzioni dignità alla vita dei prigionieri. La pena, spiegava Cesare Beccaria, deve avere due funzioni: quella di garantire sicurezza alla società e quella, non meno importante, di correggere il detenuto.
Cosa è successo a distanza di secoli, alla nostra ormai matura democrazia costituzionale, se questo non interessa più nessuno? Se diventa normale morire in abbandono terapeutico, senza protezione quando si diventa testimoni di abusi e illegalità come il giovane Emeka, quando non è previsto riscatto o recupero, ma pochi metri quadri da dividere stipati come bestiame, in pasto di quei secondini kapo che non diventeranno forse mai imputati? Da questi soprattutto dovrebbe essere difesa la nostra società. Da quelli che hanno spaccato la schiena di Stefano Cucchi, da quelli che non l’hanno curato e da quelli che hanno chiuso gli occhi mentre un giovane di 32 anni moriva. Di infarto o di paura. O di scomoda testimonianza.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Si ostinano a chiamarlo “allarme maltempo” ma da che mondo è mondo, tra dicembre e febbraio, si consuma con freddo, ghiaccio e neve quella stagione dai più conosciuta come inverno. Certo, il riscaldamento globale aveva provato a farci credere che di tetti e strade imbiancate ne avremmo visti sempre di meno ma, puntuale come non mai, anche quest’anno è arrivata la neve: delizia dei bambini, terrore dei trasporti. Per tutto il week-end il Paese è stato messo in ginocchio dalle copiose nevicate e dal gelo. Per aerei, autostrade e treni la situazione é stata critica, ma se per i primi due sono state trovate soluzioni d’emergenza, per Trenitalia l’effetto domino causato dai numerosi ritardi è stato letteralmente devastante.
Centinaia i treni soppressi, migliaia i minuti di ritardo accumulati da quella Tav che avrebbe dovuto, secondo gli spot a raffica che ci sorbiamo in tv, collegare Milano a Roma in sole 3 ore ma che lo scorso sabato ha costretto chi voleva viaggiare da Bologna a Firenze (117 kilometri di distanza) ad impiegare ben 24 ore per arrivare a destinazione. Com’é stato possibile che una nevicata, per quanto copiosa, paralizzasse un’intera rete ferroviaria? Secondo l’amministratore delegato di Rfi, Michele Elia, i ritardi sono stati causati dallo zelo sulla sicurezza: “Far circolare un treno a 300 all’ora sotto una bufera di neve può presentare dei rischi se si forma del ghiaccio sui binari e diminuisce l’attrito per i freni”. Ma va?
Pare quindi che i dirigenti Fs, nonostante le numerose avvisaglie fornite dai meteorologi, fossero del tutto impreparati a dover affrontare la stagione invernale: i binari dell’alta velocità non sono uniformemente dotati di sistemi di riscaldamento e perciò l’unico modo di evitare pericolosi deragliamenti era, secondo i piani alti di piazza della Croce Rossa, quello di far rallentare l’andatura dei Freccia Rossa. Secondo molti osservatori, la mossa è stata un terribile scivolone per Trenitalia, ma per l’amministratore delegato Mauro Moretti “siamo l’unico paese in Europa a non aver bloccato pezzi interi di rete”.
Per quanto le condizioni atmosferiche siano state e continuino ad essere poco clementi, la commissione Trasporti della Camera ha ritenuto doveroso sentire i vertici di Fs su quello che verrà ricordato come il venerdì nero delle ferrovie e da Torino il terribile pm Raffaele Guariniello - lo stesso che ha istruito i processi contro ThyssenKrupp e Juventus - fa sapere che è già stato aperto un fascicolo conoscitivo proprio sulle manchevolezze del nuovo servizio ad alta velocità. Nel mirino del magistrato, oltre ai ritardi, ci sono anche le condizioni precarie dei viaggiatori costretti in vagoni sovraffollati a causa dell’overbooking, affamati perché le carrozze ristorante non sono rifornite o infreddoliti perché il sistema di condizionamento dell’aria è in sostanza una ciofeca. E se nella lista mancano i disservizi delle toilettes è solo perché, probabilmente, anche l’inflessibile Guariniello ha rinunciato a sperare che siano pulite o semplicemente fruibili.
Insomma, le ferrovie fanno acqua da tutte le parti e in molti si domandano perplessi com’é possibile che per 15 centimetri di neve le reti ferroviarie del Paese vadano in tilt. Marco Ponti, docente di economia applicata al Politecnico di Milano, ha spiegato a La Repubblica che il problema non sono tanto le infrastrutture (di per loro già più che pessime) ma piuttosto la gestione di queste ultime e così dicendo ha invocato la presenza di un’authority indipendente che sanzioni i comportamenti non virtuosi. Peccato che non esista autorità che tenga di fronte ad un gestore unico, monopolista per quanto riguarda le rotaie ed in più suffragato dalla mano generosa degli aiuti pubblici. Perché se in Italia esistesse concorrenza a livello ferroviario, siamo più che certi che nessuno sano di mente sceglierebbe consapevolmente un servizio che definire inqualificabile è poco.
Alla stazione centrale di Milano una torma di passeggeri inferociti per i ritardi, il freddo (a Milano la massima della giornata è stata -4) e soprattutto per la mancanza di spiegazioni ha letteralmente preso d’assalto la sala d’aspetto vip del “Club Freccia Rossa”. In un revival dell’assalto dei forni di manzoniana memoria, i passeggeri colpiti dai ritardi e semi assiderati sono stati costretti a forzare l’ingresso della confortevole sala d’attesa in quanto, nella rinnovata stazione del capoluogo lombardo, non sono presenti altre stanze dedicate all’accoglienza dei passeggeri: il restyling, concentrato soprattutto sui numerosi negozi, non ha infatti contemplato le sale d’attesa.
Ma per Mauro Moretti la soluzione ai disagi è semplice: munirsi di maglioni, coperte e panini. E pazienza se il biglietti per usufruire di un servizio praticamente inesistente sono stati pagati a peso d’oro; i dirigenti Fs - si sa - viaggiano solo in aereo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giovanni Cecini
di Giovanni Cecini
La tradizione e i media ci ricordano che nel periodo di Natale sia le persone che i dolci sono più buoni. Su questi ultimi è difficile pronunciarsi, visto che è difficile mangiare torroni e panettoni ad agosto e, anche se qualcuno lo facesse, di sicuro essendo avanzi di mesi prima, sarebbero con probabilità meno saporiti del loro periodo canonico. Per quanto riguarda le persone, un cappello rosso con pon pon bianco in testa o un addobbo in casa non rendono la società più cordiale o gioviale, se è vero che lo shopping - e il relativo traffico prefestivo - trasformano gli agguerriti consumatori di pacchetti e cotechini nevrotici, irascibili e stressati dalla bella figura, che è d’obbligo fare con i regali per suoceri, mogli, mariti, figli e amici.
In tutto ciò è evidente che quanto di più vero e di intimo possa esprimere la nascita di Gesù Cristo, in un Paese che si dichiara per la stragrande maggioranza credente, rappresenta un accessorio secondario, ormai asfissiato da festoni, ghirlande, nastri e lucette colorate. Forse, mosso da questo gran chiasso da circo equestre, il papa Benedetto XVI ha trovato opportuno domenica scorsa durante l’Angelus esprimere l’intendimento di andare a ricercare quei valori, più autentici e ricchi di significato, che il Natale rappresenta per i cristiani.
L’elogio maggiore è stato per il presepio, che oltre ad essere preparato, dovrebbe essere vissuto. L’esame dei componenti di questo quadretto dovrebbe essere - secondo il Pontefice - un ammaestramento per la collettività: dalla famiglia sfortunata ma gioiosa di Giuseppe e Maria, al calore dei poveri pastori, fino a tutti coloro che nel nulla si commuovono dinnanzi al dono della vita, seppur nata all’interno di una stalla, tra bestie maleodoranti, freddo pungente e condizioni pessime di ordine igienico-sanitario, come diremmo oggi.
Tuttavia a ben vedere lo spirito del Natale, se così va inteso, è lontano anni luce con quello che ci circonda e con il clima proposto dalla società. Il presepio (o presepe) è relegato a una mera comparsa, se si considera che per cultura é un elemento identitario della tradizione italiana. Eppure San Francesco, non a caso patrono d’Italia, inventore e primo realizzatore di presepi, è di gran lunga surclassato da quel remoto San Nicola, che definiamo di Bari, ma originario della costa anatolica, che con varie trasformazioni paganeggianti è divenuto Santa Claus ovvero Babbo Natale.
Interessante per esempio il comportamento degli esponenti leghisti, che un giorno vorrebbero utilizzare il tricolore al bagno, l’altro giorno inserirvi il simbolo di Cristo per antonomasia e il giorno successivo attaccano la Chiesa e i suoi vescovi, perché la loro fratellanza universale cozza con l’idea civile e razziale della celtica Padania.
Questa breve carrellata, accompagnata all’ormai irrinunciabile albero addobbato con palle e festoni, dimostra che la cultura italiana è in prima linea nel difendere i crocifissi, ma risulta distratta nell’affermare l’origine stessa del Natale, ossia la nascita di un bambino, che secondo la fede cristiana, sarebbe il figlio di Dio e il Salvatore dell’umanità.
Ciò è documentato dalla frequente e dimostrata circostanza in cui, se in una casa manca l’albero di Natale, chi vi capita in visita si chiede: «Ma l’albero?». Inutile dire che pochi o nessuno si stupiscono dell’assenza del presepio, al di fuori di chiese o mostre tipiche.
Questo ragionamento quindi ci dimostra, se ne servisse la riprova, che ormai anche in Italia da diversi anni ci si è incanalati in una ipocrita ambientazione del Natale, senza mangiatoia e senza il suo messaggio di pace. Tutto si risolve in abbuffate, regali, giocate a carte, bambini sorridenti perché vedono nel 25 dicembre un doppione del proprio compleanno, forse anche più ricco di quello originale, e tante coreografie teatrali e posticce.
L’industria del Natale tira molto bene; ne sono la conferma la crescita vertiginosa di pubblicità di profumi, di offerte telefoniche, di alimenti ipocalorici, che oltre a far male alla salute, portano all’indomani dell’Epifania in grossi complessi di colpa o alla sfrenata ricerca di soluzioni adeguate al responso della severa bilancia.
In tutto ciò cosa resta del Natale, durante il quale tutti sarebbero più buoni? Se consideriamo le reazioni di una folla inferocita, pronta al linciaggio contro un folle, responsabile di un’azione sciagurata, nei pressi di Piazza Duomo a Milano, allora la risposta ce l’abbiamo da soli. Per quanto Massimo Tartaglia possa aver commesso un’azione criminale, tra l’altro approvata in modo neppure troppo celato da larga parte dell’opinione pubblica italiana, non sembra proprio lo spirito giusto proporlo per la forca in piazza, come invece molti hanno dimostrato pochi attimi dopo l’inconsulto gesto contro Silvio Berlusconi.
Questi episodi sono la prova di un clima in cui gli stessi che si ergono a pompieri per spegnere gli ardori degli esagitati e propongono di abbassare i toni, sono anche temerari incendiari pronti a colpire l’avversario, se trovato in malaugurato fallo.
Speriamo che sotto l’albero, se il presepe è poco gradito (e non solo a Casa Cupiello), un giorno si possa trovare almeno la consolazione di trovare una coerenza, che molto spesso si è andata perdendo. Finché si è disposti a guardare solo la pagliuzza del vicino, senza notare il trave nel proprio di occhio, forse non c’è Natale che tenga: Gesù Cristo non troverà neppure una stalla ad accoglierlo e il monito teologico di Benedetto XVI sarebbe pieno di un significato non solo religioso.
